Corso Italia 7
Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi
L’insperata fama dello scrittore Dante Arfelli
Nella primavera del 1949 vinse il Premio Venezia, antesignano del Campiello con il romanzo d'esordio I superflui, scritto di getto e in soli venti giorni. Uscito nel pieno della stagione neorealista, se ne distacca in modo netto. Pubblicato da Rizzoli e riedito da Vallecchi, così da toccare le centomila copie, venne tradotto in vari paesi con riscontri di vendite e critica. Solo negli USA l'edizione economica raggiunse le ottocentomila copie. È stato il sentimento di esclusione e inettitudine, di vuoto esistenziale refrattario a valori salvifici e fervori populisti, a procurargli i più convinti riconoscimenti della critica straniera

Ho incontrato Dante Arfelli nel 1993, solo due anni prima della sua scomparsa, mentre era ricoverato nella clinica di Ravenna presso cui, grazie al vitalizio della legge Bacchelli, aveva trovato asilo. Portavo con me alcuni pacchetti di sigarette e qualche stecca di cioccolato al latte, dopo aver saputo che erano per lui preziose risorse di cui temeva di restare sprovvisto. Mi trovai di fronte un vecchio curvo e scarno, malfermo sulle gambe, che mi fissava con un’espressione smarrita. Ai malanni che lo affliggevano da tempo si era aggiunta una grave forma di morbo di Parkinson e la sigaretta gli tremava fra le dita, minacciando di continuo di bruciargli gli abiti lisi. Ricordo che dopo un’iniziale ritrosia si mostrò contento di vedersi riconosciuta un’identità di scrittore che lui stesso sembrava aver a lungo dimenticato, e di ripercorrere insieme le tappe di un percorso cominciato con lo straordinario successo raggiunto oltre quarant’anni prima.
«Alto e robusto, con le spalle larghe e un fisico da atleta, ha l’aspetto di uno sportivo più che di uno scrittore; serio e taciturno, di poche parole anche al momento della consegna del premio e della successiva festa in suo onore, nelle fastose sale del Casinò del Lido». Così le cronache ritraevano Dante Arfelli quando nella primavera del 1949 vinceva il Premio Venezia, antesignano del Campiello con il suo romanzo d’esordio, I superflui, scritto di getto e in soli venti giorni nell’estate precedente, il cui valore era attestato in primisdalla prestigiosa giuria che lo aveva scelto, composta tra gli altri da Pietro Pancrazi, Aldo Palazzeschi, Giani Stuparich.
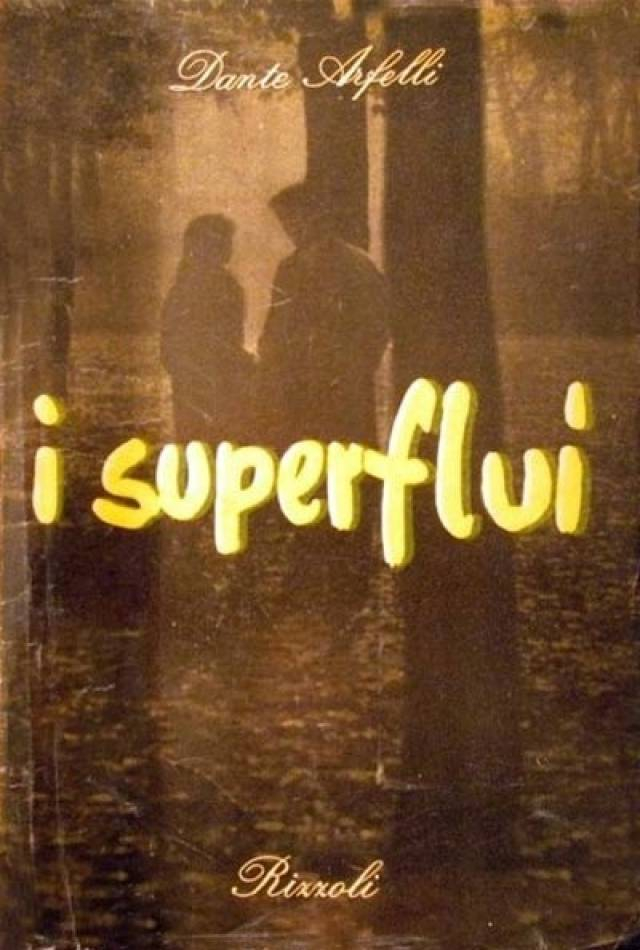
Insieme all’assegno di mezzo milione, cifra enorme per lui, di condizioni economiche tanto modeste da doversi far prestare abito e scarpe per la cerimonia, Arfelli otteneva una fama insperata. Poteva staccarsi dalla quieta provincia romagnola (era nato a Bertinoro, nel 1921), per affacciarsi negli ambienti culturali romani, incontrarvi vecchie conoscenze come Marino Moretti e Federico Fellini, che era stato suo compagno di liceo a Rimini, e farsi nuovi amici.
I superflui, pubblicato da Rizzoli e poi riedito da Vallecchi così da toccare le centomila copie, veniva tradotto in vari paesi con riscontri di vendite e critica, specie in Francia e negli Stati Uniti, che possono vantare pochi scrittori italiani di sempre. Solo negli USA l’edizione economica per l’editore Scribner’s, lo stesso di Hemingway, raggiunse le ottocentomila copie.
Uscito nel pieno della stagione neorealista, il romanzo se ne distacca in modo netto. Luca, il protagonista, è un provinciale che nell’immediato dopoguerra va a cercare fortuna in una Roma sottomessa all’arbitrio dei potenti, che possono essere di volta in volta politici, monsignori e commendatori. Ha con sé due lettere di raccomandazione, ottenute dal parroco e dal segretario del Partito Socialista del suo paese, che spera possano aprirgli qualche porta nella capitale. Ne ricaverà però solo vaghe promesse che resteranno senza esito. L’unica persona che gli offre un ambiguo e mai del tutto accettato amore è Lidia, una giovane prostituta con cui condivide un misero alloggio e le illusorie ambizioni di riscatto, ma più ancora un incolmabile vuoto esistenziale, un sentimento di esclusione e di impotenza.
Intorno ai due giovani si muove una piccola cerchia di personaggi: una vecchia affittacamere vedova di un ferroviere; l’amico Luigi, utopista anarchico, che morirà nello scontro a fuoco coi carabinieri durante l’attentato a una caserma; Alberto, studente di legge arrivista e senza scrupoli, che introduce Luca in un salotto nobiliare frequentato da faccendieri dediti all’arricchimento selvaggio nella neonata Repubblica. E pare di avvertire lo sguardo amaro e disilluso dell’autore in certe sue uscite, come quando dice a Luca: «Ognuno di noi è una merce, agli occhi dell’altro è valutato in un modo o nell’altro, guai a lasciar capire che ci si porta dietro una merce da poco». E poi ancora: «Non aver paura, questa città è una gran mucca e c’è latte per tutti».
La trama poggia su pochi perni essenziali. Luca trova un lavoro temporaneo come impiegato addetto alla paga di un cantiere, mentre Lidia riesce a farsi mantenere per un periodo da un cliente facoltoso, e intanto coltiva il sogno di raggiungere una zia in Argentina. Per questo studia spagnolo, risparmia, ma nelle due occasioni in cui la meta sembra vicina, una volta si ammala, un’altra deve pagare sottobanco una grossa somma a due agenti della buon costume per evitare l’arresto. I due finiranno per imboccare una china inevitabile, col licenziamento di Luca, la morte della vecchia affittacamere, l’aborto di Lidia che infine contrae una grave malattia, sino a un finale che sembra in linea con la più classica tradizione del melodramma, ma ne resta ben distante nei toni e nel registro narrativo. L’intera vicenda è condotta con uno stile asciutto e scarno, e risulta dominata da un pessimismo e un fatalismo che vanno molto oltre lo scenario di difficoltà dettato dalla disoccupazione e dalla ingiustizia sociale che, pure, colpiscono i protagonisti. Anche nei provvisori e precari momenti di illusione non si intravede per loro alcuna reale possibilità di cambiamento, di sovvertire la propria condizione di nullatenenti, uno stato di indigenza che, più e prima che socioeconomico, è di natura esistenziale.
«Il destino siamo noi» afferma a un certo momento il protagonista. «Per questo non possiamo scamparlo. Quando uno è fatto in quel modo farà sempre in quel modo». E lo stesso Luca si vede spesso dal di fuori, si sente svuotato come i propri abiti che vede penzolare dalla sedia. Il senso di estraneità e l’angoscia che lo accompagnano evocano certi tratti dell’Esistenzialismo, che proprio in quegli anni, con la prima traduzione italiana dell’antologia di Jaspers, si affacciava nel nostro paese. Fanno pensare a Lo straniero di Camus, che esce nel 1942 e vede la prima edizione italiana nel 1947, o a La nausea di Sartre, che Arfelli mi disse di aver letto in gioventù.
Proprio questo sentimento di esclusione e inettitudine, di vuoto esistenziale refrattario a valori salvifici e fervori populisti, procurava a I superflui i più convinti riconoscimenti da parte della critica straniera. Antony West, sul «New Yorker», parlò di «generazione bruciata»; i critici francesi di una «rinascenza letteraria italiana», di fronte a una vicenda caratterizzata dall’alienazione dei due personaggi, respinti da un mondo che avvertono corrotto e ostile.
Anche per questo ero molto curioso di sapere da Arfelli come avesse maturato quella storia e soprattutto la scrittura essenziale con cui è condotta, che mai ricorre a lirismi o enfasi retorica, e si carica di pathos e di pietas quanto più appare distaccato lo sguardo del narratore. La risposta fu che alle spalle del romanzo c’era la lettura delle commedie di Arthur Miller e di Tennessee Williams, e che agli autori italiani aveva sempre preferito quelli americani, in particolare Jack London, Ernest Hemingway e Scott Fitzgerald, William Faulkner e Erskine Caldwell. E questo mi suggerisce un parallelo con altri scrittori coevi che hanno condiviso un analogo tipo di formazione, e che a loro volta sono stati in qualche modo degli outsider, appartati e poco affini ai canoni del periodo. Penso per esempio a Silvio D’Arzo, nato nel 1920, un anno prima di Arfelli, che aveva come modelli dichiarati Robert L. Stevenson, Joseph Conrad ed Henry James, e poi a Beppe Fenoglio, che è del 1922, affascinato dal mondo anglosassone e formatosi a sua volta con la lettura di Henry James, lo stesso Conrad e David H. Lawrence.
Con La quinta generazione, pubblicato nel 1951 da Rizzoli, l’autore romagnolo conferma i tratti dominanti del libro di esordio. Il romanzo è incentrato sull’educazione sentimentale di due sbandati adolescenti, seguiti dagli anni del fascismo al dopoguerra nello scenario della cittadina adriatica di Cesenatico, dove Arfelli abitava allora. Forse meno unitario e incisivo de I superflui, ne riprende però l’efficace cifra stilistica e, con una scrittura parimenti asciutta e disadorna, rappresenta la sfiducia e il vuoto interiore dei giovani protagonisti, la loro indifferenza ai fatti storici.
«In fondo, siamo tutti uguali: nessuno ci aiuta e abbiamo bisogno di avere fortuna», dice uno di loro. E ancora «È che non riesce più a importarmene di niente. Questo è il male».
Il fallimento esistenziale, il non senso delle cose, vengono esplicitati in una sorta di consuntivo, riferito alla sorte di un soldato: «Era venuto dall’America, aveva varcato l’oceano ed era stato allevato e nutrito per più di vent’anni perché andasse a morire in una trattoria di Bari, ucciso da un negro che pure aveva varcato l’oceano e si era arruolato per incontrare l’altro una sera e sparargli».
Pubblicato in Francia, negli Stati Uniti e anche in Svezia, La quinta generazione non raggiunge il successo del romanzo d’esordio, mentre sempre più evidente risulta il divario nella valutazione de I superflui: da un lato il grande consenso della critica straniera, dall’altro la tiepida reazione di quella italiana che, pure, nel 1954 dedicava ad Arfelli una pagina speciale de «La Fiera Letteraria» di Vincenzo Cardarelli. Tuttavia, la sua fama era ancora viva quando uscì bruscamente dalla scena. Cominciava così un silenzio che venne definito emblematico da chi ne attribuiva la responsabilità alla società letteraria nostrana, che non gli avrebbe perdonato il troppo rapido successo e la non omologazione con i modelli imperanti.
È vero che Arfelli si sentiva poco apprezzato e compreso, e che ne soffriva. Ne troviamo un palese riscontro nel passo di una lettera indirizzata all’amico Mario Picchi nel 1952, in cui scrive: «La vita letteraria mi ha molto scoraggiato. Io mi sento tagliato fuori, forse perché sto in un paese e cerco di seccare gli altri il meno possibile? […] So solo che spesso si fa il silenzio intorno a me e questo mi irrita e mi scoraggia. Le sole buone notizie vengono dall’estero: dall’America, dalla Francia».
Eppure non è su questo terreno che va cercata la principale ragione della sua improvvisa sparizione, come mi confermò lo stesso Arfelli con voce malferma. Verso la metà degli anni Cinquanta era caduto in preda a una grave forma di nevrosi depressiva che gli avrebbe piegato il corpo e offuscato la mente, e che solo negli ultimi tempi gli aveva concesso la parziale tregua in cui si svolse anche il nostro incontro.
Oltre quarant’anni dura dunque il silenzio di Dante Arfelli, interrotto di tanto in tanto solo grazie alle iniziative di alcuni fedeli estimatori. Nel 1975 esce presso le Edizioni del Girasole di Ravenna Quando c’era la pineta, una raccolta dei racconti scritti negli anni della sua breve fortuna, e nel maggio 1988 si svolgono a Cesenatico due giornate di studi a lui dedicate, con le testimonianze dei suoi più cari amici, fra cui Gino Montesanto, Enrico Panunzio, Miche Prisco, oltre a un ben articolato intervento di Clelia Martignoni, e nel 1990 ne escono gli Atti per lo stesso editore.
Solo negli anni Novanta le edizioni della Marsilio riportano alla luce I superflui (1994) e La quinta generazione (1995), subito dopo la pubblicazione nel 1993, sempre da Marsilio, di Ahimè, povero me, una sorta di informale diario, introdotto da una nota dell’amico Walter Della Monica, in cui Arfelli ripercorre il suo interminabile viaggio dentro la solitudine e le fobie, le vertigini, le «voci» della malattia mentale che per tutto quel tempo l’aveva inghiottito. Vi si trovano frammenti in forma poetica spesso dominati da un tono amaro e desolato, come questo:
Guardo la finestra della stanza
le tendine verdi
alla veneziana sono
abbassate fin quasi
al davanzale grigio.
Fra le tendine
e il davanzale c’è uno
spiraglio di luce
che proviene da fuori,
dove c’è la vita.
Ma non mancano i ricordi di un tempo più felice e dell’ambiente letterario in cui era cresciuto, con gli esemplari ritratti di Marino Moretti, Federico Fellini e di altri amici. Le notazioni, ora ordinate ora frammentarie, valgono a restituirci lo sguardo lacerante che l’autore, dal suo stato di forzato esilio, rivolgeva su di sé, sul proprio passato, sul presente captato attraverso le pagine dei giornali e gli echi della televisione. Quindi anche sulla mutazione antropologica dell’Italia, divenuta un paese assai peggiore di quello conosciuto in gioventù, teatro di quella «congiura di demoni» di cui parlava Pier Paolo Pasolini, mai citato, ma che pure si coglie come presenza aleggiante fra le pagine del libro. E ci sono poi alcuni racconti rimasti fuori dalla raccolta del 1975.
Dopo questa temporanea ricomparsa, il nome di Arfelli ricade nel dimenticatoio, e anche i suoi romanzi tornano a essere in breve tempo introvabili. Trascorre quasi un altro trentennio, e siamo così al 5 marzo del 2021, l’anno in corso, in cui cadeva il centenario della sua nascita, che a causa delle costrizioni imposti da questo travagliato periodo non ha potuto essere accompagnato dalle iniziative pubbliche che avrebbe ben meritato.
Una piccola buona notizia è giunta proprio a ridosso dell’anniversario, e riguarda la riedizione de I superflui, con prefazione di Gabriele Sabatini, da parte della rfb, (readerforblind), già rivista letteraria, che proprio con questo libro inaugura anche l’attività di Casa editrice. L’auspicio è che si tratti del primo segnale di una più ampia ripresa in considerazione di Dante Arfelli, al quale andrebbe assegnato, una volta per tutte, il rilevante ruolo che merita fra gli autori della sua generazione. Mi riferisco al valore dei due romanzi e a quello non inferiore dei racconti compresi nella già citata raccolta Quando c’era la pineta, che attestano la sua felicissima vena anche nella misura più breve. Sono storie di vita quotidiana, talvolta anche in chiave autobiografica, che a partire da un impianto realista danno vita a situazioni sorprendenti e spesso inquietanti. Due autisti in fuga dopo che col loro camion hanno investito e ucciso una bambina. Una donna che insieme al figlio va a vendere i poveri abiti usati del marito contadino, morto da poco. La macabra scoperta che lo stesso autore ricorda di aver fatto al termine di una passeggiata nella sua amata pineta. Alla consueta asciuttezza dello stile si accompagna una tensione latente, un senso di minaccia che incombe sui personaggi ed esplode con improvvisi e inattesi lampi di espressionismo che tolgono il fiato.
«Poiché posso raccontare io esisto, e poiché posso raccontare la vita, la sopporto» scrive Peter Bichsel. Lessi questa frase ad Arfelli durante il nostro incontro, e insieme ne ricordammo un’altra scritta da lui nel lontano 1951: «Se non fosse un vizio o una malattia, smetterei anche di scrivere. Si starebbe così bene a fare altre cose. Chi ci inchioda a un tavolino? Ma questo bisogno di gridare, parlare, vendicarsi della realtà ricostruendola a proprio modo, di veder chiaro nella propria esistenza, sono troppo forti».
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui


Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.