L’agroburocrazia e i suoi complici
Una storia penosa che non può essere ignorata. Tutto ebbe inizio nel 1998, ma in alcuni ambienti una importante iniziativa di Roberto Borroni non era stata vista di buon occhio. Coloro che avrebbero potuto cambiare volto all’agricoltura italiana sono stati considerati presenza scomoda e imbarazzante

È una storia penosa quella che sto per raccontarvi. Ma è bene ricordarla perché spiega la difficoltà a liberare l’agricoltura italiana dell’immane burocrazia che la sovrasta. Tutto comincia nel 1998, agli sgoccioli del primo governo Prodi, quando il sottosegretario per le Politiche agricole, Roberto Borroni, costituisce un Gruppo di studio per il riordino e la semplificazione della legislazione agricola. A formarlo è un pool di docenti universitari di diritto agrario che esprimono i molteplici orientamenti ideali e culturali presenti nella comunità scientifica: Francesco Adornato, Ferdinando Albisinni, Ettore Casadei, Luigi Costato, Alberto Germanò, Carlo Alberto Graziani e Antonio Jannarelli.
Dagli anni Settanta mancava in Italia un intervento legislativo di ampio respiro in agricoltura, mentre dalla Francia arrivavano da tempo e periodicamente le novità delle leggi di orientamento capaci di anticipare le prospettive che successivamente venivano accolte dalla PAC. Da noi l’agricoltura era, invece, rigidamente inquadrata in uno schema giuridico di tipo produttivistico, avente al centro la coltivazione e non già il rapporto con il mercato, la comunità e il territorio in cui gli agricoltori si trovavano ad operare.
La Commissione Borroni avvia così una riflessione a tutto campo su questi ritardi. E vien fuori un’elaborazione che ha come elemento unificante quello di un’agricoltura imprenditorialmente organizzata e posta al centro di relazioni sistemiche sul territorio. Dopo aver proposto norme di riordino e revisione delle figure soggettive individuali e collettive, il progetto messo a punto dagli studiosi disegna un sistema di regole che sconfina in aree non considerate agricole in base alla visione tradizionale ma ritenute essenziali per modernizzare il settore primario: mercato, concorrenza, gestione del territorio, conservazione dell’integrità dei fondi rustici, plurifunzionalità dell’azienda agricola e multiattività dell’imprenditore agricolo, pluralismo delle strutture agricole, insediamento dei giovani, qualità dei prodotti legata al territorio, strumenti finanziari, distretti, contratti territoriali, contratti locali di sviluppo rurale, istruzione, formazione e concertazione.
Ma questa elaborazione di prim’ordine resterà rinchiusa in qualche faldone del ministero delle Politiche agricole. E nei decreti che saranno approvati successivamente – annoterà Costato – di quel lavoro si scorgeranno “solo labili tracce spesso così manipolate da potersi considerare addirittura stravolte”.
Commentando il lavoro svolto dal Gruppo di studio, Germanò osserverà che l’orientamento agricolo delineato non solo avrebbe potuto costituire, per lo Stato e per le Regioni, il “documento di strategia agricola dell’immediato futuro”, ma anche “l’anticipazione, per la sua dimensione sistemica, del testo unico delle norme agrarie che il governo era chiamato a realizzare” in virtù di una precisa delega del Parlamento.
Cosa avviene, dunque, mentre al governo Prodi subentrano i due governi D’Alema e il governo Amato – tutti di centrosinistra – da frenare quello straordinario tentativo di riforma della nostra legislazione agricola messo in atto da un illuminato gruppo di scienziati del diritto agrario? Essi consegnano al nuovo ministro delle Politiche agricole, Paolo De Castro, un progetto di 24 articoli e poi una stesura più ampia e approfondita, con relazione introduttiva e 59 articoli, corredati, all’occorrenza, di note esplicative.
De Castro non ne fa nulla perché nel frattempo il governo D’Alema si dimette. E quando al dicastero agricolo è chiamato a succedergli il verde Alfonso Pecoraro Scanio, il tema affrontato dal Gruppo di studio viene preso in considerazione ma senza più coinvolgere i giuristi e – cosa ancora più grave – senza mai nominarli durante l’iter di approvazione della legge delega e dei decreti di orientamento. È come se bisognasse nascondere che all’origine dei provvedimenti vi fosse la comunità scientifica.
Negli ambienti delle organizzazioni agricole, l’iniziativa di Borroni non era stata vista di buon occhio perché queste si rifiutano di prendere atto di quanto già avviene da tempo nelle campagne: l’espandersi di nuove attività e di nuovi soggetti che sono espressione della ruralità contemporanea e che però le vecchie regole ne impediscono il riconoscimento come proprie dell’agricoltura. Non vogliono saperne della scelta europea di considerare attività agricola anche la semplice cura della terra e non necessariamente la coltivazione di piante e l’allevamento di animali. Una visione innovativa che apre ad un’agricoltura di servizi a tutto tondo e sovverte gli antichi rapporti tra città e campagne.
E così il ministro verde consegna di fatto l’istruttoria e il presidio del percorso di approvazione dei provvedimenti all’opacità di una collaborazione informale, discreta e, tutto sommato, determinante tra i funzionari ministeriali e i cosiddetti “esperti” delle organizzazioni agricole.
È in un siffatto quadro di avvilente mortificazione delle istituzioni che va collocata la scelta di tenere lontana la comunità scientifica, forse considerata una presenza scomoda e imbarazzante. Una presenza che, tuttavia, non si può eludere quando non si sa come affrontare i problemi. E così, nel giro di qualche anno, appena emergono le carenze dei decreti di orientamento, il governo Berlusconi chiede una nuova delega al Parlamento per intervenire con ulteriori norme. A quel punto, il ministro delle Politiche agricole, Gianni Alemanno, insedia un gruppo di giuristi – questa volta solo tre componenti sono docenti universitari, mentre gli altri sono esperti indicati dalle organizzazioni – che consegna nel giro di qualche mese uno schema di decreto legislativo quasi completo. Ma il rituale si ripete: ottenuta la prima bozza, di nuovo si lascia a casa la comunità scientifica e si avvia la collaborazione tra funzionari ministeriali ed esperti delle organizzazioni agricole da cui nascono disposizioni normative che non conservano, però, l’ordine sistematico e la coerenza intrinseca che lo schema proposto aveva.
Sembrava, ad esempio, che l’Italia avesse scelto di allinearsi all’Europa nel cancellare definitivamente la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale per dare centralità, nei sistemi di sostegno, al progetto imprenditoriale e alle sue ricadute a vantaggio della collettività. Sembrava sufficiente che l’imprenditore agricolo, per aver titolo a un incentivo pubblico, dimostrasse di possedere capacità professionale e di rispettare le normative igienico-sanitarie, quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle per le buone pratiche agricole. Invece, si coglie l’occasione della delega per far tornare in vita la vecchia qualifica, denominandola ora “imprenditore agricolo professionale”.
Si torna così a marginalizzare l’agricoltura part time e tutte quelle nuove attività agricole che si giovano delle competenze e delle sensibilità di derivazione urbana. E nessuno s’accorge che nella nuova norma s’introduce un’ulteriore discriminazione dall’acre sapore castale: per calcolare se il reddito ricavato dall’attività agricola è superiore al 50 per cento di quello complessivo, si escludono dal computo le indennità percepite per l’espletamento di cariche pubbliche oppure in enti operanti nel settore agricolo.
Un modo obliquo per consentire a imprenditori agricoli eletti nelle istituzioni o nominati nei consigli di amministrazione delle società, di giovarsi dei privilegi accordati ai “professionali” – a partire dalle norme urbanistiche – anche nei periodi in cui essisono lontani dalle loro aziende.
La diffidenza nei confronti della comunità scientifica non finisce qui. Alemanno incarica, infatti, l’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) a redigere un progetto di codice agricolo per raccogliere in un unico testo la vasta produzione normativa tutt’ora in vigore. L’IDAIC coinvolge una settantina di giuristi tra docenti e cultori di diritto agrario e presenta un testo di 776 articoli distribuiti in 11 Libri. Ma lo schema di provvedimento non viene mai formalmente presentato in Consiglio dei ministri.
Anche con il secondo governo Prodi e il ritorno di De Castro al dicastero agricolo, il codice rimane nel cassetto e viene pubblicato solo nella collana di studi dell’IDAIC. È il ministro leghista Luca Zaia a reiterare l’incarico all’Istituto di predisporre un nuovo progetto. Ma stavolta, per facilitarne il percorso, l’opera di semplificazione della materia dell’agricoltura viene delimitata ai più rilevanti dei suoi oggetti: le figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività connesse, le società agricole, i contratti agrari, la successione, la prelazione, la valorizzazione dello spazio rurale e altri temi ritenuti essenziali.
I provvedimenti vengono predisposti con solerzia dagli studiosi e sono approvati dal Consiglio dei ministri nel 2009 e trasmessi per i pareri alle istituzioni competenti. A quel punto le Commissioni parlamentari invitano le forze sociali a esprimere le loro valutazioni. Le istituzioni e le organizzazioni coinvolte presentano le proprie osservazioni e l’IDAIC provvede a riformulare i testi per accoglierle nei dispositivi. Ma verso i provvedimenti monta l’avversione delle organizzazioni. La scusa è che la loro formulazione è avvenuta senza la “previa concertazione”. E dopo diversi incontri per accogliere le osservazioni delle organizzazioni agricole e tentare di accontentarle in qualche modo, il nuovo ministro Mario Catania chiede alle Commissioni parlamentari di sospendere l’esame dei provvedimenti in attesa di avviare una nuova richiesta di delega e ripartire ancora una volta daccapo. Eppure il codice non è altro che un riordino di norme già esistenti senza produrne necessariamente di nuove. Ma semplificare è togliere potere e status a coloro che vivono di ingorghi. È per questo che essi resistono ad ogni riforma che possa metterli in discussione.
Quella che ho raccontato è una vicenda sgradevole. Ho ritenuto di farlo perché è emblematica dei danni enormi che possono produrre certe rappresentanze, le quali, avendo smarrito il senso della propria missione, ritengono di dover tutelare le loro prerogative anche a costo di sacrificare gli interessi collettivi.
L’immagine di apertura è una foto di Luigi Caricato che riprende un particolare di un’opera di autore ignoto esposta in uno dei castelli del Salento.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

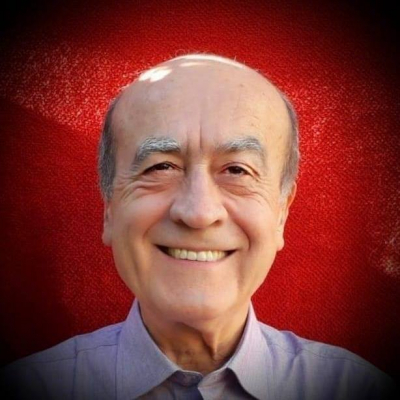
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.