Una nuova ruralità
Costruire l’immagine di un’agricoltura “tappabuchi” o “crocerossina” di un capitalismo non più in grado di generare sviluppo e occupazione è un’operazione che non fa cogliere l’innovazione sociale che si è realizzata. La Fondazione Censis sta finalmente prestando attenzione alle modificazioni che hanno investito l’agricoltura italiana

Ruralità, oggi.
Ritorno alla terra o correttivo di civiltà?
Con quarant’anni di ritardo dall’emergere del fenomeno della rurbanizzazione che vede le città e le campagne accorciare progressivamente le rispettive distanze le une dalle altre, fino a confondersi, e l’esodo urbano subentrare a quello rurale, il più noto centro italiano di ricerche in campo socio-economico, la Fondazione Censis, sta finalmente prestando attenzione alle modificazioni che hanno investito l’agricoltura italiana. Ultimamente questa agenzia ha elaborato alcuni studi sul settore primario – commissionati da organizzazioni agricole – da cui emerge il nuovo volto delle campagne. E come spesso accade quando i risultati delle ricerche sociali e le strategie di comunicazione si alimentano a vicenda, le interpretazioni dei fenomeni rischiano di perdere la loro dimensione reale per trasformarsi in miti, metafore, nuovi paradigmi, stereotipi.
In una ricerca del 2012, il Censis scopre che un italiano su due coltiva un orto e che tra i giovani la quota è persino più elevata (51,2 %). Se si considera più genericamente il giardinaggio, la percentuale degli italiani che vi si dedica sale al 70 %.
Il significato della diffusa presenza di orti in mezzo alle fabbriche e ai grandi casermoni abitativi delle periferie metropolitane era già stato colto da Franco Ferrarotti in uno studio pubblicato nel 1994 (con P. Crespi, La parola operaia, Scuola G. Reiss Romoli, L’Aquila). Commentando le storie di vita operaia raccolte nel volume, il decano della sociologia italiana aveva rilevato che “i gruppi operai italiani sono fortemente radicati nella realtà contadina e, anzi, trovano puntualmente nelle specifiche situazioni locali e nell’ambito familiare quella base d’identità e quella sorta di ammortizzatore segreto delle crisi sociali ad ampio raggio, che in altri contesti sociali e storici hanno dato luogo ai noti fenomeni di sradicamento e di alienazione operaia”.
In base alle interviste effettuate dai ricercatori del Censis, noi italiani siamo diventati d’un tratto orgogliosi dei nostri prodotti agroalimentari d’eccellenza: il 27,2 % dei nostri connazionali (il 41 % dei giovani) considera il nostro cibo un valore che viene subito dopo il patrimonio artistico e culturale e i pregi che nel mondo ci riconoscono da sempre (creatività, socievolezza, ecc.). L’82 % degli italiani ritiene che l’agricoltura rappresenti un volano di crescita del paese. Addirittura, di fronte al desiderio espresso da un proprio figlio o nipote di lavorare in agricoltura, ben l’85% degli italiani consiglierebbe loro di seguire la propria volontà, a fronte di appena un 15% che invece lo sconsiglierebbe.
Una siffatta attenzione verso l’agricoltura deriverebbe, secondo il Censis, dagli effetti della grande crisi economica, la quale avrebbe, da una parte, indotto un atteggiamento più disincantato sulla capacità dell’industria tecnologica e del terziario avanzato di guidare la crescita e, dall’altro, stimolato le stesse campagne a ripensarsi e a vivere un nuovo protagonismo, come dimostrerebbe il fenomeno dell’agricoltura sociale.
Tale interpretazione non appare congrua a cogliere il significato più profondo del fenomeno “rurbano” che si è sviluppato – come si è detto – a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e che Corrado Barberis e l’Insor – Istituto nazionale di sociologia rurale da lui diretto – immediatamente colsero, analizzando attentamente i dati censuari, sia generali che agricoli, e aggregando le informazioni per l’insieme dei comuni rurali e per il complesso dei centri urbani, in modo distinto.
L’apprezzamento che i cittadini manifestano nei confronti dell’agricoltura non va inteso come una sorta di ripiego verso un settore che, evidenziando segnali di maggiore tenuta occupazionale rispetto ad altri, avrebbe più possibilità di offrire lavoro soprattutto ai giovani. Si tratta, invece, del compimento di un lungo processo di ricomposizione, sul piano socio-economico e culturale, che vede le campagne italiane diventare finalmente parte integrante dell’economia e della società.
Costruire l’immagine di un’agricoltura “tappabuchi” o “crocerossina” di un capitalismo non più in grado di generare sviluppo e occupazione – l’immagine, cioè, di un settore che accoglie coloro che non trovano impiego altrove e si adattano al lavoro agricolo nonostante i redditi relativamente bassi e le difficoltà ad assumere i rischi d’impresa – è un’operazione che non fa cogliere l’innovazione sociale che si è realizzata.
Appare più un tentativo di creare un nuovo stereotipo ancora più opprimente di quelli che in passato hanno gravato sull’agricoltura. Un pregiudizio che si collega – dilatandolo – a quello prefigurato da alcuni opinion leader quando hanno incominciato a ritagliare e delimitare nelle campagne un’area di piccole e piccolissime aziende da tenere separate dal resto dell’economia e della società, salvaguardarle dalle contaminazioni culturali di altri soggetti e di altri settori, eventualmente proteggerle con politiche ad hoc. Un’area dorata a cui aggrapparsi per affrontare meglio i rischi della contemporaneità.
Se dovesse passare questa idea, ci troveremmo dinanzi ad un nuovo e più subdolo tentativo di dominazione culturale delle campagne da parte di gruppi che, a discapito dell’interesse generale, fanno prevalere poderosi interessi particolaristici.
I caratteri della nuova ruralità
La chiave di lettura che dovremmo utilizzare per comprendere la mutata reputazione di cui gode l’agricoltura rispetto al passato è, a mio avviso, un’altra: dopo un lungo processo di progressiva sovrapposizione socio-economica e culturale, città e campagna si presentano come un continuum non più distinguibile in modo netto e, nel contempo, le componenti rurali della società civile esprimono modelli innovativi per l’insieme delle comunità senza più rappresentare un mondo a parte non solo nella realtà, ma anche nell’immaginario collettivo. In sostanza acquista credito nell’opinione pubblica l’idea che l’innovazione sociale prodottasi nelle campagne negli ultimi 30-35 anni può costituire un importante correttivo di civiltà.
Cosa avviene in concreto in questo lungo periodo? Nel corso degli anni Settanta s’interrompe l’esodo dalle campagne che si era avviato negli anni Cinquanta e si registra una lenta inversione di tendenza. All’esodo rurale incomincia a subentrare l’esodo urbano. La fuga dalle città e il ripopolamento delle campagne interessano tutte le regioni dell’Italia centro-settentrionale , ossia le più ricche, mentre al Sud solo la Puglia e la Sardegna si inseriscono nella corrente.
Si tratta di una nuova ruralità come aspetto del benessere contemporaneo che vede emergere nuove forme spontanee di sviluppo locale nelle campagne e un passaggio graduale da una condizione di inerzia ad una di iniziativa. I figli e i nipoti di chi era fuggito dalle campagne alla ricerca di condizioni socio-economiche più appaganti scoprono che, a ricreare alcuni aspetti della società tradizionale fuori del suo contesto di miseria, le cose potrebbero andare meglio. Si affermano così stili di vita che integrano gli aspetti irrinunciabili della condizione urbana, dalla fruizione più facile delle diverse forme della conoscenza e della cultura all’adozione di modelli di abitabilità rispettosi della privacy, con le opportunità che solo i territori rurali sono in grado di offrire, dalla partecipazione alle fitte reti di legami sociali al piacere di coltivare un orto e di preparare una pietanza tipica.
Nello stesso tempo, l’alto costo degli affitti urbani spinge le giovani coppie a evadere dalla città dove però si continua a lavorare e una relativa abbondanza di impieghi urbani consente una sempre più frequente occupazione non agricola all’interno delle aree verdi.
Nel Mezzogiorno il fenomeno si presenta con caratteristiche proprie e coerenti con una tradizione rurale che pone al centro le città e gli insediamenti abitativi, come parti integranti e non separate della campagna. La nascita dei poli industriali e i fenomeni di ampliamento delle grandi e medie città meridionali creano lavoro nelle fabbriche, nell’edilizia e nel pubblico impiego con inquadramenti bassi, ma favoriscono il miglioramento della piccola azienda coltivatrice. Invece, nelle aree più emarginate delle campagne meridionali, le forme di part-time che si diffondono non trovano la complementarietà nel mercato del lavoro ma in regimi assistenzialistici che sommano varie provvidenze, dalle indennità di disoccupazione alle pensioni di invalidità. E difficilmente le rimesse degli emigrati o i risparmi investiti al rientro trovano impiego nell’azienda agricola.
Dagli studi dell’Insor viene fuori che, complessivamente, alle aree rurali spetta non meno del 35 per cento dell’intero prodotto interno lordo italiano, ma almeno il 95 per cento di questo 35 per cento ha origini non agricole. L’agricoltura rimane una componente dell’economia rurale anche se non si identifica più con essa. E non solo perché molte iniziative industriali e nei servizi nascono per opera di imprenditori già agricoli, ma perché il mito dell’agricoltura di un tempo finisce per essere il collante dei nuovi arrivati che si dedicano sempre più all’ospitalità turistica, alla vendita dei prodotti agricoli locali, alle attività educative, terapeutiche e riabilitative mediante l’utilizzo di risorse agricole e all’artigianato rurale.
Gli agricoltori che alla fine degli anni Cinquanta e negli anni Sessanta si erano adattati al modello industrialista, innescano ora un processo di recupero dal punto di vista culturale, delle antiche modalità di economia contadina, attraverso però le istanze modernizzatrici. Si continua a denunciare la miseria e la sussistenza del vecchio sistema, privilegiando tuttavia la capacità di integrarsi nel nuovo contesto e rispondere ai nuovi bisogni che la società esprime. L’ondata modernizzatrice dei decenni precedenti aveva generato fenomeni di spaesamento che si intrecciavano alla necessità di ridefinire i contorni identitari. Gli anni Settanta e Ottanta costituiscono così il tempo dell’assestamento in nuovi e più adeguati equilibri che giungeranno a compimento nei decenni successivi.
Questa nuova ruralità si manifesta mediante la rigenerazione di un’agricoltura relazionale e di territorio, la fioritura di una leva di neo-agricoltori il cui obiettivo non è produrre cibo in sé, ma produrlo in un certo modo per ottenere beni pubblici capaci di soddisfare bisogni collettivi. Si opera una sorta di capovolgimento dei mezzi in fini, per ristabilire un ordine di priorità che si era smarrito con la modernizzazione agricola: è l’uomo coi suoi bisogni e le sue aspirazioni più profonde e sono i beni pubblici, relazionali e ambientali, i fini dell’attività economica, mentre il processo produttivo, il prodotto e la sua scambiabilità sono soltanto i mezzi per conseguirli. In tale solco, già alla fine degli anni Settanta s’inseriscono le iniziative pioneristiche nell’ambito dell’agricoltura sociale.
Il fenomeno rurbano vede anche l’entrata in scena di una particolare tipologia di consumatore che vuol essere partecipe del progetto con cui si crea il prodotto agricolo e non semplicemente spettatore passivo nel teatro del marketing; vuole, in sostanza, essere un co-protagonista che interagisce con il produttore, diventando un consumATTORE. Egli non si limita ad informarsi sui diversi prodotti, guardare l’etichetta e acquistare passivamente il bene in qualunque punto vendita. Vuole invece partecipare attivamente al rapporto di scambio dopo essersi aggregato, anche informalmente, in gruppi di acquisto o in comunità di cibo, le cui esperienze pioneristiche nascono tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta.
Queste novità sono sottovalutate per un lungo periodo dalle organizzazioni di rappresentanza che non colgono la portata dirompente di tali cambiamenti e non sanno intercettare i nuovi soggetti e accompagnare lo sviluppo di una molteplicità di relazioni e integrazioni che si stabiliscono nei territori. E non vengono percepite nemmeno dall’opinione pubblica, se non sporadicamente, quando alcuni scandali alimentari fanno suonare il campanello d’allarme senza spingere verso una più diffusa consapevolezza dell’esigenza di nuovi equilibri.
Negli ambienti scientifici, la nuova realtà delle campagne incomincia ad essere analizzata negli ultimi quindici anni quando si sviluppano i filoni di studi sull’economia civile, riprendendo la grande tradizione della scuola napoletana che nei primi decenni del Settecento era una delle più vitali e importanti d’Europa; si accumulano le banche dati contenenti informazioni sulla felicità e soddisfazione di vita dichiarata dalle persone di diverse aree del mondo; si definiscono i “beni relazionali” e s’incominciano a identificare i nuovi modelli di welfare nelle aree rurali.
È in questo fervore di grande rinnovamento negli studi socio-economici e di costruzione delle prime reti di pratiche innovative che si diffondono le agricolture civili e si analizzano in modo più approfondito i nuovi rapporti urbano/rurale.
La funzione demistificante della crisi
Non è stata, dunque, la grande crisi internazionale esplosa dal 2008 in poi a produrre la nuova ruralità. Essa ha messo a nudo la fragilità di un modello di sviluppo le cui faglie vanno fatte risalire ad alcuni decenni fa. La prima mossa che ha innescato la crisi attuale accade, infatti, agli inizi degli anni Settanta, quando Nixon decide di sganciare il dollaro da ogni parità fissa con l’oro. La seconda viene effettuata alla fine dello stesso decennio quando gli Stati Uniti decidono un forte rialzo dei tassi d’interesse. E la terza è attuata agli inizi degli anni Ottanta con la decisione di Reagan e Thatcher di liberare la circolazione dei capitali.
Crollando l’impalcatura che regolava il sistema finanziario internazionale e che faticosamente si era costruito nell’immediato dopoguerra, viene meno l’equilibrio su cui si reggeva la convivenza tra il capitalismo e la democrazia. Ma questo lungo processo di incubazione della crisi ha prodotto, nel suo svolgersi, la devastazione ulteriore dell’ambiente, l’accentuazione degli squilibri distributivi di risorse e di potere connessi alla globalizzazione, l’erosione dei beni relazionali che si era già manifestata con l’avvento della società dei consumi.
Il buon funzionamento del mercato e delle istituzioni poggia, infatti, su alcune risorse indispensabili, che sono la fiducia, la collaborazione, la responsabilità, lo spirito di coesione, la solidarietà. Si tratta del capitale sociale che si costituisce sulla base di un impulso valoriale non egoistico.
L’economia finanziaria che si è imposta nella società postfordista ha prodotto un’accentuazione della spersonalizzazione dei rapporti economici come portato di un’idea riduttiva e avvilente della persona umana. Ha fatto ulteriore breccia l’opinione che vuole gli uomini mossi unicamente da autointeresse miope e non anche dalla simpatia verso gli altri e dall’etica della responsabilità verso ogni ente. Si è voluto negare che gli esseri umani prima di cercare interessi e guadagni, sono cercatori di stima, di approvazione sociale, di relazioni.
È prevalsa la concezione secondo la quale hanno dignità di esistere solo le imprese proiettate esclusivamente alla massimizzazione del profitto e sono, comunque, destinate a soccombere nella concorrenza con le prime, tutte quelle che si pongono anche altri obiettivi.
Si è imposto il luogo comune che il benessere delle persone è solo materiale e che quello spirituale è qualcosa di cui si può benissimo fare a meno.
Si è consolidata l’idea che la speculazione finanziaria sulle derrate alimentari sia una componente indispensabile per la vitalità degli scambi anche quando induce più insicurezza alimentare per una parte della popolazione mondiale.
La grande crisi sta svolgendo una salutare funzione demistificante e fa lentamente emergere la fallacia di questi convincimenti. Tornano così ad essere ritenuti importanti i beni relazionali e il capitale sociale nei processi di sviluppo, cioè quei valori su cui la nuova ruralità ha inteso rifondare la funzione dell’agricoltura come generatrice di comunità.
Ed è precisamente a questo punto che le antiche separatezze, considerate fino a poco tempo fa irriducibili e necessarie, e i vari pregiudizi, che dipingevano le campagne come entità restie all’innovazione, appaiono ormai definitivamente crollati.
L’agricoltura non è dunque il ripiego di un capitalismo in crisi: una sorta di accampamento di fortuna in attesa di tornare quanto prima ad abitare nelle case dissestate. Così fu intesa nell’America di Roosevelt immediatamente dopo la grande crisi del ’29, all’insegna della parola d’ordine Back to the land. Ma ben presto a quei programmi infuocati subentrarono nuovi e più intensi processi d’industrializzazione e urbanizzazione.
L’agricoltura è al culmine di un lungo e profondo processo di riassestamento socio-economico che è seguito alla grande trasformazione del paese avvenuta tra gli anni Cinquanta e Sessanta da un’Italia prevalentemente rurale ad un’Italia prevalentemente industriale. Nel nuovo volto dei territori italiani non più rurali e non più urbani emergono in forme nuove legami comunitari, economie civili, agricolture di servizi, reti di mutuo aiuto e di reciprocità sorte spontaneamente nell’humus di tradizioni e culture rurali millenarie, le cui forme concrete costituivano sistemi di welfare ante litteram.
L’attenzione che l’opinione pubblica sta rivolgendo all’agricoltura andrebbe, pertanto, esaminata guardando ad un arco temporale di lungo periodo per coglierne fino in fondo le cause e i caratteri. E andrebbe vista come un’occasione per ripensare complessivamente lo sviluppo. Si tratta, infatti, di recuperare un’idea che da Carlo Cattaneo a Francesco Saverio Nitti, da Arrigo Serpieri a Manlio Rossi-Doria, da Giorgio Ceriani-Sebregondi a Danilo Dolci, ha sempre ispirato i grandi progetti territoriali, come la bonifica integrale e la riforma agraria: la profonda convinzione che la coesione sociale è la premessa, non un effetto dello sviluppo. Un’idea che nel tempo si è smarrita avendo preferito inseguire il mito di uno sviluppo purchessia, a cui sarebbe dovuta succedere una coesione mai concretizzatasi.
I nuovi indirizzi di politica agraria che si annunciano nei provvedimenti del Governo e delle Regioni non colgono questa domanda profonda di innovazione nelle politiche di sviluppo. Si limitano a inseguire con slogan e promesse la comunicazione di letture sociologiche parziali e distorte di dati statistici e sondaggi d’opinione che non colgono affatto, nella nuova ruralità, un potenziale correttivo di civiltà. S’introducono, pertanto, misure spot non verificabili in termini di fattibilità e di risultati concreti. Le quali hanno senza dubbio un impatto nell’opinione pubblica, perché incrociano una domanda effettiva di cambiamento, ma non avendo alcuna incidenza nelle culture dello sviluppo che permeano la pubblica amministrazione e il mondo della rappresentanza, ben presto si riveleranno un boomerang.
Quando gli slogan restano parole vuote prive di esecuzione e di verifica, il capitale di credibilità si prosciuga inesorabilmente e si ritorcono contro il loro brillante proponente. Anche in tempi di deflazione, l’inflazione degli slogan in politica diventa un nemico da combattere, per il bene stesso della politica. E gli slogan andrebbero sostituiti con riflessioni serie e accurate in uno sforzo culturale collettivo per cambiare mentalità e abitudini consolidate.
L’immagine di apertura riprende un particolare dell’illustrazione di Angelo Ruta per l’edizione di Olio Officina Food Festival 2014
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

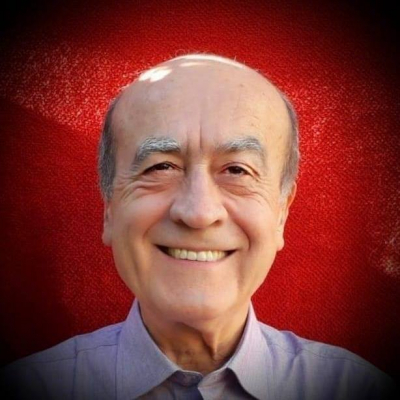
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.