C’è un dato nella spietata diagnosi della SVIMEZ che paradossalmente mi conforta: anche l’agricoltura arretra, gli investimenti delle imprese agricole calano del 38%. E così questa volta non c’è proprio il minimo spazio per analisi superficiali e sbagliate come quelle che alludono a nuove arcadie e a nuovi mondi autarchici. Perfino il Censis si era lasciato abbagliare dall’idea che mettendo insieme un po’ di agricoltura e un po’ di turismo avremmo potuto fare a meno dell’industria, dell’innovazione tecnologica e costruirci un Sud fuori dal mondo.
Invece le cose non stanno così. L’agricoltura non è il ripiego di un capitalismo in crisi: una sorta di accampamento di fortuna in attesa di tornare quanto prima ad abitare nelle case dissestate. Così fu intesa nell’America di Roosevelt immediatamente dopo la grande crisi del ’29, all’insegna della parola d’ordine “Back to the Land”. Ma ben presto a quei programmi infuocati subentrarono nuovi e più intensi processi d’industrializzazione e urbanizzazione. E l’agricoltura è dovuta andare a rimorchio.
Oggi corriamo un rischio analogo e lo corriamo come sistema Paese e come Unione Europea. Il Mezzogiorno anticipa soltanto una tendenza che presto riguarderà l’intero vecchio continente. Negli Stati Uniti si è avviato un nuovo ciclo di sviluppo industriale fondato su internet e sulla robotica e, naturalmente, su una trasformazione totale del lavoro sia dipendente che imprenditoriale e su forme totalmente nuove dell’abitare.Il governo cinese ha varato un programma di costruzione di nuove città dove si trasferiranno entro il 2020 cento milioni di contadini che lasceranno le campagne. I nuovi centri urbani che stanno per nascere non saranno le metropoli fordiste che si sono sviluppate in Occidente tra l’Ottocento e il Novecento. Ma le città-territorio che assorbono gli antichi conflitti tra città e campagna in nuovi equilibri sociali, economici e territoriali, in nuove modalità dell’abitare, mettendo insieme tecnologie digitali, robotica, biotecnologie. Insomma, dove la crisi viene affrontata seriamente, s’investe in sviluppo e innovazione, puntando su ricerca, sperimentazione e istruzione. Si sogna e s’inventa coi piedi per terra. Non si piange e non ci si dispera. Si aguzza il cervello per trovare strade nuove, mai percorse.
In Italia pensiamo invece di affrontare le difficoltà, stando sulla difensiva. Ci riteniamo l’ombelico del mondo. Interpretiamo il made in Italy come un’arma con cui perseguire improbabili disegni neonazionalisti e, nello stesso tempo, autarchici. Molti sciamani ogni giorno riempiono le prime pagine dei giornali per dispensare a piene mani l’illusione che l’economia italiana possa riprendersi facendo leva esclusivamente sui nostri beni storico-culturali e ambientali e sulle nostre tipicità. Basterebbe – secondo questi venditori di fumo – mettere insieme questi pochi ingredienti. Niente industria e niente città. Come se l’industria fosse finita con la conclusione del ciclo fordista e la città fosse esaurita con la fine della metropoli. Tra queste lugubri voci che si levano nella foresta preannunciando imminenti catastrofi e improbabili ritorni all’eden, la maggior parte dell’imprenditoria italiana non sa come reagire ed è allo sbando.
La rivoluzione tecnologica in atto può aprire una nuova prospettiva allo sviluppo dei territori e dei mercati internazionali in cui l’agricoltura e l’agroalimentare possono diventare elementi qualificanti e partecipare attivamente, con il proprio capitale umano e sociale e in relazione con l’insieme dei sistemi produttivi locali, al salto tecnologico che si sta realizzando. Si tratta di invertire l’ordine di priorità tra sviluppo e coesione sociale, anticipando la seconda come premessa del primo per civilizzarlo.E di ridisegnare completamente il rapporto tra territori e mercati internazionali mediante politiche industriali per l’internazionalizzazione fondate sul “fare squadra” in Italia e all’estero, sulla nostra capacità – da sempre dimostrata nella nostra storia – di favorire processi di interscambio culturale prima ancora che commerciale, sulla costruzione di reti diffuse e collaborative tra pubblico e privato (a partire dai territori con più antiche tradizioni di sviluppo locale) e sul rendiconto alle comunità territoriali dei risultati conseguiti. Il campanello d’allarme suonato dalla SVIMEZ deve scuoterci ma senza farci prendere dalla disperazione.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

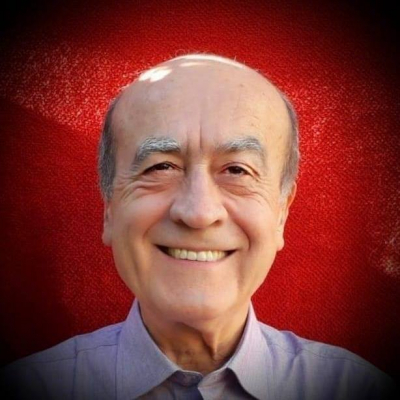
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.