Alcuni a torto ritengono che l’affermazione contenuta nell’articolo 1 della Costituzione italiana “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro” dimostri l’estraneità dell’ispirazione liberaldemocratica dalla nostra Carta fondamentale. E si arriva a dire che, con il “disconoscimento del mercato”, la nostra Costituzione, a differenza delle altre Costituzioni europee, offra l’elaborazione più avanzata per il superamento del capitalismo su basi democratiche e nel quadro di un sistema fondato sul pluralismo politico.
Non è affatto così se andiamo a rileggere attentamente gli atti dell’Assemblea costituente. A illustrare la norma fu Amintore Fanfani: “Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro – egli affermò – si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui”. Ma il relatore fu ancora più esplicito: “Niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune”. E Meuccio Ruini, presidente della “Commissione dei 75”, scrisse nella relazione che accompagnava l’intero progetto: “Lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana”.
Su tale concetto di lavoro si ritrovava completamente anche il liberale Luigi Einaudi, che lo esprimerà più tardi con queste parole rimaste celebri: “…migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi” (1960).
Che il contenuto dell’articolo 1 della Costituzione non abbia alcun significato classista è, inoltre, dimostrato dalle dichiarazioni di voto rese dai rappresentanti dei vari gruppi parlamentari. Il socialista Lelio Basso e il comunista Giorgio Amendola avevano proposto la formula: “L’Italia è una repubblica democratica dei lavoratori”. Ma nell’illustrarla, avevano escluso di volerle dare un’interpretazione classista. Il democristiano Giovanni Gronchi non ne era affatto convinto: “È illogico negare – aveva affermato a proposito della formula proposta dai comunisti e dai socialisti – che la parola ‘lavoratori’ ha, anche contro la volontà dei proponenti, un significato classista”. E tutti allora convennero sul testo proposto da Fanfani.
Anche le formulazioni del Titolo III della Costituzione riferite all’”utilità sociale” dell’iniziativa economica privata o alla “funzione sociale” della proprietà privata o ancora all’”utilità generale” come giustificazione dell’intervento dello Stato sulla proprietà privata, non vanno lette come sintomi di estraneità alla cultura liberaldemocratica. La prova sta, innanzitutto, nel fatto che tali espressioni furono approvate anche dai costituenti di fede liberale. Einaudi ottenne l’eliminazione di ogni riferimento ai “piani” o all’”abolizione del latifondo”, preferendo il termine “trasformazione” e approvò tutti gli articoli del Titolo III. Se si vanno a leggere le sue “Prediche inutili” dal titolo “Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo” (1955) si trovano questi passaggi molto significativi: “Liberale è colui che crede nel perfezionamento materiale o morale conquistato con lo sforzo volontario, col sacrificio, colla attitudine a lavorare d’accordo con gli altri”; “l’uomo liberale vuole porre norme osservando le quali risparmiatori, proprietari, imprenditori, lavoratori possano liberamente operare”. E in “Liberismo e liberalismo” (1957) precisa che tra i principali compiti dello Stato liberale vi è una lotta ai monopoli. Solo all’interno di precisi limiti, cioè delle regole dello Stato di diritto, economia di mercato e libera concorrenza possono funzionare da fattori di progresso.
È tuttavia indubbio che, come ha rilevato Guido Carli nella sua autobiografia intitolata “Cinquant’anni di vita italiana” (1996), “la parte economica della Costituzione risultò sbilanciata a favore delle due culture dominanti, cattolica e marxista”, ma nello stesso tempo, tra il 1946 e il 1947, “De Gasperi ed Einaudi avevano costruito in pochi mesi una sorta di ‘Costituzione economica’ che avevano posto però al sicuro, al di fuori della discussione in sede di Assemblea Costituente”. Si trattò di una strategia “nata e gestita tra la Banca d’Italia e il governo”, mirata alla stabilizzazione, ancorata a una visione di “Stato minimo”, e aperta alle regole e alle istituzioni monetarie internazionali.
In effetti, benché, per usare le espressioni di Carli, quel che accomunava in Assemblea costituente la concezione cattolica e la concezione marxista fosse “il disconoscimento del mercato”, l’azione di governo fu già nei primi anni della Repubblica segnata da scelte di demolizione dell’autarchia, di liberalizzazione degli scambi e infine di collocazione dell’Italia nel processo di integrazione europea.
E da ultimo Giorgio Napolitano ha ricordato nel 2011 (“La lezione di Einaudi. Un’eredità per il riformismo e per tutti”) che “con i Trattati di Roma del 1957 e la nascita del Mercato Comune, furono riconosciuti e assunti dall’Italia i fondamenti dell’economia di mercato, i principi della libera circolazione (merci, persone, servizi e capitali), le regole della concorrenza; quelle che ancor oggi vengono denunciate come omissioni o come chiusure schematiche proprie della trattazione dei ‘Rapporti economici’ nella Costituzione repubblicana, vennero superate nel crogiuolo della costruzione comunitaria e del diritto comunitario. Nell’accoglimento e nello sviluppo di quella costruzione, si riconobbe via via anche la sinistra, prima quella socialista e poi quella comunista”.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

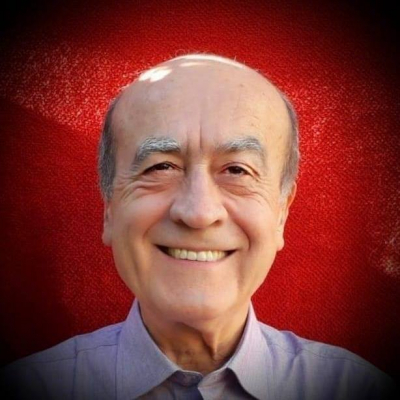
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.