Il 24 e 25 novembre del 1901 si svolge a Bologna, presso il Palazzo dei Notai, il primo congresso della Federterra. Per uno come me che da ragazzo ha incominciato l’esperienza di dirigente di un’organizzazione agricola, nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, è sempre un’emozione ricordare gli esordi dei primi sindacati. Agli inizi del Novecento sorgono, infatti, le organizzazioni di rappresentanza sociale.
E sono proprio le campagne a edificarle per prime.
La Federazione nazionale dei lavoratori della terra, denominata più brevemente “Federterra”, raggruppa fin dalle origini un numero rilevante di associati: circa 230 mila destinati a crescere fino a un milione quando il fascismo la costringerà a sciogliersi per sostituirla con una propria organizzazione di regime.
La fondazione della Federterra è un evento importante, per il carattere unitario e nazionale dell’iniziativa e per l’ampiezza del ventaglio delle figure sociali coinvolte. Il movimento che di qui prende avvio costituisce una grande peculiarità nello scenario europeo. In altri Paesi, infatti, le cose stanno diversamente.
Se si esclude l’Andalusia, che è teatro di azioni sindacali agricole significative per un lungo periodo, in nessuna delle altre regioni d’Europa si sviluppano forme di organizzazione contadina stabili e di una certa rilevanza.
Le diverse posizioni
Nel congresso di fondazione, il dibattito è alquanto animato. Il dilemma è chiaro: bisogna edificare un’organizzazione prettamente bracciantile, oppure aperta anche ai ceti intermedi: ai mezzadri, affittuari, compartecipanti, coloni e piccoli proprietari coltivatori? Socialisti riformisti, sindacalisti rivoluzionari e repubblicani si scontrano accanitamente sulla base delle rispettive impostazioni ideologiche. E alla fine prevale una soluzione unitaria ma ambigua, perché impegna la nuova organizzazione a costituire due sezioni distinte, a patto però che tutti operino per la socializzazione della terra. Una parola d’ordine in contrasto con le aspirazioni dei contadini. E i repubblicani, perciò, se ne vanno. Questa indicazione generale, ripugnante alla coscienza dei contadini, resta come una contraddizione insanabile nella Federterra, con fatica lasciata nello sfondo affinché non influisca più di tanto nell’azione pratica.
L’obiettivo della socializzazione della terra, perseguito dai socialisti e dalle frange estremistiche, non ha nulla a che vedere con la tradizione dei diritti collettivi e dei demani civici. È semplicemente la negazione del valore della proprietà privata della terra considerandolo incompatibile coi valori di una società che aspira all’eguaglianza.In base a questa visione schematicamente egualitaria che costituisce uno dei capisaldi dell’ideologia marxista, la terra è un bene che può essere solo espropriato e statalizzato. Un’indicazione in perfetto contrasto con l’aspirazione profonda dei contadini ad un legame intenso, quasi affettivo, con la terra e, dunque, con il luogo dove abitare, coltivare e costruire per poter vivere.Su questo vi è un’identità assoluta di vedute tra ceti contadini e borghesia agraria. E il tentativo di far passare la socializzazione della terra come obiettivo coerente con l’aspirazione al miglioramento delle proprie condizioni è vissuto dai contadini come una frattura profonda con il proprio quadro di valori, in cui l’individuo viene prima del collettivo e la proletarizzazione è considerata un arretramento nella scala sociale e non già un progresso.
I diritti collettivi e i domini civici, che affondano le radici in antiche consuetudini, hanno invece la funzione di assicurare per il presente e per il futuro un minimo di risorse per vivere dignitosamente quando non si possiede nulla e la gestione dei beni collettivi è inquadrata sempre in percorsi partecipativi in cui i cittadini esercitano direttamente la funzione di condomini e non tramite istituzioni statali. Le terre collettive sono una sorta di welfare ante litteram, ed è per questo motivo che l’usurpazione privatistica di questi beni, da parte dei ceti borghesi, ha suscitato sempre reazioni violente da parte dei contadini, ma tali insorgenze non sono in contraddizione con la loro aspirazione alla proprietà privata della terra di cui vivere.
La diversificata percezione culturale della proprietà della terra
La differenza di fondo tra la percezione del diritto privatistico al godimento della terra da parte dei contadini e quella dei ceti borghesi sta nelle finalità che deve avere l’uso del bene.
Nella cultura contadina, la terra è sempre stata considerata un bene particolare perché, a differenza di altri beni, essa va utilizzata e sfruttata senza mai impoverirla o “consumarla” al punto tale da pregiudicarne l’uso futuro e ripartendo sempre la fruizione dei suoi benefici tra tutti per conseguire il fine della giustizia sociale.
Non potei fare a meno di stupirmi quando sentii dire per la prima volta da un contadino che la terra in determinate condizioni “si stanca”. Ora, l’idea di stanchezza attiene ad un organismo vivente e il fatto che i contadini abbiano sempre associato questa condizione anche alla terra per rispettarne il decorso è la prova di un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo bene.
Dal versante scientifico, il primo ad affermare che il terreno agrario fosse “qualcosa di vivo” è stato Marcelin Berthelot (1827-1907), professore al Collège de France e senatore a vita. Una definizione dimostrata da numerose indagini, partite dagli studi pioneristici di Carlo Cattaneo sul suolo lombardo.
Dunque, non è solo un’intuizione della cultura contadina che la terra in determinate condizioni “si stanchi”. Né tale percezione è appannaggio esclusivo delle idee filosofiche del mondo antico. Tutti gli scienziati, ricercatori e sperimentatori, che studiano tra l’Ottocento e il Novecento le tecniche di coltivazione, conservazione e intensificazione produttiva del suolo, sono profondamente convinti che il terreno agrario fosse “qualcosa di vivo”. Ma, dal versante antropologico, il regime “inclusivo” che si ritrova in pratiche agronomiche autoriproduttive e in forme di scambio improntate a criteri di reciprocità e solidarietà, proprie della cultura contadina, è perfettamente complementare al regime “escludente” dei diritti di proprietà che opera su un altro piano.
Il possesso della terra rimanda al possesso dei corpi; e l’esclusivismo, ovvero tutte le pratiche che escludono i meccanismi di reciprocità, riflettono l’abuso individualista che si è operato a partire dalla terra e che si è consacrato nell’individualismo avulso da legami responsabili con altri esseri viventi.
La traduzione della connessione tra i due regimi, quello includente e quello escludente, in normative e riforme che possano migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali sarà il banco di prova di quelle forze politiche e sindacali che si cimenteranno nella conquista del consenso dei ceti contadini. Essa registrerà una prima sanzione legislativa soltanto nel secondo Dopoguerra con la promulgazione della Costituzione repubblicana, che saprà coniugare l’idea millenaria della terra come bene “inclusivo” coi principi moderni di libertà, equità e fraternità.
Modelli organizzativi differenti
Tornando alla Federterra, la grande contraddizione irrisolta sulla questione della terra determina nel sindacato agricolo modelli organizzativi differenti nei diversi territori a seconda della composizione sociale. Le associazioni esclusivamente bracciantili continuano ad espandersi in alcune province lombarde e venete. Mentre quelle che aggregano sia i braccianti che i coltivatori continuano a prevalere nel ravennate e nel reggiano. Nell’Italia centrale le leghe sono perlopiù mezzadrili. E infine nel Sud le leghe vengono organizzate nella forma di aggregazione territoriale di tutte le figure sociali presenti in ciascun centro urbano. E continuano a mantenere una relativa autonomia.
L’idea di organizzare insieme braccianti senza terra e ceti medi contadini deriva non solo dall’ideologia marxista, che non permette di riconoscere ai ceti rurali un ruolo autonomo nei processi di cambiamento della società, ma anche dalla più generale cultura urbana, che ha sempre identificato il contadino con gli elementi socialmente più deboli e dipendenti al fine di marcare l’inferiorità sociale del mondo rurale. Un’identificazione che i contadini vivono come un vero e proprio stigma. Ed è per questo che le forme organizzative variano a seconda del peso di tale componente sociale.
La ripartizione della proprietà terriera
Esaminando i vari censimenti, lo storico Pasquale Villani ha calcolato che negli ultimi anni dell’Ottocento tra un quinto e un quarto della popolazione rurale è costituita da piccoli proprietari coltivatori diretti, molto spesso obbligati a integrare lo scarso reddito o conducendo terreni altrui o lavorando a giornata; la categoria più numerosa è composta di mezzadri, coloni parziari, affittuari, piccoli coloni e partecipanti; infine, una percentuale tra il 30 e il 40 per cento costituisce il bracciantato avventizio ai limiti della sussistenza. Una stratificazione sociale che evidenzia accentuate diversità e aspirazioni differenziate.Altri studiosi hanno tratto da varie fonti una serie di dati per ricavare anche un quadro della ripartizione della proprietà terriera tra gli enti e tra i vari ceti sociali nei primi decenni del Novecento.
Su un totale di 26 milioni di ettari di superficie agraria, 4 milioni sono le proprietà comunali e collettive; 2 milioni quelle di altri enti statali, religiosi e civili; 3 milioni costituiscono la proprietà nobiliare, un milione quella delle banche e di società per azioni; 16 milioni di ettari appartengono a privati cittadini. Di questi 16 milioni, una metà è da attribuire alla borghesia agraria e l’altra metà ai contadini.
Cosa ci dicono questi dati? Balza subito agli occhi come i 6 milioni di ettari della proprietà contadina rappresentino la medesima entità della superficie relativa alle proprietà collettive, pubbliche, religiose e civili. Se andiamo a vedere dove queste ultime sono collocate, constateremo che sono per lo più situate in alta collina e in montagna e sono, in buona parte, costituite da incolti produttivi e da magri pascoli. Ma questo carattere non costituisce un limite perché la loro funzione essenziale è di interesse collettivo per garantire il minimo vitale per la sopravvivenza a chi non ha nulla o ha meno degli altri. Inoltre, non si può non rilevare che la proprietà contadina ha le stesse dimensioni di quella borghese e che tende a sopravanzarla. E il motivo di questa lenta ma progressiva evoluzione è che la proprietà contadina porta con sé una cultura delle relazioni tra le persone e di quelle tra gli uomini e la terra che, attraverso l’assimilazione critica del progresso tecnico, rende l’attività agricola e qualsiasi altra attività produttiva potenzialmente più efficiente. È qui il salto di qualità che, con le innovazioni tecnico-scientifiche, modifica i ruoli dei vari ceti delle campagne.
Il progresso tecnico unifica gli interessi dei contadini con quelli della borghesia terriera
Il salto di qualità è compreso bene da quei figli della borghesia terriera che non legano più il proprio status nella società all’entità della rendita fondiaria goduta (indipendentemente dalla sua provenienza pregressa), bensì all’integrazione intelligente di competenze tecniche, professionali e imprenditoriali con quella cultura materiale di cui i territori rurali e i ceti contadini sono depositari.
Sono coloro che scelgono carriere professionali che permettono di acquisire competenze tecnico-agronomiche e stabiliscono rapporti positivi coi ceti contadini. E sono anche quelli che danno vita a modelli industriali decentrati, a cui l’Italia deve la celebrità nel mondo. Lo possono fare proprio perché si espande la proprietà della terra tra quelle famiglie i cui componenti svolgono lavoro a domicilio o sono operai a mezzo tempo. Nasce in questo modo una differenziazione socio-economica che si accentuerà sempre più nel tempo nel nostro Paese tra una ruralità agricola e una ruralità non agricola: due tipi di ruralità che hanno, tuttavia, in comune la stessa base culturale, quella contadina. Soprattutto nel Mezzogiorno, i figli della borghesia terriera preferiscono scegliere, invece, carriere professionali che aprono più facilmente la strada alla vita amministrativa e politica (notai, avvocati, insegnanti, ecc.), ritenendo tale opzione la via maestra per conservare una posizione egemone. E sono quelli che considerano i ceti contadini privi di una propria cultura specifica e, dunque, come classi sociali da sfruttare e da dominare con la forza e, a volte, con la violenza. Le campagne meridionali saranno segnate enormemente da tali scelte.
Una donna al vertice del sindacato agricolo
Un tratto originale dell’agricoltura italiana è la partecipazione numerosa e combattiva delle donne alla costruzione del movimento sindacale. Pur cercando con insistenza, non ho trovato situazioni analoghe in altri Paesi.Si costituiscono leghe femminili per impedire che il successo delle lotte per la parificazione salariale tra uomini e donne si tramuti in espulsione di quest’ultime dal mercato del lavoro. Diventa, infatti, opinione diffusa che la parità salariale faccia venir meno la convenienza per le aziende alla loro assunzione. Ma si tratta di un convincimento che è frutto di un pregiudizio comune a tutti i ceti sociali. In realtà, le donne contadine sanno sobbarcarsi i lavori pesanti alla pari degli uomini, ma non lo si vuole ammettere e si tenta di ritorcere contro di loro una giusta conquista paritaria.
Non a caso nel 1905 è proprio una donna, Argentina Altobelli, ad essere eletta segretaria nazionale della Federterra, caso unico nel panorama del movimento sindacale europeo dell’epoca. Dirigerà il sindacato agricolo fino al 1922 quando i gerarchi fascisti la faranno allontanare da Bologna dove aveva sede l’organizzazione sindacale. Il suo primo impegno è rivolto alla difesa dei diritti delle mondariso e dei giornalieri avventizi, le due categorie più umili dei lavoratori della terra: “le formiche erranti più numerose – per usare una espressione a lei cara – che non hanno mai la sicurezza del pane”. Altobelli è profondamente convinta che per avanzare sulla strada delle conquiste sociali e politiche bisogna coinvolgere nelle lotte anche le donne, occupandosi prima di tutto dei loro problemi. Da qui la costante attenzione alla difesa dei diritti civili dei contadini e dei loro figli, dalla casa ai servizi sociali e all’istruzione, e l’impegno costante per ottenere già in questi anni una legge che permetta il divorzio.
Partendo dall’originario nucleo bracciantile padano, la dirigente sindacale guarda sempre con grande attenzione al Mezzogiorno, organizzando convegni sui temi dell’emigrazione interna e della colonizzazione in Sardegna e in Basilicata e iniziative di lotta contro la disoccupazione in Puglia, Calabria e Sicilia.
Nel 1908 si precipita a Messina per partecipare alle attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto e per questa sua azione ottiene una menzione speciale da parte del governo. Nel 1915 organizza nei locali di Roma della Cassa nazionale infortuni (l’attuale Inps), che lei ha contribuito a fondare, una clinica di fortuna per accogliere ed assistere una parte dei feriti nel terremoto della Marsica.
Accanto alle lotte per i miglioramenti salariali e di orario, la battaglia principale del sindacato agricolo è quella per strutturare il collocamento.
La Federterra ambisce, in sostanza, ad esercitare una sorta di monopolio nel collocamento della manodopera, obiettivo che le avrebbe consentito di detenere le chiavi del mercato del lavoro. Altobelli considera, infatti, la disciplina del collocamento l’elemento determinante della strategia sindacale, anzi “la salvaguardia di ogni conquista”.
La costruzione del sindacato agricolo è, dunque, tutt’uno con la nascita e lo sviluppo dei servizi attraverso i quali passa il flusso di manodopera e della pratica di imporre al datore di lavoro l’assunzione di coloro che man mano vengono scelti sulla base di una graduatoria precedentemente stilata.
Allo stesso modo che lo Stato classifica le terre in buone, mediocri e cattive basandosi su questa aggiudicazione per riscuotere le imposte, le leghe bracciantili attribuiscono a ogni fondo il numero delle giornate necessarie a una più o meno perfetta coltivazione. In base alle colture presenti o possibili di ogni podere si viene così a formare una sorta di catasto sindacale che stabilisce quanto reddito deve essere devoluto dai datori di lavoro sotto forma di salari e giornate aggiunte.
È da queste esperienze maturate nei primi decenni del Novecento nelle campagne italiane che nascono il principio della richiesta numerica, l’organizzazione delle strutture del collocamento e le forme di tutela previdenziale, su cui si eserciterà nel secondo Dopoguerra l’azione riformista nelle campagne.
Si tratta, in definitiva, di un sindacalismo fortemente e meticolosamente strutturato e istituzionalizzato: più dell’azione di controllare il salario, il problema fondamentale è quello di ripartire le scarse occasioni di lavoro. Il modello è per certi versi analogo a quello che in altri Paesi, e solo in parte in Italia, si sviluppa sul terreno economico del mercato dei prodotti agricoli, mediante la costruzione di un’estesa rete associativa dei produttori, volta a controllare tutto lo spazio entro cui si realizzano lo scambio delle materie prime e le fasi della trasformazione e commercializzazione degli alimenti.
Argentina Altobelli anticipa così nel primo Novecento contenuti e strumenti che riguardano non solo lo Stato sociale ma anche le condizioni civili e sociali, dalla casa al diritto di famiglia e al divorzio. Tali temi diventeranno oggetto di importanti conquiste realizzate con l’azione di massa nel secondo Dopoguerra.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

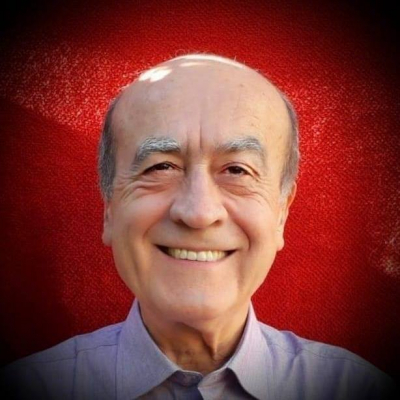
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.