La questione Federconsorzi
È una ferita ancora aperta per l’agricoltura italiana. La fonte di ogni disagio e imbarazzo,ma anche la conseguenza di una grande anomalia. Ci ha scritto un ex lavoratore e il figlio di un ex dipendente. Ora, ci domandiamo: cosa c’entrano gli ammassi di settanta anni fa con una condotta omissiva che si è consumata venticinque anni fa? Perché riesumare a tutti i costi un’organizzazione economica morta e sepolta da un quarto di secolo? Perché pagare onorari e strutture a gestioni commissariali del tutto inutili?

Prima di leggere questo lungo saggio di Alfonso Pascale e le lettere che sono giunte in Redazione, consigliamo di leggere i seguenti passaggi:
Federconsorzi, Coldiretti e M5S
LE LETTERE
Egregio Dott. Luigi Caricato
le scrivo in merito all’articolo menzionato in oggetto, portando a sua conoscenza che l emendamento presentato dal M5S in merito alla questione Federconsorzi era teso alla chiusura del contenzioso dei crediti vantati da ex dipendenti che sono in attesa di una risoluzione da circa venti anni.
Nella mia modestia faccio notare che quanto fatto dal M5S era per dare giustizia alle tante persone che hanno perso soldi e lavoro sia per quanto accaduto sia per il dispendio economico nel mantenimento del procedimento in corso di giudizio.
In risposta al Dott. Pascale, si fa rilevare che il ruolo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari nell’agricoltura italiana è stato fondamentale fino al suo fallimento. Da ciò si evidenzia il regresso della nostra agricoltura.
In Fede… Il figlio di un ex dipendente
Michelangelo Mastroianni
Egr. Direttore,
le scrivo in merito all’articolo sui 40 milioni a Federconsorzi per esprimere la mia amarezza sulla non corretta informazione, l’emendamento presentato si riferisce a crediti vantati dagli ex dipendenti che il tribunale di Roma ha riconosciuto e sancito e che da quasi trent’anni attendono la liquidazione. gli ex dipendenti federconsorzi, dopo il crac sono gli unici che hanno pagato con la perdita del posto di lavoro (circa 1500 posti di lavoro). Gradirei sempre nell’ottica di una completa e corretta informazione che si approfondisse il discorso su chi ha beneficiato del fallimento federconsorzi, le Banche sicuramente (si legga l’accordo quadro). solo i lavoratori ci hanno rimesso, lo tenga sempre ben presente ed i 40 milioni sono i soldi che servono per risarcire solo i lavoratori, tutte le altre storie non ci interessano.
Grazie e saluti
Franco Sodano
ex lavoratore federconsorzi
Grazie per le lettere che ci avete inviato.
Lascio rispondere Alfonso Pascale, che della vicenda Federconsorzi, da storico dell’agricoltura qual è, conosce tutti i dettagli.
Non è una risposta breve ma un vero e proprio saggio, pertanto utile a tutti, per comprendere una questione, quella di Federconsorzi, che molti, se non tutti, ignorano.
Luigi Caricato
All’origine della debolezza dell’agricoltura italiana
di Alfonso Pascale
Ancora oggi non si ha consapevolezza delle ragioni storiche e politiche di fondo della debolezza della nostra agricoltura. Eppure, se si analizzasse con serenità e distacco il particolare intreccio tra politica, economia e società che si è realizzato nell’Italia repubblicana, se ne potrebbero cogliere quelle che in modo più significativo e duraturo hanno influenzato la vita del paese e le sue trasformazioni. Ma bisogna liberarsi di pregiudizi e ideologismi per leggere laicamente i fatti così come sono realmente accaduti. L’idea che la Federconsorzi abbia svolto un ruolo fondamentale per l’agricoltura italiana fino al suo fallimento e che da allora siano iniziati i guai del nostro settore primario, purtroppo, è convinzione abbastanza diffusa nel paese. Si tratta però di una fake news che occorre smentire nel modo più netto. Pochi, infatti, si rendono conto delle conseguenze disastrose di questa menzogna fatta circolare ad arte. Il rovinoso crack della holding agricola è stato interamente provocato da chi ha gestito la struttura dal Dopoguerra in poi. Ad essi bisogna rivolgersi perché rendano conto dei danni provocati a famiglie, imprese e all’intera agricoltura. Negli strascichi giudiziari di questa squallida vicenda si è inserita una vertenza di lavoro degli ex dipendenti della Federconsorzi. Se ci sono dei diritti legittimi è giusto riconoscerli. Ma sarebbe più sensato non legare le aspettative dei lavoratori con i presunti crediti per la gestione degli ammassi. Questi signori che lavoravano in Federconsorzi hanno diritto ad un risarcimento? Un giudice ha accertato che chi doveva ricollocarli dopo il licenziamento non lo ha fatto e che un organo dello Stato doveva vigilare perché questo avvenisse e non ha fatto il proprio dovere? Bene. Provveda lo Stato a risarcire il danno direttamente. Si proponga un emendamento che riconosca questo diritto. Ma cosa c’entrano gli ammassi di settanta anni fa con una condotta omissiva che si è consumata venticinque anni fa? Perché riesumare a tutti i costi un’organizzazione economica morta e sepolta da un quarto di secolo? Perché pagare onorari e strutture a gestioni commissariali del tutto inutili? Ci aspetteremmo dal M5S posizioni radicali e capaci di distinguere le soluzioni volte a fare giustizia dalla perpetuazione di un sistema di potere corruttivo, arrogante e distruttivo.
Una scissione a freddo
L’evoluzione dell’agricoltura italiana è stata fortemente condizionata dalla presenza e dall’iniziativa di una organizzazione professionale potentissima: la Coldiretti. Mentre in altri grandi paesi europei, la rappresentanza degli interessi agricoli è espressa da grandi organizzazioni che raccolgono oltre l’ottanta per cento delle aziende agricole e comprendono sia quelle di piccola che quelle di medio-grande dimensione, in Italia una simile organizzazione è esistita solo per un periodo molto breve che va dal 1920 al 1944, compreso quindi l’arco di tempo in cui la struttura di rappresentanza della nostra agricoltura venne assorbita nel regime corporativo fascista.
Molti ignorano che la Coldiretti nacque a seguito di una scissione che si consumò nella Federazione italiana degli agricoltori (Fida). Una scissione a freddo, cioè condotta con cinismo e determinazione senza espletare alcun tentativo per ricercare percorsi alternativi. È importante ricordare questo passaggio della vita delle nostre campagne perché ci fa comprendere meglio l’origine delle condizioni di debolezza del tessuto agricolo nazionale e le responsabilità storiche e politiche dei protagonisti.
Alla fine di luglio del 1943, la Confederazione fascista degli agricoltori era stata commissariata dal governo presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio. Un governo transitorio, costituito a seguito della caduta del fascismo. Alla guida della Confederazione erano state designate persone che, per i loro requisiti e i loro trascorsi politici, potevano garantire il trapasso al regime democratico, rassicurando i partiti antifascisti. La scelta era, infatti, caduta sul trentenne Filippo Visconti di Modrone, esponente di quei ceti agrari lombardi che avevano da tempo manifestato una crescente insofferenza nei confronti della politica autarchica e dirigistica del regime fascista. Visconti di Modrone era stato affiancato dai democristiani Pietro Germani e Paolo Bonomi, dal liberale Alberto Donini e da Carlo Petrocchi, di idee socialiste in giovane età e tra i maggiori esperti di problemi idraulici e di bonifica durante il Ventennio.
Bonomi, futuro presidente della Coldiretti, era stato nominato dal governo commissario della Federazione dei coltivatori diretti, che costituiva un’articolazione della Confederazione fascista degli agricoltori.
Nel giro di un anno dal commissariamento della Confederazione degli agricoltori tutto era pronto per dar vita ad una nuova organizzazione, con uno statuto ispirato ai principi democratici e liberali. E così il 12 agosto 1944, sulle ceneri dell’organizzazione fascista, era sorta la Fida. Alla nascita della nuova organizzazione degli agricoltori avevano partecipato anche Bonomi e Germani. Essi non avevano mosso particolari rilievi al programma della Fida. Si erano limitati ad annunciare che avrebbero però organizzato autonomamente i piccoli proprietari e affittuari, senza spiegarne i motivi. E già il 30 ottobre dello stesso anno, d’intesa con il capo della Democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, essi perseguirono il loro proposito e fondarono la Coldiretti.
Le ragioni della rottura
Perché Bonomi e i suoi amici non erano rimasti nella Fida? Perché il loro progetto di costituire nelle campagne “una classe sana di piccoli proprietari indipendenti” non era stato presentato all’assemblea costitutiva della Fida? Perché tale obiettivo non poteva essere attuato in un’unica organizzazione di agricoltori, così come era avvenuto fino a quel momento in Italia e altrove e sarebbe continuato ad avvenire in altri paesi europei? Perché da noi si era ritenuta necessaria la scissione del mondo agricolo in due tronconi, indebolendo in modo così lampante la sua rappresentanza?
Bisogna sforzarsi di rispondere con onestà e completezza a queste domande. Solo così comprendiamo il senso del processo storico che stiamo esaminando. Non potevano essere i rispettivi obiettivi economici a ostacolare la convivenza dei contadini proprietari coi medi e grandi imprenditori agricoli nella stessa organizzazione perché i loro interessi erano a volte identici, a volte distinti, ma mai antitetici. Non a caso nel congresso costitutivo della Fida non furono presentate piattaforme alternative. E anche prima del fascismo, don Luigi Sturzo partecipava alle riunioni della Confederazione generale dell’agricoltura, in rappresentanza dei proprietari contadini, senza mai prendere in considerazione, nemmeno a livello ipotetico, l’idea di costituire un’organizzazione autonoma dagli altri agricoltori. La FNSEA in Francia, la DBV in Germania, la NFU nel Regno Unito sono organizzazioni professionali che rappresentano la quasi totalità delle aziende agricole indipendentemente dalle loro dimensioni. E questo da quando sono sorte.
C’è, dunque, qualcosa di più profondo che agisce nella decisione di separarsi.
Prevale, in primo luogo, la volontà politica di perseguire un modello di agricoltura fondato sulla famiglia rurale, intesa come unità di vita morale, religiosa ed economica. La presenza dei vertici della Chiesa cattolica nel nostro paese influenza enormemente tale scelta. Questo modello agricolo viene preferito da De Gasperi e perseguito da Bonomi perché, incrociandosi con l’introduzione del suffragio universale, amplia le possibilità di consenso per un partito che intende caratterizzarsi come partito di massa. Ed espande anche la possibilità di giocare un ruolo determinante nello scacchiere politico per un’organizzazione che tutela e promuove una categoria numericamente ampia. Se l’obiettivo è assicurarsi un maggior numero di iscritti da tramutare in voti, diventa giocoforza privilegiare la tutela degli interessi sociali delle famiglie coltivatrici, rispetto ad una linea tesa ad accrescere la produttività delle loro aziende. E l’interesse politico a perseguire la prima opzione è spinto fino ad eliminare ogni attenzione all’esigenza di integrare i due obiettivi. Il calcolo in soldoni era questo: in un’azienda agricola vale più la numerosità della famiglia contadina che la produttività dei pochi ettari che essa ha nella sua disponibilità. E dunque si sacrifichino pure le migliori condizioni sui prodotti della campagna e le innovazioni tecniche in agricoltura, mentre si privilegino gli interventi assistenziali verso ogni membro della famiglia. Garantirsi fedeltà e legami profondi da parte di un numero elevatissimo di individui fa dunque premio sull’esigenza di rafforzare il capitale umano come condizione per rafforzare il tessuto produttivo agricolo.
L’idea poi di promuovere nelle campagne un ceto di piccoli proprietari nasceva anche, nella riflessione dei cattolici democratici, da una specifica interpretazione della storia d’Europa. Secondo lo storico Pietro Scoppola, “De Gasperi era convinto che la democrazia fosse stata travolta, in Germania come in Italia, dallo scontro fra fascismo e comunismo e che la ricostruzione democratica dovesse fondarsi perciò sul superamento di quella alternativa”. Anche Konrad Adenauer ricompose sull’impresa contadina il blocco agricolo a sostegno della sua politica, ma non arrivò a separare le due categorie di agricoltori. Forse, a differenza della Germania, l’Italia poneva un problema politico in più al cattolicesimo democratico: l’anticomunismo di De Gasperi doveva fare i conti con una presenza socialista e comunista eccezionalmente diffusa nelle campagne. Una specificità tutta italiana che affondava le proprie radici in forme solidaristiche e mutualistiche addirittura medievali. E solo la promozione di una nuova classe sociale da fondare sulla proprietà diffusa della terra, cioè con un assetto strutturale agricolo ritenuto del tutto incompatibile con un’economia socialista – ragionava il capo della Dc – avrebbe potuto creare un argine invalicabile al comunismo. A De Gasperi peraltro non faceva difetto una profonda conoscenza della storia d’Italia. E dunque egli confidava nella circostanza che il tradizionale saper fare italico e la multiforme operosità delle nostre famiglie rurali avrebbero costituito l’acqua di coltura in cui felicemente inverare quel programma.
Una corporazione di nuovo conio
Un po’ tutti i libri che raccontano la storia italiana del secondo Dopoguerra concordano nel ritenere la Coldiretti di Bonomi come una sorta di “partito contadino” associato alla Dc. Una specie di “Giano bifronte”. Da un lato, organismo professionale e gruppo di pressione politico; dall’altro, potentato effettivo di controllo su aspetti rilevanti degli assetti istituzionali e dei processi economici del paese. Questo carattere composito dell’organizzazione era il frutto di una indubbia capacità di architettare marchingegni normativi e giuridici che dessero la possibilità alla Coldiretti di legare a sé gli agricoltori nelle forme più varie. Prima di tutto, attraverso le funzioni pubbliche esercitate dalla Federconsorzi e la vasta rete di relazioni finanziarie ed economiche gestite dall’ente. Poi, anche mediante le casse mutue dei coltivatori diretti alloggiate in tutte le sedi comunali dell’organizzazione.
Bisogna considerare che il “Giano bifronte” delle campagne italiane era frutto di un’accorta operazione culturale: far diventare senso comune due cose. La prima era che la “classe” dei coltivatori diretti avesse una missione da svolgere: contenere la capacità di espansione dei comunisti e, dunque, di essere un baluardo di libertà. La seconda era che gli interessi particolari di questa corporazione coincidessero con l’interesse generale.
Le corporazioni del Novecento non hanno nulla a che vedere con quelle medievali di arti e mestieri, che nell’Italia centro-settentrionale proliferarono spontaneamente per incardinarsi nella civiltà dei Comuni. Stiamo parlando della particolare forma di corporazione inventata per la società di massa. Si tratta dell’organizzazione professionale che subentra – con funzioni di mediazione – nel rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato. Corporazione capace di inquadrare tutti in un’unica volontà e di far esprimere al potere la sua intima vocazione: farsi tutto a tutti. Solo così il potere riesce ad essere se stesso, cioè totalitario, fatto di tante cose, anche tra loro contraddittorie. Alcuni tratti caratteristici della corporazione sono una professione, meglio se legata ad un titolo di proprietà; un livello di reddito che incida nella gerarchia sociale; un’uniforme o, semplicemente, un foulard da indossare e una bandiera da sventolare nelle manifestazioni pubbliche; uno stile di vivere, abitare e lavorare, fondato sull’orgoglio dell’anonimato unanime; un sentirsi al sicuro e protetto tra la “propria gente”; una comunanza di ideali politico-ideologici; un senso di appartenenza a qualcosa che si ritiene unico, eccellente. E questa mentalità corporativa non riguarda solo l’organizzazione professionale, ma permea e corrobora anche il partito di massa: partito supermarket, dove ogni avventore sa di trovare un conveniente articolo.
L’anticomunismo democratico
L’Italia ha conosciuto, senza soluzione di continuità, due fasi della società di massa e del suo connesso potere: quella antidemocratica, o fascista, e quella democratica. L’idea di “anticomunismo democratico” come tratto identitario di una nuova “classe”, quella dei “coltivatori diretti”, appositamente creata per difendere la libertà dal pericolo bolscevico, non era una banale operazione di copertura di interessi lobbistici. Aveva la valenza di potente iniziativa culturale, dotata di reali capacità di convincimento e di orientamento. Non a caso erano notevoli e variegati gli strumenti di propaganda messi in campo, tipici del regime fascista. Il quale, per primo, si era cimentato – ripeto – con la costruzione del consenso in una società di massa.
L’iniziativa di Bonomi si poneva in perfetta continuità coi modelli organizzativi del regime precedente. E in più poggiava sul disegno di trasformare l’ideologia interclassista da semplice mediazione di contrapposti interessi in scaturigine di una classe di mezzo in formazione perenne da promuovere attraverso una serie di interventi statali.
Riforma agraria, industrializzazione forzata dall’alto e assistenzialismo
Gli incentivi per la proprietà coltivatrice, la riforma agraria e l’intervento straordinario per il Sud diventavano il terreno su cui avviare la realizzazione di quel disegno. Ma già a metà degli anni Cinquanta, l’obiettivo di formare un nuovo ceto sociale e produttivo non era più centrale. Ad esso si sovrapponeva quello dell’industrializzazione forzata dall’alto, al fine di assicurare una crescita economica immediata senza dover attendere i necessari percorsi di accompagnamento e adattamento dei soggetti sociali coinvolti. L’idea era che la presenza di grandi impianti industriali di Stato avrebbe stimolato la diffusione di una prassi e di una cultura imprenditoriale. Non prevedeva, pertanto, alcun impegno concreto nell’attivare l’iniziativa privata e le risorse locali. Essa si nutriva della fiducia taumaturgica nella capacità dei grandi gruppi industriali di creare in pochissimi punti ben delineati i fattori esterni richiesti dall’impianto di un grande stabilimento. E dunque non lasciava trasparire alcuna volontà di creare, in modo diffuso, condizioni propizie allo sviluppo economico. La Dc burocratizzata di Fanfani faceva propria questa scelta suggerita da Pasquale Saraceno, direttore della Svimez.
La Coldiretti si adeguava al cambio di marcia senza fiatare. Otteneva, infatti, come contropartita l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per la pensione e contro le malattie ai coltivatori diretti, monopolizzando la gestione delle relative Casse mutue. Nel frattempo, si era impadronita della Federconsorzi, nata alla fine dell’Ottocento per iniziativa di gruppi ebraici e massonici di ispirazione liberale e trasformata dal fascismo in entità parastatale. E i servizi confederali non erano più orientati all’interesse degli associati ma a quello della Federconsorzi e delle aziende meccaniche, chimiche e sementiere con cui questa operava in esclusiva.
Per esaminare le spregiudicate modalità con cui Bonomi aveva scalato il vertice della Federconsorzi bisogna richiamare alla memoria le norme del 1948. Le quali stabilivano che all’elezione del primo consiglio di amministrazione di un consorzio agrario potevano partecipare i soci regolarmente iscritti entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge. Mentre gli statuti sociali disponevano che non poteva essere amministratore di un consorzio chi non ne era socio e che l’elezione ad amministratore della Federconsorzi aveva come presupposto la qualità di presidente o di socio delegato a rappresentare il consorzio nell’assemblea federale.
Per farsi eleggere presidente della Federconsorzi, Bonomi dovette ricorrere a un sotterfugio perché lui non era affatto agricoltore.. Si rivolse, pertanto, al presidente della Coldiretti di Viterbo, Carlo Petroselli. Il quale, il 25 aprile 1948, redasse una scrittura privata in cui sua moglie Clara Achilli dichiarava di affittare un fondo di sua proprietà, posto in località “Acquarossa”, al presidente nazionale della sua organizzazione. Sulla base di tale atto, Bonomi poté richiedere l’iscrizione a socio del consorzio agrario di Viterbo in qualità di agricoltore ed essere delegato a rappresentare l’organismo nell’assemblea federale. Solo qualche anno dopo, venne fuori che il terreno in questione era da tempo immemorabile di proprietà della Cura di S. Sisto di Viterbo, la quale fin dal 1946 lo aveva affittato a tal Paoletti Antonio. Ma l’accertamento del falso titolo di agricoltore non ebbe alcuna conseguenza.
Che l’ascesa di Bonomi al vertice della Federconsorzi e il patto di ferro da lui stretto con il direttore generale Leonida Mizzi furono una sorta di “golpe” lo prova l’indignata reazione di don Sturzo, il quale commentò la vicenda sul Tempo di Roma del 31 luglio 1949 con queste parole: “Si sono fatti entrare frettolosamente nella Federconsorzi un numero notevole di nuovi soci col pagamento di 100 lire di quota, meno di un pacchetto di sigarette; e per di più le quote sono state pagate dagli Enti nazionali dell’agricoltura”. L’anima liberale del cattolicesimo democratico si ribellava al modo come veniva condotta la privatizzazione della struttura fondamentale dell’agricoltura italiana, che produceva uno snaturamento della società civile per dar vita ad un monopolio che vedeva l’intreccio perverso di funzioni pubbliche e interessi privati sotto la guida di un gruppo di pressione.
Le responsabilità della sinistra
Si è fatto cenno alle peculiari origini rurali del movimento socialista in Italia. E tali radici avevano influenzato la costruzione del Pci in età repubblicana come moderno partito di massa. Il suo ri-fondatore, Palmiro Togliatti, era inoltre perfettamente consapevole della novità rappresentata dal partito popolare di Sturzo nella società italiana del primo Dopoguerra: assegnando una funzione politica agli strati di piccola borghesia urbana e rurale e ai proprietari contadini, i popolari avevano non solo compensato l’incapacità della borghesia agraria italiana di proporsi come classe egemone degli interessi agricoli, ma si erano impegnati a sostenere la crescita dei ceti medi delle campagne e delle città. Egli aveva infine studiato a fondo, durante l’esilio a Mosca, il rapporto tra massa e potere totalitario e, soprattutto, tra massa e organizzazione dello stato corporativo fascista.
Le vicende legate alla costituzione della Coldiretti, pertanto, erano state dibattute a fondo in una vivace e contrastata riunione della direzione comunista. La discussione si era concentrata sul presunto “tradimento” di Bonomi che aveva organizzato i coltivatori diretti fuori dalla Cgil. Ma Togliatti, sorprendendo tutti, aveva concluso dichiarando legittima la scelta della Dc e invitando anche la sinistra a “creare accanto alla Federterra un’associazione di coltivatori diretti” in competizione con quella promossa da Bonomi. L’idea di un’organizzazione contadina di sinistra, già affacciatasi nelle Tesi di Lione del 1926 come proposta di costruzione di un movimento di contadini poveri strutturato in modo indipendente dalla Federterra, non solo veniva confermata ma assumeva una dimensione più ampia fino a considerare l’insieme dei coltivatori proprietari, affittuari, mezzadri e coloni in un unico e autonomo polo di rappresentanza. Si trattava dunque di una visione perfettamente speculare a quella della Dc. E tale specularità segnerà alcuni tratti comuni delle proposte di politica agraria che democristiani e sinistra elaboreranno negli anni successivi. L’indicazione togliattiana era più rigida perché non considerava affatto, nemmeno in prospettiva, il problema di costruire un qualche rapporto di collaborazione con la Confederazione degli agricoltori, ritenuta come la struttura di rappresentanza degli avversari di classe dei lavoratori dipendenti delle campagne. E la scelta di un impegno per costruire una “Coldiretti” di sinistra, benché minoritaria sia nel Pci che nel Psi, di fatto forniva una giustificazione non irrilevante a quei settori della Dc che avevano sostenuto Bonomi nella sua impresa. Tra le personalità della sinistra dell’epoca, solo Manlio Rossi-Doria, il più insigne economista agrario italiano, dialogava con la Confagricoltura e coi settori della cultura tecnico-agronomica ad essa collegati. E anche per questo motivo, oltre che per la competenza scientifica, veniva spesso chiamato a collaborare con il governo dal ministro democristiano Antonio Segni.
Tranne il periodo dei governi di unità nazionale, durante il quale i comunisti avevano svolto funzioni di primo piano nel governo dell’agricoltura (Fausto Gullo in qualità di ministro dal 1944 al 1946 e Francesco Spezzano in qualità di commissario della Federconsorzi dal 1944 al 1948), dall’avvento della Repubblica fino al 1994 i ministri dell’agricoltura sono stati ininterrottamente democristiani. Durante tale arco di tempo solo i ministri Giovanni Marcora e Alfredo Diana non hanno avuto il consenso preventivo della Coldiretti.
Il disegno di un’organizzazione autonoma di coltivatori in competizione con la “bonomiana” fu molto contrastato da settori importanti della sinistra politica e sindacale. E venne realizzato con grave ritardo e con forti limiti. Solo dopo qualche mese dalle elezioni politiche del 18 aprile 1948 che aveva assegnato alla Dc una schiacciante vittoria, si costituì nel Centro-Nord l’Associazione nazionale coltivatori diretti che aderì alla Confederterra (ma non alla Cgil) e nel 1951 venne fondata a Napoli l’Associazione dei contadini del Mezzogiorno, affidata alla guida del comunista Pietro Grifone e del socialista Giuseppe Avolio. Fu necessario attendere il 12 maggio 1955 per vedere nascere a Roma l’Alleanza nazionale dei contadini, in cui confluirono l’Associazione dei contadini del Mezzogiorno, l’Associazione coltivatori diretti del Centro-Nord, che finalmente si distaccò dalla Confederterra, e le altre strutture che si erano costituite su basi regionali. Mancava all’appuntamento la potente Federmezzadri, che resterà nella Cgil fino alla metà degli anni Settanta quando potrà confluire nella Confcoltivatori. Erano ancora forti le resistenze politiche a considerare i mezzadri come una categoria non assimilabile ai lavoratori dipendenti.
Le prime fonti per ricostruire la vicenda
Si deve a Rossi-Doria una prima ricostruzione del ruolo svolto dalla Federconsorzi nella politica agraria in età repubblicana. In un meticoloso Rapporto – presentato alla Commissione parlamentare d’inchiesta sui limiti della concorrenza nel dicembre 1962 – egli sollevò un’accusa pesante: nella politica granaria del Dopoguerra fino agli inizi degli anni Sessanta, lo Stato aveva speso 1052 miliardi di lire incamerati dalla Federconsorzi, senza che questa presentasse regolari rendiconti sulla gestione delle attività esercitate per conto dei pubblici poteri. L’attacco non era tanto rivolto contro l’organizzazione economica, quanto invece alla Coldiretti e alla Dc, che vennero individuate come le destinatarie, di fatto, delle ingenti risorse finanziarie.
Lo scandalo che allora ne seguì fu uno dei temi di un’infuocata campagna elettorale per le politiche. E rimase proverbiale la puntata della tribuna elettorale televisiva in cui un veemente e caustico Gian Carlo Pajetta polemizzò con la sedia lasciata vuota da Bonomi. Il capo della Coldiretti preferì, infatti, fare la parte del convitato di pietra piuttosto che trovarsi nei panni dell’accusato per l’ammanco denunciato da Rossi-Doria.
Passarono le elezioni e il nuovo ministro dell’Agricoltura, Mariano Rumor, senza battere ciglio, rispose alla Camera che i calcoli di Rossi-Doria non erano esatti ma non negò l’ammanco: la somma fatta sparire dalle casse della Federconsorzi senza rendere conto a nessuno non era di mille miliardi ma solo di 850. Insomma, lo scandalo veniva ammesso ma lo si accantonò senza un dibattito parlamentare e solo con l’approvazione frettolosa di una sanatoria che scaricò sullo Stato l’onere degli interessi a cui avrebbe dovuto far fronte la Federconsorzi. Un costo che in seguito lieviterà a dismisura fino a raggiungere cifre che supereranno quelle relative ai consuntivi non approvati dalla Corte dei Conti.
Sulla vicenda della Federconsorzi Rossi-Doria aveva mantenuto sempre una posizione equilibrata e costruttiva. Il Rapporto consegnato alla Commissione parlamentare d’inchiesta si concludeva con siffatte parole: “Nello scrivere questi paragrafi confesso che ho più volte esitato nel timore che questo mio apertis verbis apparisse come un forzar la mano su cose che dovrebbero parlar da sé e potesse, perciò avere un effetto opposto a quello che mi propongo. Ma troppo in questi anni, tutti noi che viviamo nel settore dell’agricoltura abbiamo sentito che il silenzio sotto il quale passavano dati e vicende, a noi ben noti e gravissimi, diventava omertà. Occorreva pertanto rompere questo silenzio”. E poi, in un convegno del Psi-Psdi unificati svoltosi a Roma nel 1967, il professore di Portici aveva continuato ad esprimere sempre giudizi pacati : “I consorzi agrari e la loro federazione sono uno dei grandi patrimoni degli agricoltori italiani. Decaduto sotto il fascismo a strumento della politica corporativa a tutto danno degli agricoltori, è dal 1948, – con la conseguenza dell’immobilismo dell’intera politica agraria – un diretto strumento di potere del partito di maggioranza e dell’organizzazione sindacale dei coltivatori diretti ad esso legata. Fin dalle prime mosse verso l’accordo di centro-sinistra il partito socialista ha ammonito la democrazia cristiana che questo stato di cose – legate ad un passato di cattiva amministrazione di pubblico danaro – non poteva durare e doveva essere mutato nel suo stesso interesse e per il comune impegno politico di costruire uno stato e una società democratica in Italia. Purtroppo, si è visto tuttavia che il partito di maggioranza e i suoi ministri sono prigionieri di una situazione, dominata da un solo uomo al quale certamente la Dc molto deve, ma che ostinatamente oppone il suo no ad ogni costruttiva soluzione dei problemi agricoli italiani, come il generale De Gaulle – se il paragone fosse ammissibile – dice no all’Inghilterra in Europa”.
Il sociologo Gilberto Antonio Marselli, che aveva collaborato con Rossi-Doria alla stesura del Rapporto, ha recentemente così descritto le vicende della più importante struttura economica dell’agricoltura italiana: “La Coldiretti è diventata ad un certo punto l’azionista di maggioranza della Federconsorzi, il che significava essere il controllore della Dc”. Ma come esercitava questo controllo sul partito di maggioranza relativa? Vediamo come risponde Marselli: “C’è una profonda differenza tra Nord e Sud. Mentre la Coldiretti nel Sud era un’organizzazione ‘mafiosa’, la Coldiretti nel Nord capì che si doveva puntare sulla cooperativa, e sulla istruzione dei contadini. Il rapporto con la Dc non fu più solo un rapporto di gestione del potere, e quindi di raccolta dei voti e di rappresentanza parlamentare, ma fu anche un rapporto finanziario, per cui la DC veniva finanziata dai consorzi agrari. La Coldiretti, in sostanza, era un’organizzazione para-politica per la raccolta di voti”.
Un inquadramento storico di lungo periodo sulle vicende della Federconsorzi è stato compiuto dal giornalista e scrittore Antonio Saltini, con una serie di articoli apparsi su diverse riviste tra il 1977 e il 2002 e oggi raccolti nel blog Agrarian Sciences. È Renato De Marzi a tentare inoltre, nel 1987, la ricostruzione delle vicende del colosso economico dell’agricoltura italiana in un libro intitolato “Grano e potere. La Federconsorzi, cento anni di lotte per il dominio sulle campagne”, pubblicato per i tipi di Edagricole. L’autore aveva svolto compiti di alto funzionario nell’organismo e ne conosceva a fondo la vita interna e gli uomini che lo avevano diretto. E difatti il volume è prodigo di informazioni, ricordi, percezioni molto utili per comprendere “il ruolo essenziale svolto da un organismo che – come sottolinea l’editore nella presentazione – è avvolto in un alone brumoso”. E significativamente si aggiunge sempre nella presentazione: “Verso quell’organismo non è gratuito supporre vi siano forze che al mantenimento di quella bruma sono interessate, complice una diffusa opzione per la non conoscenza, quasi una rimozione collettiva, dell’opinione pubblica”.
Il crack Federconsorzi: uno choc
Quando gli agricoltori si lamentano delle condizioni di debolezza della nostra agricoltura dovrebbero ricordare almeno due date infauste: il 30 ottobre 1944, giorno in cui si consumò la scissione della rappresentanza agricola con la nascita della Coldiretti, e il 17 maggio 1991, giorno in cui venne firmato il decreto di commissariamento della Federconsorzi con l’avvio della dispersione della holding e dello storico patrimonio della rete dei servizi nelle campagne, cresciuta attorno ai consorzi agrari.
A provvedere al commissariamento fu il ministro dell’Agricoltura, Giovanni Goria, democristiano legato a Giulio Andreotti, che in quel periodo era presidente del Consiglio. Le inchieste giudiziarie sul concordato preventivo porteranno alla luce un indebitamento per 6 mila miliardi di lire nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Al momento del commissariamento, nel collegio dei revisori a tutelare la regolarità dei bilanci figuravano due alti funzionari della Coldiretti, Franco Pasquali e Vincenzo Gesmundo. Il primo ricoprirà la carica di segretario generale e l’altro di segretario organizzativo. Saranno loro due a gestire nel 1993 la sostituzione di Arcangelo Lobianco con Paolo Micolini e i rinnovi presidenziali successivi. Di fatto diventeranno i veri “capi” della Coldiretti.
Quello di Goria fu un tardivo atto dovuto. “Paradossalmente – ha scritto l’economista agrario Roberto Fanfani – il commissariamento della Federconsorzi è stato il primo serio atto di vigilanza effettuato dal ministero dell’Agricoltura a partire dall’ordinamento stabilito con il decreto del 1948”. Ma dopo quello choc, anziché prendere finalmente atto della situazione disastrosa, a cui un atteggiamento di prevaricante arroganza protrattosi per oltre un quarantennio aveva condotto, e iniziare un nuovo cammino dell’agricoltura italiana andando spediti verso un’unica e grande organizzazione degli agricoltori, si è fatto il contrario. E invece di individuare i responsabili del disastro e chiamarli a rispondere dei loro comportamenti, i dipendenti e i creditori, ingiustamente coinvolti nelle conseguenze nefaste della vicenda, si sono rivalsi sullo Stato per tentare di sanare pendenze con risorse che esso normalmente destina all’insieme dell’agricoltura italiana.
La Commissione Cirami
Le ragioni storiche e politiche che hanno portato al crack della Federconsorzi sono state approfondite dalla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita nel 1998, che ha svolto i suoi lavori tra il 1999 e il 2001. Venti deputati e venti senatori hanno acquisito una mole imponente di documenti e hanno interrogato centinaia di testimoni in cinquantuno audizioni. Sono stati ascoltati un ex presidente del Consiglio (Giulio Andreotti), un ministro dell’Agricoltura in carica (Alfonso Pecoraro Scanio), quattro ex ministri dell’Agricoltura (Filippo Maria Pandolfi, Gianni Fontana, Alfredo Diana e Calogero Mannino), ex sottosegretari e capi di Gabinetto, banchieri e magistrati titolari di inchieste sul crack, nonché i massimi dirigenti delle due organizzazioni che avevano gestito la struttura economica. Un professore di economia applicata, Antonio Piccinini, e un giornalista, Fabrizio Peronaci, hanno riportato – in uno studio molto approfondito sull’evoluzione della Pac e i gruppi di pressione in Italia e in Europa, dal titolo “La lobby agricola. Tra concertazione, neocorporativismo, globalizzazione dei mercati, vacche pazze e organismi geneticamente modificati”, pubblicato nel 2003 – ampi stralci dei lavori della Commissione. Di tale fonte ci si è avvalsi per illustrare i risultati dell’importante iniziativa parlamentare.
Il rapporto finale contiene queste affermazioni: “La Commissione ha maturato il convincimento che la Coldiretti e la Confagricoltura, sia pure in misura diversa, dirigevano di fatto la Fedit, gestendo risorse di sostanziale derivazione pubblica, nulla rischiando del loro patrimonio ed anzi attribuendosi parte dei ricavi, sotto forma di contribuzioni di dubbia legittimità”. Negli anni Ottanta, con il primo ricambio generazionale avvenuto dal Dopoguerra, “si accentuò l’influenza delle organizzazioni di categoria e in particolare della Coldiretti che, in armonia con le impostazioni politiche del partito di riferimento, la Democrazia cristiana, piegò il mutualismo, insito nella struttura a base cooperativa del sistema, ad assistenzialismo, e quindi assegnò alla Fedit il ruolo tipico di un ente pubblico assistenziale a sostegno del sistema satellitare dei consorzi, conservati così vitali per mantenere il consenso politico ed elettorale che ne derivava, a prezzo del progressivo depauperamento e dell’inevitabile tracollo della casa madre”.
La diagnosi è molto netta: la decisione di non commissariare e liquidare i consorzi più indebitati, e peggio ancora di presentare bilanci che continuavano “ad occultare con varie alchimie” il progressivo aggravarsi della situazione, fu “una scelta politica ed economica radicalmente sbagliata che coltivava l’illusione di poter fare fronte alla crisi con l’iniezione di denaro pubblico”.
L’audizione di Lobianco
“A quale degli uomini politici di maggiore spicco della Democrazia cristiana di allora lei faceva riferimento? De Mita? Andreotti? Forlani?”, chiede il presidente della Commissione, Melchiorre Cirami, a Lobianco. La risposta è evasiva: “All’epoca ebbe inizio una serie di incontri ufficiali con i presidenti del Consiglio incaricati. I giornali hanno scritto che ci sarebbero state delle divergenze con alcuni amici della Dc per il fatto che mi ero spostato a sinistra. Non mi ero spostato né a sinistra né a destra. Si trattava semplicemente di questa linea di azione autonoma che cercavo di portare avanti e che probabilmente non era gradita a qualche amico di partito”. “Ma almeno si può sapere a quale corrente appartenevano le decine di deputati e senatori democristiani eletti con i voti dei contadini?”, incalza un commissario. “Guardi, noi abbiamo avuto un periodo in cui c’erano 60-70 deputati perché, oltre ai dirigenti, c’erano i cosiddetti amici dei coltivatori. A mano a mano che si è andati avanti si è precisato che dovessero essere candidati e appoggiati solo i dirigenti della Coldiretti. Quindi negli ultimi tempi si è arrivati ad avere 15-20 amici, alcuni dei quali facevano parte dei cosiddetti dorotei, altri del gruppo del presidente Andreotti e altri, pochi, della sinistra. Però l’orientamento ufficiale della confederazione era di rimanere fuori dalle correnti di partito… Per quanto riguarda i parlamentari europei – precisa in risposta a una successiva domanda Lobianco – erano sei o sette, questo è sicuro, mentre i consiglieri comunali erano migliaia”.
È a questo punto che l’audizione entra nel vivo. Il presidente della Commissione chiede a Lobianco a chi si riferisse nel 1993 quando, nel discorso d’addio alla Coldiretti, si scagliò contro “certi potentati economici” e contro “il patto scellerato eseguito con freddo cinismo da certi personaggi” per lo smantellamento della Federconsorzi. Cirami: “Quale fu questo patto scellerato? Tra chi fu stretto? Avevano un nome e cognome costoro?”. Lobianco: “No, ho parlato di personaggi in senso politico. Anche oggi si parla di personaggi che alla Camera o al Senato non vogliono certe cose”. Cirami: “La posso aiutare? Era il mondo bancario? Perché poi nel mondo bancario ci sono nomi e cognomi, banche e dirigenti…”. Lobianco: “No, le mie dichiarazioni erano in senso politico generale. Mi riferivo a un sistema politico-economico che non si era dato da fare per evitare la distruzione”. Cirami: “Ma si estrinsecava in certi enti o in certi istituti economici? Lei parla di potentati economici e io mi domando se questi significhino le banche creditrici che esercitavano la loro invadenza nella gestione della Federconsorzi”. Lobianco: “Su questo non posso essere preciso. Si tratta di mie personali teorie politiche che spero possano chiarirsi quando saranno conclusi i processi in corso…”. Cirami: “Abbiamo toccato l’argomento banche, ma avrei potuto fare riferimento anche ad altri potentati economici: però vorrei da lei una risposta più concreta. Le sue risposte non dico che siano evasive, ma certamente sono di largo respiro politico, mentre dobbiamo parlare di riferimenti concreti. Dunque, vi erano le banche che erano creditrici o che avevano prestato denaro alla Federconsorzi senza alcun privilegio che le tutelasse (perché a volte si trattava di prestiti che avvenivano senza nessuna garanzia, in mancanza totale di controlli da parte del Ministero, della Banca d’Italia e dell’Abi), ma anche altri potentati economici che avevano rapporti con la Federconsorzi e con il mondo agricolo quali ad esempio la Ferruzzi, Tanzi, la Sme.
Questi potentati premevano per lo smantellamento perché avevano prospettive diverse sulla riorganizzazione della Federconsorzi? Credo sia il momento di parlare di queste cose senza nessuna reticenza”. Lobianco: “Non ho reticenze”. Cirami: “Reticenze nel senso di voler rimandare tutto alle valutazioni politiche”. Lobianco: “Signor presidente, sono in corso dei giudizi”. Cirami: “Non vorrei invadere quel campo, ma si tratta di giudizi che, comunque, la magistratura darà con i limiti ed i poteri del processo penale, mentre noi stiamo facendo un’inchiesta politica per capire cosa è accaduto nella Federconsorzi. Riguardo a ciò, lei riferiva di pressioni di personaggi o potentati economici, ma dei riferimenti di ordine pragmatico deve pur averli”. Lobianco: “Ribadisco, signor presidente, che si trattava di una mia sensazione. La Federconsorzi faceva da calmiere, aveva agenzie e officine nelle zone di montagna, aperte anche fuori orario, e questo non faceva comodo al privato… Era al servizio degli agricoltori di una certa zona e certo il meccanico privato non traeva vantaggio da questo. La Federconsorzi faceva paura a quelli che avrebbero potuto speculare facendo venir meno questo sistema. Si trattava soltanto di sensazioni politiche in quanto non ho nomi da fare, né indicazioni da dare…”.
Gli ultimi tentativi di salvare la Federconsorzi
I commissari, rassegnati all’idea che i famosi “nomi” non salteranno mai fuori, passano ad altro. Il presidente della Commissione invita Lobianco a riferire sui tentativi di lobbying adottati dalla Coldiretti per risolvere il problema della Federconsorzi. Cirami: “Ella operò tre tentativi. In un primo tempo tentò di fare inserire i consorzi agrari tra i beneficiari degli stanziamenti governativi per circa 19 mila miliardi in favore dell’agricoltura, previsti da una legge in discussione in sede deliberante dinanzi alla Commissione agricoltura del Senato. Fu il senatore Micolini a presentare un emendamento che avrebbe assicurato ai consorzi circa un terzo delle provvidenze. Insorse il senatore Fabbri del Psi che, con l’appoggio di esponenti della maggioranza e dell’opposizione, fece rimettere il provvedimento in aula e lo affossò. Un secondo tentativo, anch’esso frustrato dall’opposizione dei socialisti, sarebbe avvenuto nel corso del disegno di legge sul credito agrario: si sarebbe tentato di favorire i crediti Fedit. Da ultimo, sarebbe stato elaborato una sorta di piano, denominato Lobianco-Pomicino, che prevedeva il commissariamento non della Fedit ma di un buon numero di consorzi, l’accorpamento di altri, la vendita di beni, la creazione di una nuova società. È corretta questa ricostruzione?”. Lobianco, nella risposta, conferma le frenetiche quanto vane trattative avviate per scongiurare il crollo della Fedit: “Ho avuto contatti con amici preoccupati dell’andamento delle cooperative, per cui si parlò di poter inserire nella legge pluriennale delle norme nuove che potessero aiutare la cooperazione negli accorpamenti, nelle fusioni, nella vendita del patrimonio non utile. Definimmo un progetto denominato ‘Parim’, con tutta una serie di azioni. In questo senso, mi ero incontrato più volte con esponenti del mondo della cooperazione, ai quali chiesi di poter far includere anche la Federconsorzi e i consorzi agrari tra i beneficiari. Mi chiedevo: perché, se queste sono cooperative, non devono godere degli stessi benefici, non dei 19 mila miliardi ma di quella quota che anno per anno sarebbe andata alla cooperazione? L’emendamento Micolini non passò per l’opposizione dei socialisti. Quanto al secondo tentativo, identica sorte. Noi abbiamo sostenuto che il credito agrario in natura era utile al mondo dell’agricoltura perché dando concimi, mangimi, sementi si aveva la possibilità di avere merce buona e di poter fare cambiali agrarie, quindi pagare al momento del raccolto. La tesi del senatore Fabbri e di altri era quello di fare il credito agrario soltanto in denaro e abolire quello in natura…”. Infine, “sull’accordo con Pomicino, esso non è mai esistito. Io mi sono incontrato con il ministro Pomicino, che allora era ministro del Bilancio, per dirgli che vi era una situazione di difficoltà del mondo della cooperazione in generale, e in particolare della Federconsorzi. Rispose che forse si sarebbe potuto trovare un sistema che desse un aiuto alla cooperazione per le passività onerose, quindi un aiuto sugli interessi, e si sarebbe potuto cercare di far entrare, se le altre forze politiche lo permettevano, anche i consorzi agrari. Quindi non abbiamo fatto nessun accordo, fu un puro scambio di opinioni”. Cirami: “Io non parlavo di accordo, ho chiesto se c’era stato un piano”. Lobianco: “No, nessun piano”. Cirami: “Questa discussione che lei ebbe con Cirino Pomicino si svolse all’insaputa di Goria?”. Lobianco: “Non vorrei sbagliare, ma si svolse prima che la Federconsorzi fosse commissariata”. Cirami: “Anche prima del commissariamento ne parlò con Goria?”. Lobianco: “Goria è stato ministro un mese solo prima del commissariamento. Quindi l’incontro con Pomicino avvenne prima. Le nostre preoccupazioni per la Federazione vi erano da alcuni anni, dal 1989, quando cominciammo a leggere sui giornali delle difficoltà che viveva il sistema”. Sublime. Il presidente della confederazione agricola che amministra con propri dirigenti, da sempre, la Federconsorzi, apprende “dai giornali” che la stessa è sull’orlo del collasso finanziario.
Ma il grande burattinaio è davvero esistito?
Come in un grande giallo, il successivo passo consiste nel tentare di abbozzare un identikit del colpevole. Chi è stato il “grande burattinaio” del crack? Ed è davvero esistito? Il senatore Cirami un’idea sembra averla: “Credo che al pubblico ministero di Perugia lei avesse prospettato che l’atteggiamento di commissariare la Federconsorzi, più che riferito a Goria, è da attribuire al sottosegretario Cristofori, se non vado errato”. Lobianco: “Era stato un articolo di giornale. Cristofori aveva risposto sui giornali che non era vero”. E allora chi? Il presidente della Commissione invita Lobianco a tornare con la memoria al 17 maggio, quando “tra le 10,30 e le 11 ci fu quella riunione nel salone privato di Andreotti dove già si trovavano il ministro Goria, il ministro Pomicino, l’onorevole Forlani, il sottosegretario Cristofori e, dopo alcuni minuti, entrò il presidente Andreotti”. Cirami: “Questa riunione presso la Presidenza del Consiglio la volle lei, oppure fu una risposta della Presidenza del Consiglio alle sue preoccupazioni?”. Lobianco: “Parlando nei giorni precedenti con Cristofori, dissi che avevo visto Goria preoccupato e che non avrei voluto che agisse in modo non concordato facendo qualcosa di non buono. Cristofori mi disse di lasciargli il tempo di pensare. Poi mi chiamò al telefono e mi comunicò che ne aveva parlato con il presidente e che aveva fissato la riunione per l’indomani. Quindi non so se la riunione fu a seguito della mia telefonata con Cristofori”. Cirami: “Quando avete fatto questa riunione lei ebbe la sensazione che il decreto di commissariamento fosse stato già firmato?”. Lobianco: “Lo stesso Goria disse di aver già fatto tutto, di aver già convocato la stampa per una conferenza. Chiesi se non era possibile aspettare qualche giorno, ma egli mi rispose che aveva già predisposto tutto e allora io mi domandai il motivo per il quale mi avevano chiamato”. È a questo punto che il botta e risposta assume una piega un po’ irreale, con divagazioni nel sovrannaturale. Cirami: “Dottor Lobianco, le chiedo un giudizio obiettivo: questo commissariamento fu disposto per ragioni reali ed oggettive oppure fu fatto contro la Coldiretti e una parte della Democrazia cristiana?”. Lobianco: “È una domanda che mi pongo tutti i giorni e tutte le notti… Alcune volte mi rispondo nel senso da lei ipotizzato, altre volte invece la mia fede religiosa non mi induce a pensare che ci sia stata una cattiveria del genere, anche perché si tratta di esprimere un giudizio su una persona morta. Non nascondo che in un certo senso io stesso avevo indicato Goria come ministro. Feci il suo nome perché ritenevo che ci volesse un ministro dell’Agricoltura con esperienza internazionale: Goria era stato presidente del Consiglio, ministro del Tesoro e ministro della Finanze e pertanto avrebbe potuto qualificare il mondo agricolo. Tutto si può pensare, anche che quest’uomo da me stesso indicato sia stato lo strumento di un’operazione del genere, però la mia fede religiosa mi porterebbe a ritenere il contrario”. Cirami: “Ma come si spiega la caparbietà di Goria nel commissariare senza ascoltare nessuno, neanche l’ultimo afflato in quella riunione che a sentire lei fu una presa in giro visto che tutto era stato deciso? Io mi sarei sentito preso in giro”. Lobianco: “Infatti questo l’ho evidenziato all’allora segretario del mio partito: ho detto che non era stata una cosa corretta e che comunque io da cristiano non capivo come in un mese si potesse fare il commissariamento. Il fatto stesso che quella sera si sia parlato con la stampa e con i banchieri di un progetto di tre società vuol dire che era tutto predisposto”. Cirami: “Quindi dobbiamo scartare la buona fede”. Lobianco: “Non lo so. Come cristiano non dovrei, come uomo…”. Cirami: “Purtroppo non discutiamo di fatti di religione, ma di fatti umani…”. Lobianco: “Che la riunione sia stata una presa in giro è certo”. “Quindi prima di pensare alla buona fede c’è un baratro”, conclude il senatore Cirami, che alla successiva risposta di Lobianco (“Visto che era tutto fatto mi chiedo perché mi hanno chiamato. Si tratta di una domanda che mi pongo da dieci anni”), replica con tono quasi sconsolato: “Lei se la pone come domanda, mentre per noi è la ricerca di una risposta che dobbiamo dare al Parlamento”.
Le modalità del finanziamento alla Coldiretti
Molto serrata è anche la parte conclusiva dell’audizione, dedicata al finanziamento della Coldiretti. Lobianco spiega che la Federconsorzi, in quanto associata dal 1981, versava alla Coldiretti una quota annuale di circa 5 miliardi di lire e che le pubblicazioni di Palazzo Rospigliosi venivano stampate da una società della Fedit. Ammette di non sapere se tali quote fossero state mai esposte nei bilanci. Cirami: “Ora le pongo domande un po’ più delicate. Risulta che i contributi annuali venivano corrisposti dalla Fedit a mezzo di assegni circolari. Perché, se si trattava di contributi legittimi, non si procedeva ad accreditare le somme sui conti della Coldiretti e si adottavano invece così anomale e invero sospette modalità? Quale destinazione avevano gli assegni circolari? Venivano girati da lei? A chi? Con quali fini?”. Lobianco: “Per il 1991 la Coldiretti ha rinunciato al contributo, diversamente dalla Confagricoltura che ha fatto causa per essere inserita tra i creditori. Per quanto riguarda i contributi, ogni 2-3-4 mesi io o il segretario centrale passavamo gli assegni all’amministrazione che li versava in banca”. Cirami: “Non era più spedito che mese per mese si facesse l’accredito sul conto corrente della Coldiretti?”. Lobianco: “Non ci siamo mai posti questo problema”. Cirami: “Il problema è vedere quale destinazione finale avevano questi assegni circolari”. Lobianco: “Entravano nella cassa della Coldiretti e venivano iscritti nei bilanci. Ho una copia fotostatica di un bilancio. Quando versavo questi contributi l’amministratore mi rilasciava regolare riversale di incasso”. Cirami: “Dottor Lobianco, lei deve comprendere le nostre perplessità, anzi un mio dubbio personale che non voglio addebitare ad altri: si fanno questi assegni circolari, si danno a lei, lei li firma con girata, li consegna all’amministratore che li registra e li deposita in banca. Ma allora non era più semplice fare l’accredito sul conto corrente della Coldiretti?”. Lobianco: “Signor presidente, non so perché si facesse così. È un’usanza che ho trovato e che ho mantenuto. Non c’era niente di straordinario”. E su questo dubbio la seduta viene dichiarata conclusa.
L’entità del finanziamento a Coldiretti e a Confagricoltura
Tra il 1986 e il 17 maggio 1991 (periodo considerato nell’inchiesta), la Coldiretti ricevette a titolo di contributo ordinario 24 miliardi e 900 milioni di lire, ma se si sommano i contributi straordinari e le spese per le pubblicazioni la cifra totale arriva a superare i 47 miliardi di lire. La Confagricoltura nello stesso periodo beneficiò, tra contributi e pagamenti di pubblicazioni o affini, di quasi 26 miliardi di lire.
La prima domanda che si pone la Commissione è la seguente: a che titolo la Fedit saldava il conto delle pubblicazioni di altri? La risposta è nelle delibere e nei verbali dei consigli d’amministrazione: il pagamento di libri o periodici veniva effettuato per “sostenere iniziative di carattere culturale”, “migliorare la capacità professionale degli agricoltori”, “diffondere la cultura agricola tra le centinaia di migliaia dei soci dei consorzi agrari provinciali suoi federati e in generale tra i produttori agricoli italiani”. Benissimo, replica tagliente la Commissione: “Si potrebbe plaudire all’ispirazione pedagogica, se le pubblicazioni fossero state di università e centri di ricerca e divulgazione e non fossero state sempre e soltanto quelle della Coldiretti e della Confagricoltura. La fragilità della giustificazione del tutto formale è evidente”. E non finisce qui: “Essa diventa addirittura grottesca – incalza l’organismo d’inchiesta – se si pensa che la Fedit pagava, a titolo di spese di rappresentanza, persino la pubblicazione dell’Agenda agricola Coldiretti (nel 1996 ben lire 95.150.000 per 55.000 copie), della cui capacità di promozione culturale è lecito dubitare”.
Un altro aspetto di cattiva gestione, denunciato nella relazione finale con accenti sdegnati, è quello delle gratifiche: “La Federconsorzi era generosa non solo con le organizzazioni professionali, ma anche con i suoi dipendenti e collaboratori. Gli amministratori avevano grandissima considerazione dei loro collaboratori, tanto da corrispondere loro premi di produttività ogni anno”. Fino al commissariamento, la Federconsorzi distribuì ai responsabili dei consorzi “premi di operosità” che venivano stabiliti dal direttore generale. “Evidentemente – rampogna la Commissione – premeva piuttosto la fedeltà dei direttori che non la loro capacità gestionale”.
Un patrimonio immobiliare a prezzi di saldo
La Commissione parlamentare d’inchiesta ha approfondito anche i rapporti intercorsi tra Federconsorzi e organizzazioni agricole in relazione alla gestione di alcuni immobili di pregio storico ed architettonico, arricchiti da preziosi arredi di rilievo e da una collezione di opere d’arte, di proprietà della holding. In particolare si tratta dei due edifici situati nel centro storico di Roma e adibiti a sede nazionale delle due confederazioni: Palazzo Rospigliosi (via 24 maggio 43), dato in locazione alla Coldiretti, e Palazzo Della Valle (corso Vittorio Emanuele 101), preso in affitto dalla Confagricoltura. Per Palazzo Rospigliosi la Coldiretti pagava 200 milioni di lire annue, “mentre secondo il consulente tecnico d’ufficio, il canone che si sarebbe dovuto richiedere per il valore di redditività degli immobili ammontava a 4 miliardi 155 milioni annui”; per Palazzo Della Valle, la Confagricoltura sborsava invece 150 milioni l’anno, “mentre quello che si sarebbe dovuto richiedere ammontava a 970 milioni”. A conti fatti, lo “sconto” sui prezzi di mercato era nell’ordine del 95% per la Coldiretti e dell’85% per la Confagricoltura, che peraltro, aggiunge con una punta di malizia la Commissione, non dovevano nemmeno prendersi la briga di versare somme proprie: “Indipendentemente dall’entità del canone di locazione, va osservato che Coldiretti e Confagricoltura non pagavano con i propri soldi, ma con l’ammontare delle somme che la Fedit dava loro di anno in anno”. Due ulteriori accertamenti riguardano il rinnovo del contratto relativo a Palazzo Rospigliosi, formalizzato il 15 maggio 1991, “cioè – annotano i commissari – due giorni prima del commissariamento della Federconsorzi”, e la vendita dello stesso alla Germina Campus srl, società completamente controllata dalla Coldiretti, il 28 giugno 1995 per la somma di 71 miliardi di lire: “La Commissione ha svolto accertamenti sulle modalità del pagamento, verificando che la Coldiretti utilizzò crediti bancari ed affidamenti concessi sulla base di titoli di Stato in possesso della stessa Coldiretti”.
Il verdetto
Due anni di lavoro, migliaia di documenti esaminati, una puntigliosa ricostruzione del tracollo finanziario attraverso il riesame di tutti i conti della Federconsorzi, soprattutto quelli in “nero” o “riservati”, e alla fine un giudizio molto negativo sulle due organizzazioni professionali per il ruolo avuto nella gestione della Fedit, considerata “un pozzo miracoloso” piuttosto che uno strumento economico “imparziale” di sostegno dell’agricoltura.
Per la Commissione, le cause che concorsero al crack della holding agroalimentare furono molteplici, ma tutto si può far risalire a un’anomalia di fondo: l’obbligo fissato in capo ai consorzi agricoli di rivolgersi obbligatoriamente alla casa-madre per l’acquisto dei beni da rivendere ai soci. La Federconsorzi in questo modo “si era costituita una complessa ed articolata rete di società che le consentiva una parziale e non sempre vantaggiosa autarchia”, in quanto “il prezzo dei prodotti non si formava attraverso il confronto sul mercato”, ma in condizioni di sostanziale monopolio, come nel caso della vendita dei trattori Fiat agli agricoltori. Le conseguenze di tale grave distorsione furono di due tipi: da un lato i consorzi non ricevevano le merci ai prezzi più convenienti e quindi “non avevano la possibilità di garantire ai soci le condizioni più vantaggiose e a se stessi adeguati margini di remuneratività”; dall’altro la Fedit poteva contare su “un vero e proprio profitto parassitario”, che le derivava dal ruolo di diretta venditrice e distributrice dei prodotti.
“Le due associazioni di categoria – stigmatizza la Commissione nel XIII capitolo, intitolato “Sintesi delle conclusioni raggiunte” – erano consapevoli che la loro forza politica si basava proprio su questo assetto sistemico che produceva l’indebitamento dei consorzi… Modificare il meccanismo, allargando la base e prevedendo l’ingresso di nuovi capitali e di forze nuove nel sistema, radicalmente riformandolo, adeguandolo alle esigenze della moderna agricoltura ed aprendolo al mercato, avrebbe comportato la necessità di un nuovo assetto normativo, ma avrebbe anche segnato inevitabilmente la fine del monopolio delle due associazioni…”. Fu proprio nel decennio precedente il tracollo, fa notare la Commissione nel capitolo V (“Federconsorzi: dalla prosperità al dissesto”), che si crearono i presupposti del collasso a causa dei tre fattori “concomitanti e interdipendenti”: dirigenza Fedit inadeguata, accentuazione dell’influenza della Coldiretti nelle decisioni sulla gestione e mancato scioglimento dei consorzi agrari in perdita.
Il giudizio del Parlamento è senza appello: “Le responsabilità sono da imputarsi principalmente alle due associazioni di categoria e in particolare alla Coldiretti e ai suoi dirigenti, ancor prima e di più che agli amministratori e sindaci della Federconsorzi…”.
La cura consigliata ma mai applicata
Come si può facilmente notare il verdetto della Commissione Cirami è identico alla diagnosi contenuta nel Rapporto che Rossi-Doria aveva stilato quarant’anni prima. E il professore di Portici – avvicinandosi alla soglia degli ottant’anni – il 28 aprile 1982, nella sala dell’istituto Alcide Cervi in Piazza del Gesù a Roma, a conclusione di un ciclo di otto lezioni, aveva aperto il dibattito sul tema “Verso una nuova Agricoltura” con questo interrogativo: “Lo sviluppo dell’agricoltura italiana è stato finora condizionato dalla contrapposizione di due blocchi. Da una parte la Coldiretti, la Confagricoltura, la Federconsorzi (dietro le quali ci sono la Dc, il Pli, le forze cosiddette moderate). Dall’altra parte ci sono la Confcoltivatori, la Lega delle Cooperative, l’Anca (dietro le quali ci sono il Pci, il Psi, le forze cosiddette progressiste). Questa la situazione negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Oggi, anni Ottanta, vi domando: la situazione è ancora così bloccata oppure si sta sbloccando o addirittura si è già sbloccata? Ecco, signori, la chiave di lettura del domani!”. Con questo esordio avvincente il vecchio maestro avviò la discussione. Dopo tre ore la concluse con il seguente monito: “Oggi, che l’età mi consente di staccarmi dai problemi di cui mi sono occupato per tutta la vita, raccomando a tutti di guardare a tali problemi con molta prudenza. La diagnosi è difficile. La nostra agricoltura in fatto di produttività per addetto, in fatto di impiego di mezzi tecnici per ettaro, in fatto di entità di capitali investiti, rivela dei parametri notevolmente inferiori a quelli di altri paesi. È vero. Ma è anche vero che in trent’anni la nostra agricoltura ha più che raddoppiato la produzione globale mentre il numero dei suoi addetti si è più che dimezzato. Chi ha ragione dunque? Chi afferma che la politica agraria finora perseguita nel nostro paese è tutta sbagliata o chi sostiene che quanto si è fatto è quanto si poteva e si doveva fare? Anche stabilire la terapia non è facile. Le realtà da affrontare sono molte e molte debbono essere le terapie ossia le politiche. In ogni caso però la politica agraria deve privilegiare l’associazionismo e intervenire per il riassetto dei mercati di sbocco dei prodotti agricoli, tema sul quale, ahimè, mi sono affannato per tutta la vita”. Il messaggio era estremamente chiaro: la causa principale delle difficoltà della nostra agricoltura andava ricercata nel blocco politico che ne aveva condizionato lo sviluppo; e tale blocco andava assolutamente rimosso per rafforzare prioritariamente le organizzazioni economiche dell’agricoltura e riassettare i mercati di sbocco dei prodotti agricoli.
Un altro esimio studioso, preside della Facoltà di Agraria di Bologna ed editore di una buona parte della stampa agricola italiana, Luigi Perdisa, in un editoriale della rivista “Terra e vita” del febbraio 1983, aveva fatto notare “il colmarsi nel mondo agricolo del fossato che divideva l’impresa contadina dall’impresa capitalistica”, per poi auspicare “il superamento delle burocrazie sindacali che ancora si frappongono alla costituzione di un’unica organizzazione degli imprenditori agricoli italiani”.
Caduto il Muro di Berlino nel 1989 e venuta meno finalmente la conventio ad excludendum, il Pci, a prezzo di una grave divisione interna, ne traeva immediatamente le conclusioni, cambiando nome e statuto. Con la fine del comunismo anche la Dc perdeva il fondamentale collante ideologico che la teneva in piedi. Svaniva così l’antico sogno della sinistra di competere con la Dc tenendo in campo un’organizzazione di coltivatori del tutto speculare, sul piano ideologico, alla Coldiretti. Nel 1992 il presidente della Confcoltivatori Avolio approfittava del nuovo scenario politico per correggere finalmente un errore compiuto al momento dell’atto fondativo della nuova organizzazione nata nel 1977 dalla confluenza dell’Alleanza dei contadini, della Federmezzadri e dell’Uci. Di quale errore si tratta? Quello di non chiamarsi come tutte le organizzazioni di rappresentanza a vocazione generale delle agricolture nel mondo. E così, forte della denominazione finalmente corretta “Confederazione italiana agricoltori” – che evocava la Confederazione sorta con statuto democratico dalle ceneri della vecchia Confederazione fascista – Avolio poté concludere il congresso con queste parole: “È finita l’epoca degli ideologismi, nessuno può pensare di farcela da solo. Il processo unitario non può aspettare i tempi delle organizzazioni… C’è chi ha ricevuto un’eredità cospicua e ha paura di gestirne i resti, mentre noi, che abbiamo dovuto faticosamente conquistarci il diritto di essere alla pari con gli altri, ci sentiamo pronti e andremo avanti”. L’agricoltura italiana è ancora in attesa che l’appello di Avolio venga raccolto per sanare finalmente i guasti provocati dalla scissione che si consumò settantatré anni fa e passare da una condizione di debolezza ad una condizione di forza.
L’attenzione delle forze politiche, delle istituzioni e dell’opinione pubblica dovrebbe essere rivolta a questo traguardo: unificare finalmente la rappresentanza dell’agricoltura. In che modo? Si dovrebbe inserire in ogni provvedimento riguardante il sostegno alle attività delle organizzazioni dell’agricoltura una condizione inderogabile: l’organizzazione beneficiaria deve essere rappresentativa della stragrande maggioranza del settore di riferimento. E qualora vi fossero più progetti bisognerebbe indurre i proponenti a costituire un unico soggetto per accedere al beneficio.
I contenziosi post mortem
Oggi l’attenzione è rivolta non già ai profili politici della vicenda per trarne finalmente le conseguenze a vantaggio dell’agricoltura e del paese, ma esclusivamente ai contenziosi che sono sorti e che non si sono mai conclusi a distanza di ventisei anni.
Il 4 luglio 1991 fu avanzata, dai commissari nominati da Goria, la domanda di concordato preventivo, approvata nel gennaio 1992. Concordato che in seguito è stata oggetto di una lunga vicenda giudiziaria. Il Tribunale civile di Roma in data 18/22 luglio 1991, ammise in soli quindici giorni la Federconsorzi alla procedura.
La parte penale seguì due percorsi. Il primo presso il Tribunale di Roma, per i reati fallimentari inerenti alle attività svolte dagli amministratori fino al commissariamento. Gli imputati sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione, nell’udienza del 31 marzo 2008 svoltasi presso la prima sezione, dopo che era stato riconosciuto dagli stessi, un misero risarcimento danni alle parti civili costituite. Ma la Cassazione, con una sentenza depositata in data 5 marzo 2010, ha rinviato alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio di secondo grado gli ex amministratori, i sindaci e i direttori generali della holding agricola. Infatti, per la Suprema Corte, contrariamente al verdetto del Tribunale di Roma del marzo 2008, i reati non possono considerarsi estinti. L’altro percorso presso il Tribunale di Perugia, per l’attività svolta dagli organi della procedura. L’organo giudicante ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti degli imputati, unitamente alla società che aveva rilevato i beni della Federconsorzi a prezzo vile. La vicenda si concluse solo nel 2006 con la definitiva assoluzione da parte della Corte di Cassazione di Pellegrino Capaldo e di Ivo Greco. La Suprema Corte confermava quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Perugia nel settembre 2004, la quale, aveva decretato che i beni della Federconsorzi erano stati venduti ad un prezzo inferiore al loro reale valore, per cui, mancavano all’appello circa 1.100 miliardi di lire.
A distanza di anni dall’apertura della procedura non è ancora possibile prevedere quando la stessa troverà termine. Nel frattempo sul mercato finanziario secondario di Londra vi è stato un largo passaggio delle posizioni creditorie con importi veramente cospicui.
I crediti per la gestione ammassi finanziata con il Piano Marshall
I commissari nominati da Goria, con atto di citazione del 28 dicembre 1992, avanzato dinanzi al Tribunale civile di Roma ha convenuto in giudizio l’allora Ministero delle Politiche agricole chiedendo il pagamento dell’importo di 463 milioni di lire, oltre ad interessi convenzionali nella misura del T.U.S. maggiorato del 4,40 % con capitalizzazione semestrale, per crediti maturati nei confronti dello Stato a titolo di compenso per attività di gestione degli ammassi obbligatori di cereali effettuati dai consorzi agrari nel secondo dopoguerra, nell’ambito del Piano Marshall (1948-1951).
Si costituiva in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda; interveniva, in seguito, la Liquidazione giudiziale dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari a seguito dell’omologa del concordato preventivo in adesione alle richieste del Commissario governativo.
Nel frattempo, veniva varata la legge 28 ottobre 1999, n.410, recante “Nuovo ordinamento dei consorzi agrari”. L’art. 5, comma 2, stabiliva che la Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, veniva sciolta. L’art. 8 introduceva norme specifica sulla “gestione ammassi”. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, venivano estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per attuare dette disposizioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica era autorizzato ad emettere in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d’interesse, la durata, l’inizio del godimento non anteriore all’1 gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, dovevano essere stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all’entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l’anno 1999, in lire 60 miliardi per l’anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, venivano dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell’assegnazione dei titoli di Stato. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restavano privi di effetti. L’art. 9 dettava norme riguardanti il rendiconto delle gestioni di ammasso. In base a tali norme, la Federconsorzi avrebbe dovuto entro sei mesi presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.
Ma torniamo al contenzioso giudiziario. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8 novembre 2001 n. 10027/2002 rigettava le domande attrici perché inammissibili, sul presupposto che la Federconsorzi nella gestione degli ammassi aveva svolto unitamente ai consorzi agrari “funzioni di organi indiretti del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (…)”. Pertanto, secondo il Tribunale, la soluzione del pagamento sarebbe dovuta essere disposta “nell’ambito del rapporto interno o interorganico tra Federconsorzi e Stato”.
Avverso quest’ultima sentenza del Tribunale civile di Roma hanno proposto appello la Federconsorzi in persona del Commissario Governativo, nonché la liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori, mentre il Ministero delle Politiche agricole ha proposto appello incidentale.
Con sentenza n. 5020 del 2004, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda delle parti appellanti affermando che “il credito di spettanza della Federconsorzi è dunque di complessive L. 991.135.946.282 pari a € 511.878.997,39 considerando gli interessi dovuti al saldo a tiolo di interessi al TUS maggiorato del 4,40% con capitalizzazione semestrale degli stessi per il periodo dal 5 luglio 1991 al 20 giugno 2004”.
La vertenza degli ex dipendenti della Federconsorzi
A questo punto sono entrati in gioco, nel contenzioso giudiziario, anche cinquecento dipendenti della Federconsorzi licenziati a seguito del commissariamento. Ad essi era stata palesata la prospettiva di una ricollocazione nella società Agrisviluppo. Il Tribunale fallimentare, in sede di omologa del concordato, aveva infatti previsto la ricapitalizzazione di questa società da parte degli assuntori del concordato stesso (SGR). Ma poi la SGR non ha più finanziato Agrisviluppo. Questi lavoratori sostengono che il commissario governativo, che all’epoca ricopriva anche la funzione di commissario liquidatore, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione degli accordi assunti e quindi sulla ricapitalizzazione della Società Agrisviluppo e il contestuale trasferimento del personale. Sulle base di tali presupposti, gli ex dipendenti della Federconsorzi hanno citato in giudizio, presso il Tribunale civile di Roma, il ministero delle Politiche agricole e il Ministero dell’Economia per il risarcimento del presunto danno subito.
Nel frattempo, la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2004 è stata annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26159/97 del 13 dicembre 2007, che ha rinviato la causa nuovamente dinanzi alla Corte d’appello di Roma per difetto di motivazione in ordine alla identificazione delle fonti che avrebbero dovuto definire il computo del tasso di interesse moratorio applicato.
Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma dal Commissario Governativo della Federconsorzi con atto del 18 aprile 2008.
La Corte di Appello, con decisione n. 4699/2010 dell’11 novembre 2010 confermava il credito nella misura di “euro 511.878.997,39, oltre gli ulteriori interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato del 4,40% capitalizzato semestralmente maturato e maturando dal 1° luglio 2004 fino alla data dell’effettivo pagamento”, svolgendo una puntuale disamina delle ragioni e dei presupposti normativi sulla cui base detto importo è stato quantificato.
Il 9 dicembre 2010 avveniva un strano colpo di scena. Il ministro delle Politiche agricole, Giancarlo Galan, nominava l’ex magistrato della Corte dei conti, Andrea Baldanza, commissario della Federconsorzi con il compito di svolgere una ricognizione dei contenziosi (sia quello relativo alla gestione ammassi, sia quello riguardante gli ex dipendenti) e di definirli, anche in via transattiva. Ma a questo incarico non ha mai fatto seguito – per la sacrosanta opposizione di una parte considerevole del mondo agricolo – l’assegnazione di risorse per poter svolgere i compiti affidati. Tutti i tentativi di dirottare finanziamenti alla riesumata Federconsorzi sono stati prontamente sventati dall’opposizione determinata ed efficace di tutte le organizzazioni agricole che non vogliono la perpetuazione di un sistema di potere arrogante e corruttivo rappresentato dalla Coldiretti. Nonostante tale carenza, il dott. Baldanza ha proceduto comunque a transigere con le controparti senza avere nulla in mano, ma solo facendo affidamento sul fatto che lo Stato un giorno o l’altro dovrebbe trasferire i crediti alla gestione commissariale. Come ha dichiarato egli stesso nel corso dell’audizione informale in Commissione Agricoltura della Camera, il 5 ottobre 2017, si è trattato di mettere in gioco “l’aspettativa del debito dello Stato, confidando che lo Stato, se debitore, prima o poi dovrà adempiere alle proprie obbligazioni”.
Il contenzioso si è complicato perché la difesa della liquidazione giudiziale ha eccepito la violazione dei principi comunitari in tema di anatocismo, costringendo la Cassazione a rinviare la questione alla Corte di Giustizia. La quale si è pronunciata affermando che non vi è violazione dei principi comunitari nel comportamento assunto dallo Stato italiano con l’emanazione dell’art. 12, comma sesto, del decreto legge n. 16/2012, perché attinente a contratti antecedenti al 2000.
Tuttavia, la sentenza della Cassazione n. 9887 del 2016 che avrebbe dovuto chiudere la controversia, è stata adesso impugnata dagli ex dipendenti perché ometterebbe il richiamo alla normativa introdotta nel 2012.
L’emendamento Gallinella
A questa vicenda fa riferimento l’emendamento presentato in questi giorni dai parlamentari del M5S (primo firmatario l’on. Gallinella) in occasione della discussione sulla legge di stabilità: “In ordine ai crediti spettanti alla Federconsorzi e maturati nei confronti dello Stato a titolo di compenso per l’attività di gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli entro sei mesi il Ministero delle Politiche agricole provvede a liquidare le pendenze in essere tra il personale ex dipendente e la Federazione. A conclusione del processo di liquidazione di cui sopra, i crediti si considerano estinti”.
I parlamentari grillini propongono una norma che vorrebbe rispondere positivamente alle aspettative dei lavoratori. Ma non si rendono conto che, cedendo a tale pressione, di fatto aprono la stura al riconoscimento di crediti di settanta anni fa che andrebbero agli stessi soggetti che hanno portato la Federconsorzi al disastro. Sarebbe più sensato non legare le aspettative dei lavoratori con i presunti crediti per la gestione degli ammassi. Questi signori hanno diritto ad un risarcimento? Un giudice ha accertato che chi doveva ricollocarli dopo il licenziamento non lo ha fatto e che un organo dello Stato doveva vigilare perché questo avvenisse e non ha fatto il proprio dovere? Bene. Provveda lo Stato a risarcire il danno direttamente. Si proponga un emendamento che riconosca questo diritto. Ma cosa c’entrano gli ammassi di settanta anni fa con una condotta omissiva che si è consumata venticinque anni fa? Perché riesumare a tutti i costi un’organizzazione economica morta e sepolta da un quarto di secolo? Perché pagare onorari e strutture a gestioni commissariali del tutto inutili? Ci aspetteremmo dal M5S posizioni radicali e capaci di distinguere le soluzioni volte a fare giustizia dalla perpetuazione di un sistema di potere corruttivo, arrogante e distruttivo.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

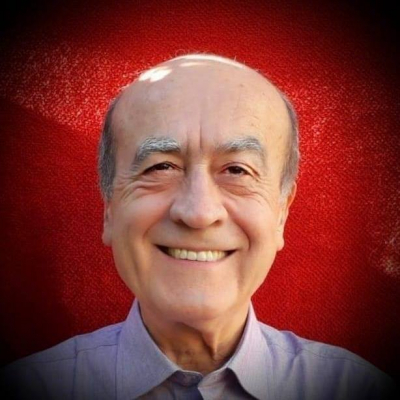
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.