Per un’economia non autarchica
E’ penoso e ignobile che s’insinui un odioso pregiudizio: l’idea che l’olio e le olive degli altri Paesi che s’affacciano sul Mediterraneo siano di per sé scadenti. Le multiformi identità hanno tutte pari dignità. Nessuna possiede, sul piano simbolico, uno spessore culturale che sovrasta l’altra

Oggi, giovedi 23 gennaio 2014, alle ore 18 c’è l’inaugurazione della terza edizione di Olio Officina Food Festival. Tra i tanti relatori che presenzieranno alla tre giorni milanese, vi è lo storico dell’agricoltura e saggista Alfonso Pascale. Per riattualizzare il suo pensiero, proponiano ai lettori di Olio Officina Magazine quanto Pascale ha pubblicato sul primo numero di olio officina almanacco, volume pubblicato lo scorso anno proprio in occasione del festival. Alfonso Pascale sarà presente al festival il pomeriggio di venerdi 24 gennaio, con due interventi, occasione buona anche per presentare il suo ultimo lavoro editoriale, Radici & Gemme.
Per un’economia civile e non autarchica dell’olio d’oliva
Nel 2011 abbiamo consumato in Italia 730 mila tonnellate di olio d’oliva per un valore di 3 miliardi di euro e ne abbiamo esportato 400 mila tonnellate per un miliardo e duecento milioni di euro soprattutto negli Stati Uniti, in Germania e in Francia. Ma la produzione si è attestata solo intorno a 500 mila tonnellate per un valore di un miliardo e trecento milioni. Il tasso di autoapprovvigionamento è pari al 70 per cento. E’ per questo motivo che importiamo molto olio, soprattutto dalla Spagna: le importazioni riguardano 640 mila tonnellate di prodotto pari a un miliardo e duecento milioni di euro.
Nei prossimi anni, nuovi consumatori di olio d’oliva si affacceranno sulla scena mondiale. Saranno soprattutto cinesi, brasiliani e nord-americani ad aggiungere questo condimento sulle vivande delle loro tavole.
Coi numeri che ho ricordato e con le prospettive nuove di mercato che si aprono, è dunque una follia la guerra che si è ingaggiata ultimamente contro l’olio straniero e le sue patrie. Potremo, infatti, in futuro accrescere notevolmente le esportazioni ma difficilmente si aumenterà in modo significativo la produzione di olive. Perché allora provocare un’insensata avversione verso i prodotti provenienti da altri paesi quando abbiamo l’impellente necessità di importare olive e olio per poter mantenere e migliorare le nostre performance?
Se malauguratamente gli italiani dovessero davvero farsi convincere che è buono soltanto l’olio tricolore mentre è da scartare quello prodotto in altri paesi oppure fabbricato in Italia con olive raccolte in Marocco o in Tunisia, dovremmo ben presto abituarci all’idea che questo condimento venga sostituito da altri prodotti. E ci troveremmo così in presenza di una brutta mutazione delle nostre abitudini alimentari e di una ferita insanabile inferta alla cultura culinaria italiana.
In sostanza, anche volendo affrontare il tema con un approccio prettamente utilitaristico, la parola d’ordine “olio tutto italiano” appare una sorta di istigazione al suicidio collettivo.
La questione riveste, tuttavia, un’importanza sia economica che culturale e andrebbe affrontata con un approccio al mercato da cui emergano anche i profili etici e civili.
Trovo, innanzitutto, penoso e ignobile che s’insinui soprattutto nei nostri ragazzi – così come sta accadendo mediante programmi di comunicazione e promozione impropriamente finanziati dal pubblico – un odioso pregiudizio: l’idea che l’olio e le olive degli altri paesi che s’affacciano sul Mediterraneo siano di per sé scadenti. E che lo stigma sia inculcato magari in presenza di ragazzi i cui genitori sono originari proprio di quei paesi. Un’umiliazione inflitta a questi nostri nuovi concittadini senza una qualche plausibile giustificazione, specie ora che l’Italia diventa sempre più multietnica.
L’atto del mangiare ha, infatti, costituito da sempre un veicolo di pratiche e dispositivi culturali, capaci di fornire una rappresentazione dei mondi altri. Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare tra culture diverse aprendo i sistemi di cucina ad ogni sorta di invenzioni, incroci, sincretismi, ibridismi e contaminazioni. Conoscere le culture alimentari di un gruppo e scambiare i cibi può, dunque, costituire una pratica che favorisce l’integrazione. Senza sminuire l’importanza delle tradizioni locali e delle pratiche ricostruttive di radici più o meno inventate – essenziali per il nostro equilibrio biologico e psicologico -, sono convinto che educare a un’alimentazione autarchica e chiusa agli scambi con altre culture, significa negare in radice l’assunto di fondo della nostra cultura del cibo.
L’idea che una specie alimentare del mio giardino sia più buona di un ortaggio che arrivi da terre lontane non appartiene alla nostra storia alimentare. Non era mai accaduto che il cibo costituisse un elemento identitario così forte da essere utilizzato per definire un confine invalicabile tra sé e i “barbari” che ci minacciano. Se guardiamo alle nostre tradizioni culinarie si trova sempre un atteggiamento di grande apertura e curiosità nei confronti di qualsiasi specie esotica. E questo non solo nelle mense dei ricchi ma anche in quelle dei poveri. Osserva, infatti, lo storico Jean-Louis Flandrin che se i processi di adozione di alcuni alimenti arrivati in Italia da altre parti del mondo appaiono abbastanza lunghi, non lo si deve necessariamente al fatto che le persone del popolo siano meno aperte delle élites sociali ai nuovi cibi: si dà semplicemente il caso che le fonti documentarie sono meno attente al cibo dei poveri che a quello dei ricchi. E il medievalista Massimo Montanari aggiunge che il concetto di “tipicità” solo recentemente ha acquisito l’importanza che oggi gli viene attribuita: in passato, il luogo d’origine di un alimento ha sempre contato pochissimo.
La nostra alimentazione – come afferma l’antropologo Vito Teti – presenta stratificazioni e sedimentazioni originatesi in epoche storiche e in spazi geografici lontani; è riflesso e testimonianza di arrivi, passaggi, incontri, commistioni, fluttuazioni, intensi dialoghi con il mondo mediterraneo, l’Oriente, l’Europa continentale e le Americhe. Insomma, le radici della nostra identità alimentare si diramano molto lontano da noi.
Con l’avvento della globalizzazione ci è sembrato che il cibo potesse subire un processo di appiattimento. La cucina di McDonald’s ha interpretato l’emblema alimentare del villaggio globale: la grande M uguale dappertutto, rassicurante, materna, rotonda come un seno. E saggiamente abbiamo reagito a questo fenomeno valorizzando le diversità. La normativa europea sulle denominazioni d’origine ci ha voluto rammentare che le identità possono essere molteplici. Il cittadino di Matera (che si riconosce nel cibo della sua città e delle sue campagne) non è solo un membro del villaggio globale ma è anche cittadino di Basilicata, d’Italia, d’Europa. E ciascuna di queste identità – tutte mutevoli e in costruzione – vuole i suoi simboli alimentari.
Ma queste multiformi identità hanno tutte pari dignità. Nessuna possiede, sul piano simbolico, uno spessore culturale che sovrasta l’altra. Anzi convivono pacificamente e vanno sempre più a integrarsi e completarsi a vicenda. Basti pensare alla messa in rete e allo scambio delle biodiversità a livello globale, alla creazione dell’hamburger vegetariano o del panino McItaly firmato da Gualtiero Marchesi oppure ancora dell’olio extra vergine d’oliva Primissimo prodotto da Monini in Australia.
Solo da noi la cultura della tipicità, da strumento di affermazione del pluralismo delle identità, viene esasperata fino al punto di trasformarla in arma con cui tentare di difendersi nella competizione globale. Da strumento per far convivere identità diverse, la tipicità è diventata elemento scatenante di conflitti tra chi ritiene di affermare l’identità e chi viene accusato di volerla annientare, tra chi presume di tutelare la vera ed unica identità e chi viene tacciato come il paladino della non-identità.
Si è venuto, in sostanza, a delineare un neonazionalismo autarchico che pretende di tutelare una malintesa italianità, frutto del raggrumarsi di subculture che rispondono impaurite e rabbiose alla globalizzazione e ai nuovi equilibri mondiali, in cui emergono paesi con un tasso di crescita prima inimmaginabile. Un neonazionalismo autarchico che esclude ogni collaborazione con le agricolture di altri Stati, considerate come nemiche da combattere, e preme ostinatamente sulle istituzioni perché si riprendano quella sovranità nazionale che un tempo si era disposti a sacrificare per l’obiettivo di un ideale collettivo europeo. Il tutto condito di una diffusa avversione alla scienza, dettata spesso da timori egoistici e paure millenaristiche; avversione che impedisce l’innovazione.
L’innovazione, infatti, non si fonda sullo scambio di prodotti autarchicamente pronti e finiti, ma sullo scambio di idee. E’ per questo che oggi si tende a definirla come innovazione sociale. Solo mettendo insieme le idee, partecipando culturalmente a un processo e integrando apporti scientifici multidisciplinari, riusciamo a realizzare un prodotto di uso collettivo.
Si tratta di mettere in piedi progetti commerciali per l’olio d’oliva che vedano la partecipazione di produttori e operatori italiani e di altri paesi del Mediterraneo, accomunati dalla volontà di aggiungere allo scambio economico anche un livello di negoziazione aggiuntiva, fondata sulla dimensione civile. L’obiettivo dovrebbe essere quello di riconoscere una quota di valore agli olivicoltori, specie quelli dei paesi più poveri del nostro, che sia remunerativa e di assicurare risorse per investimenti che permettano una loro maggiore inclusione nei mercati, affrontando gli aspetti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza del lavoro relativi alla produzione delle olive e dell’olio.
Progetti innovativi di questo tipo riscuoterebbero senz’altro l’interesse dei cittadini, che potrebbero così farsi parte attiva e responsabile nella realizzazione dell’obiettivo, diventando acquirenti consapevoli di un olio d’oliva garantito innanzitutto dalla qualità delle relazioni tra tutti i partecipanti allo scambio economico: produttori, trasformatori, distributori e consumatori che collaborano indipendentemente dal paese in cui si trovano. E’ in tal modo che i processi economici diventano economia civile.
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

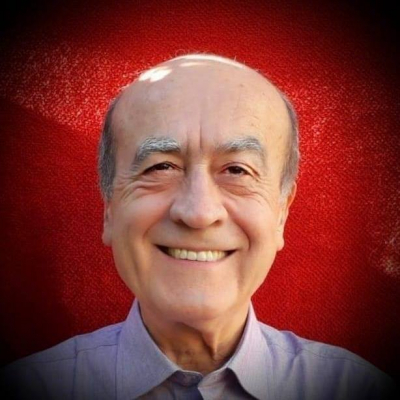
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.