La distribuzione moderna del cibo. Il secondo dopoguerra
Cosa comporta l’arrivo del frigorifero nelle case degli italiani? Si rivoluziona, per sempre, il modo di fare la spesa e di consumare i prodotti, comportando nuovi approcci da parte del settore agricolo. Anche lo sviluppo dell’industria alimentare, nel suo più ampio significato, modella i nostri atteggiamenti: lo spuntino, la pausa, i pasti fuori casa. Questi scenari sono mutati anche per la forte presenza pubblicitaria, capace di arrivare al cliente e inculcargli figure e modelli da seguire. Ma per capire questo bisogna partire dal secondo dopoguerra, quando l’intera società ha cominciato un lento e progressivo cambiamento [2. continua]

A partire dal secondo dopoguerra, in vaste aree del Paese, si modifica completamente il modo di mangiare.
All’origine del fenomeno c’è l’esodo biblico dalle campagne.
Gli addetti agricoli erano ancora 8,6 milioni nel 1951. Scendono a meno di 5 milioni dopo dieci anni.
Tra il 1951 e il 1971 le campagne perdono 4,4 milioni di agricoltori, ma guadagnano 1,9 milioni di operai, impiegati e artigiani.
Si crea in realtà un circolo virtuoso: le aziende agricole figlie della riforma agraria del 1950, per accrescere la produttività, investono in mezzi tecnici.
Il “piano dodecennale” del 1952 prevede prestiti e mutui per l’acquisto di macchine agricole.
Anche per effetto di questa nuova domanda di trattori e fertilizzanti, l’industria si espande in tutti i settori e utilizza una quantità enorme di mano d’opera proveniente dalle campagne.
Perciò, ogni anno, 260 mila contadini lasciano l’agricoltura.
Negli anni Sessanta diventano 314 mila quelli che ogni anno vanno via. Sono decine e decine di migliaia anche coloro che di continuo sono assunti in settori diversi da quello agricolo pur restando in campagna.
Per la prima volta incomincia a scarseggiare la mano d’opera agricola e aumenta così il costo del lavoro. L’esigenza di produrre di più e la minore disponibilità di braccia portano verso l’integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.
Soprattutto nel Mezzogiorno, l’esodo è imponente. Tra il 1955 e il 1970 sono tre milioni le persone che spostano la residenza dal Sud in un comune settentrionale.
E si tratta per lo più di uomini e giovani, tutti o quasi provenienti dall’agricoltura.
È un’emigrazione definitiva che non lascia nulla dietro di sé nelle regioni d’origine, se non profonde contraddizioni sul piano dei modelli culturali.
Emigrando a Milano, Genova Torino e in altri agglomerati urbani del “triangolo industriale”, i “cafoni” del Sud devono affrontare un difficile adattamento, che investe i rapporti di lavoro, quelli tra i sessi, le concezioni della famiglia, del tempo libero, dell’abitazione, della salute, del denaro.
La varietà delle forme di adattamento produce compromessi e traumi culturali, che si riflettono negativamente anche nei luoghi di origine a seguito dei continui rapporti tra gli emigranti e i loro congiunti.
Sicché, nelle realtà meridionali, spesso prende forza un’idea distorta e mitizzata di modelli culturali inesistenti, il miraggio di un “paese di cuccagna” che incentiva oltre misura l’ulteriore fuga dalle campagne.
Soprattutto giovani donne spingono i ragazzi a partire e si mostrano ben disposte ad accompagnarli.
Dicono che non sposerebbero mai e poi mai un morto di fame e si scambiano questa opinione tra di loro.
Quando i fattori attrattivi che vengono dall’esterno si mescolano al senso di colpa provato dalla frustrazione di aver corroso il proprio destino, si realizzano i percorsi di memoria spezzata, doppia assenza legata al sentimento di sentirsi privati del qui e dell’altrove.
La mentalità degli operai
Se si scorrono le storie di vita raccolte da Franco Ferrarotti in collaborazione con Pietro Crespi in “La parola operaia – Cento anni di storia di vita operaia (1892-1992)” si ritrovano brani che fanno emergere una cultura di fabbrica fortemente intrisa di solidarismo rurale: “Qualche volta ripenso alla vita che facevo nella mia vita contadina e devo dire che sento un po’ di nostalgia […] Era una vita libera, aperta, con tanta solidarietà; ci si conosceva tutti, qualunque cosa fosse successo erano tutti solidali. Il contadino che andava in fabbrica conservava la sua tradizione fin che poteva, non c’era frattura fra mondo contadino e mondo operaio”.
E a commento di queste testimonianze i ricercatori affermano: “I gruppi operai italiani sono fortemente radicati nella realtà contadina e, anzi, trovano puntualmente nelle specifiche situazioni locali e nell’ambito familiare quella base d’identità e quella sorta di ammortizzatore segreto delle crisi sociali ad ampio raggio, che in altri contesti sociali e storici hanno dato luogo ai noti fenomeni di sradicamento e di alienazione operaia”.
Questa caratteristica della mentalità operaia in Italia si era già manifestata nella seconda metà dell’Ottocento.
A segnalarlo era stata la reinvenzione della tradizione degli orti negli interstizi dei grandi complessi edilizi da parte dei contadini immigrati nelle città.
Spesso erano le aziende o gli istituti delle case popolari a promuovere quella tradizione per soddisfare un bisogno di comunità che la vita urbana tendeva a sfaldare.
I modelli di riferimento venivano da altri Paesi europei dove amministratori comunali o piccoli industriali affrontavano il problema della povertà.
In Germania, questi orti erano stati chiamati “Armengärten” (orti dei poveri) perché i lotti venivano assegnati agli indigenti e ai senza tetto.
A Lipsia, i “Kleingärten” erano, invece, riservati ai bambini. Ma la peculiarità di tali pratiche era emersa in Francia coi “jardins ouvriers” (giardini operai) sorti dall’attività di mons. Jules Lemire, non solo uomo di chiesa, ma anche professore e politico di grande statura.
Negli anni Trenta del Novecento erano stati poi promossi gli “orticelli di guerra”, nel quadro della “battaglia del grano” e della ruralizzazione forzata degli italiani che Mussolini perseguiva.
Anche l’America aveva conosciuto l’esperienza dei “relief gardens” (orti di soccorso) e durante la seconda guerra mondiale quella dei “victory gardens” (orti della vittoria).
La tradizione degli orti urbani subisce un declino nel secondo dopoguerra perché considerata una vera anomalia.
L’orto in città diventa il simbolo di una condizione sociale ed economica inferiore, un elemento di degrado paesaggistico. In quegli anni impera l’esecrazione per ogni forma di economia domestica.
Nascono altri modi di impiegare il tempo libero. Non solo la televisione ma anche le ferie.
Alla rispettabilità sociale e familiare conferita da un orto o un giardino ben tenuto, si sostituisce quella del “mese al mare”, ovviamente incompatibile con il mantenimento di un orto.
L’autoconsumo si trasforma
Anche nei comuni rurali, i piccoli appezzamenti destinati all’autoconsumo si riducono drasticamente.
Gli annuari dell’Inea stimano il peso dell’autoconsumo sulla produzione lorda vendibile in Italia intorno al 37% nel 1951 e pari al 19% nel 1960.
L’interpretazione di quei dati risente del vezzo intellettuale, tutto italiano, di disprezzare il lavoro manuale, ritenuto un pesante fardello ancestrale di cui sbarazzarsi.
E dunque meno autoconsumo alimentare assume necessariamente il significato di maggiore progresso.
Le “Indagini sui bilanci familiari (1963-64)”, pubblicate dalla Cee, ci dice, invece, che in Europa la situazione è diversa.
La presenza di un orto o di un piccolo allevamento è segnalata soltanto dal 20% degli operai e dal 9,2% degli impiegati italiani, per un totale 17%, a fronte del 47% in Francia e del 45% in Germania federale.
È importante quella rilevazione perché ci dice anche chi compone quel 17%.
Non sono ancora gli hobbisti che emergeranno negli anni Ottanta e Novanta con percentuali del 34,2% (1995) e del 39,3% (2000), ma operai-contadini (o impiegati-contadini), ossia lavoratori part-time, occupati in fabbrica che continuano ad essere dotati di una sia pur minuscola azienda agricola.
La rilevanza dell’autoconsumo (e soprattutto la sua metamorfosi) in Italia non interessa a nessuno.
Se ne trova solo un accenno in un documento parlamentare del 1977, prodotto dall’economista agrario e deputato Giuseppe Orlando che, non a caso, era stato il curatore dei gloriosi annuari dell’Inea.
Si attribuisce al fenomeno il 5% appena.
Non si ha la percezione che non è più solo l’autoconsumo di miseria o di propensione al risparmio, ma è anche quello di relativo benessere o di libera opzione alimentare.
Lo spartiacque è segnato dal raggiungimento delle 3 mila calorie medie per abitante nel 1968.
L’autoproduzione di cibo che in Germania e in Francia è già pienamente espressione – tra gli anni Cinquanta e Sessanta – di passatempo per i ceti benestanti, anche in Italia comincia pian piano a trasformarsi radicalmente.
Bottegai e grossisti
Molti contadini che lasciano le campagne per emigrare nelle città danno vita a piccoli negozi alimentari, contribuendo a irrobustire numericamente il commercio al dettaglio.
A incentivarlo provvede la legge Lombardo del 1949, che abolisce la legge mussoliniana del 1926.
Da questo momento, fino al 1971, chiunque può intraprendere un’attività economica, quindi anche commerciale, senza necessità di alcuna autorizzazione.
È sul rapporto di fiducia fra negoziante e cliente che si basa la garanzia della salubrità e freschezza dei prodotti, nonché l’informazione sulle caratteristiche nutrizionali ed eventualmente innovative di determinati alimenti.
È inoltre lo stesso negoziante che provvede al frazionamento e al confezionamento del prodotto alimentare venduto al banco.
Nel 1960, il 95 per cento del totale del commercio al dettaglio effettuato in Italia si svolgeva in negozi di tipo tradizionale contro una media europea del 79 per cento.
Tra il 1961 e il 1968, mentre in Francia il numero di negozi di minuiva del 10 per cento, in Italia aumentava dell’8.
Nel 1951, in Italia, esistevano 316 mila negozi alimentari, che dieci anni dopo salivano a 385 mila e, nel 1965, a 427 mila.
Nel 1977 l’Italia poteva “vantare” un numero di esercizi alimentari quattro volte superiore a quello della Germania.
Le cause di questo fenomeno sono essenzialmente socio-politiche.
Il ceto degli esercenti – tutelato da misure protezionistiche che hanno mortificato lo spirito d’iniziativa e impedito la libera concorrenza – ha funzionato da ammortizzatore sociale in senso anticiclico.
Esso ha costituito una riserva di manodopera in grado di espandersi o di contrarsi a seconda della congiuntura: nelle fasi di recessione, assorbendo i lavoratori in eccesso del sistema produttivo; nelle fasi di espansione, fornendo un serbatoio di forza-lavoro.
All’epoca del boom economico, Giorgio Bocca annotava al riguardo: “Certi italiani quando non sanno proprio cosa fare, non avendo titoli di studio, un mestiere, una tradizione, ebbene allora aprono un negozio. Anche i peggiori della grande fuga contadina, quelli che non ce la fanno o non se la sentono di entrare in fabbrica, si mettono a fare gli ambulanti di frutta e verdura o di fiori o i magliari con la prospettiva luminosa di aprire prima o poi il negozietto di alimentari, tre cavoli quattro pesche, cinque scatole di detersivo, un po’ di scatolame e lo squallore dei luoghi da cui è assente l’abbondanza”.
In tale contesto diventa cruciale il ruolo dei mercati all’ingrosso.
Questi stanno a metà strada tra le tante aziende agricole sparse nelle campagne e la presenza diffusa dei dettaglianti negli 8 mila comuni d’Italia.
E hanno il compito di concentrare i prodotti in termini quantitativi e di predisporre l’assortimento desiderato dai commercianti.
Sono quest’ultimi infatti che interpretano le richieste dei consumatori. In questo modo, lo scambio è più efficiente.
Con il commercio all’ingrosso si evita la dispersione dei contatti, ciascuno di scarsa rilevanza economica.
Ma il grossista non fa altro che sopperire alla difficoltà, da parte dei tanti produttori e dei numerosi dettaglianti, di conoscere e selezionare gli sbocchi distributivi o i mercati di approvvigionamento.
Insomma il grossista si sostituisce al produttore e al negoziante nel processo decisionale.
Certo, alleggerisce questi di un problema, ma li spoglia anche di un’opportunità, ammesso che desiderassero davvero, chi da una parte e chi dall’altra, minimamente organizzarsi.
Negli anni Cinquanta e fino alla metà degli anni Sessanta, la nostra industria alimentare è ancora molto debole.
E in Italia non esiste per nulla la grande distribuzione, che invece negli Stati Uniti è già in pieno sviluppo.
È solo successivamente che inizia un lento ma progressivo trasferimento della trasformazione alimentare dall’agricoltura all’industria.
Sono infatti aumentati i redditi e nascono più bambini. Inoltre, scongiurato ormai lo spettro della fame, i consumatori iniziano a chiedere qualcosa in più del semplice nutrimento.
Il tradizionale pasto in famiglia è sempre più riservato solamente alla sera.
A mezzogiorno si mangia in mensa o si consuma qualcosa di rapido al bar o in un fast food.
Il nuovo ruolo della donna fa aumentare fortemente la domanda di prodotti ad alto contenuto di servizio: dai legumi secchi pronti per la cottura alle pizze surgelate, dalla polenta precotta all’insalata già lavata e tagliata.
È tutta una gara da parte dell’industria per abbreviare i tempi della preparazione di cibi “freschi” in casa.
Nasce, nel frattempo, il Tetrapack, usato soprattutto per il confezionamento del latte a lunga conservazione, e grossi miglioramenti si hanno nella conservabilità e nel packaging per porzioni individuali: novità che sono alla base di un nuovo modo di fare shopping, a scadenze meno ravvicinate nel tempo.
Nel frattempo, nel 1963 viene emanata la legge sanitaria sul confezionamento degli alimenti che diventa operativa nel 1967: questa normativa introduce l’obbligo della vendita in confezioni per prodotti come riso, pasta, zucchero, farina, latte, olio, burro, biscotti, fino a quel momento venduti prevalentemente sfusi.
Arriva il frigorifero nelle case
A influire sulle abitudini alimentari degli italiani è l’avvicendarsi, in cucina, di una serie di accessori tecnologici indispensabili: prima il frigorifero, poi il frullatore, quindi il fornetto elettrico, la pentola a pressione e il forno a microonde.
Nel 1951, l’Italia produceva 18.500 frigoriferi, nel 1957 370 mila e nel 1967 la bella cifra di 3 milioni e 200 mila.
E se diamo un’occhiata ai modelli di frigorifero più venduti nei diversi periodi, ci rendiamo anche conto di come i prodotti surgelati siano diventati gradualmente una componente importante della spesa alimentare delle famiglie.
Fino alla fine degli anni Sessanta, era presente nell’apparecchio un unico sportello, attraverso cui si poteva al più accedere ad una sorta di strapuntino, il congelatore, in cui la temperatura era più bassa che nel resto del vano e in cui avrebbero potuto trovare posto due o tre scatole di cibo surgelato.
Negli anni Settanta, i freezer avevano un loro sportello apposito posto sopra quello della zona frigorifero.
Ma la dimensione del vano dedicato ai prodotti sottozero era ancora di gran lunga inferiore a quello destinato al cibo usuale.
Solo da qualche decennio, il congelatore sta di norma sotto il frigorifero, ma ha un volume se non pari almeno paragonabile a quello del comparto sopra lo zero.
La comparsa del frigorifero dentro le nostre case segna simbolicamente la fine dell’era che vedeva l’agricoltura soddisfare direttamente i bisogni alimentari della popolazione.
E l’inizio di quella in cui il primario diventa un settore a “domanda derivata”: gli agricoltori forniscono la materia prima, mentre i cibi che arrivano sulle tavole delle famiglie sono sempre più frequentemente prodotti industriali.
È così che si dissolve progressivamente – con lo sviluppo tecnologico, economico e sociale – quell’economia rurale, fondata sul protagonismo di un mondo agricolo capace di occuparsi di tutto, dalla produzione al consumo dei prodotti agroalimentari.
Un’economia che si frantuma in diverse attività decentrate corrispondenti alle differenti fasi: produzione, trasformazione, distribuzione e consumo. Per descrivere quel processo avvenuto in agricoltura, il tecnologo ed economista Umberto Bertelè conia l’espressione “disintegrazione verticale”.
Concorrono, dunque, alla funzione alimentare più settori economici altamente specializzati e fortemente interdipendenti tra loro.
E il peso economico e sociale che prima era appannaggio quasi esclusivo dell’agricoltura, adesso viene condiviso da questa con l’industria e la distribuzione.
Il potere tende a trasferirsi verso chi è più vicino alla domanda finale.
E così l’agricoltura è indotta a organizzarsi per evitare di diventare del tutto dipendente dall’industria e, successivamente, dalla distribuzione.
L’industria alimentare influenza il modo di mangiare
Per capire cosa ha significato lo sviluppo dell’industria alimentare nei modi di pensare e nelle abitudini degli italiani, basta fare riferimento ad un caso esaminato nell’ambito degli studi semiotici sulla pubblicità condotti da Dario Mangano e Gianfranco Marrone.
L’ex garzone pasticcere di Gessate vicino Milano, Angelo Motta, appena tornato dalla Grande Guerra, si era messo in proprio nella centrale via della Chiusa del capoluogo lombardo.
Aveva modificato l’impasto e la lievitazione di un tipico dolce milanese, rendendolo più alto e più soffice.
E così il suo panettone era stato venduto con grande successo in tutti i negozi sotto Natale.
Poi era giunta la seconda guerra mondiale coi suoi lutti e distruzioni.
E per venir fuori dai marosi di quel tragico evento, Motta si affidò ad un manager, Alberto Ferrante, laureato in economia e commercio alla Bocconi ed ex segretario generale della Camera di Commercio di Milano, che impostò la politica di espansione e di produzione di massa dell’azienda.
Il segreto fu l’invenzione della merendina. Fino a quel momento si era parlato solo di merenda, quella che non era fatta con prodotti industriali.
Per la merenda erano invece utilizzati alimenti che si potevano trovare nei principali pasti della giornata, come il pane, a cui associare il formaggio, la marmellata, l’olio, il burro o semplicemente una spolverata di zucchero.
Quello che era richiesta a questa aggiunta ai pasti era infatti energia, secondo la concezione dietetica dell’epoca.
E per questo la merenda era destinata soprattutto ai più piccoli, ritenuti quelli più bisognosi di colmare la presunta carenza energetica.
Nel 1950, l’azienda dolciaria di Milano inventò il “Mottino”, versione miniaturizzata del tradizionale panettone.
Un prodotto nuovo, il cui nome, nell’immaginario collettivo, passò come la merendina confezionata per antonomasia.
Nel 1953, il “Buondì” prese il posto del “Mottino”.
E nel 1973 fu la volta di “Girella”, il rotolino di pan di Spagna farcito con crema al cacao.
La merenda aveva trovato il suo senso, anche etimologico, nell’idea di ricompensa dopo lo studio o il lavoro (in latino “mereo” significa “meritarsi”) e aveva sancito la differenza tra ordinario e straordinario, adulto e bambino, tavola e altri luoghi di consumo (corridoio della scuola, cortile di casa o il giardino).
Il prodotto industriale invece trasformò il fuoripasto in un’abitudine diffusa, una pausa da prendere in qualunque momento e a cui ognuno, grande o piccolo che fosse, avrebbe dovuto aspirare.
È stata la comunicazione pubblicitaria legata al prodotto industriale a moltiplicare i contesti d’uso e le forme di consumo, elaborando nuovi significati riferiti a comportamenti individuali o di gruppo, rituali e stili alimentari più vari e più ricchi.
Fino a reinventare, inconsapevolmente, tradizioni contadine come i continui spuntini, consumati spesso velocemente e in grande solitudine nelle pause dei lavori agricoli: “lu mozzëgu” (pane e salumi o altro companatico) o “pane e coltello” (pane “asciutto”).
Rispetto agli altri Paesi europei, l’industria alimentare italiana rimane complessivamente caratterizzata dalla presenza di numerose imprese artigianali con mercati di sbocco locali.
Solo in pochissime aree del Paese (soprattutto al Nord) si avviano intensi processi di concentrazione.
E questa caratteristica dell’industria alimentare è il motivo del ritardo con cui decolla la grande distribuzione organizzata.
Questa è in mano prevalentemente a grandi gruppi spesso a partecipazione statale, come Montedison-Standa, Ifi Fiat-Sma, Sme Iri, con scarsa esperienza nella distribuzione moderna e alti costi di gestione.
Nascono così negli anni Settanta e si sviluppano fino alla fine degli anni Ottanta gruppi di acquisto, unioni volontarie e cooperative di consumatori.
Ma questa è una storia che merita un capitolo a sé.
[Prossima puntata: La distribuzione moderna del cibo. La cooperazione di consumo]
Leggi anche la prima puntata: La distribuzione moderna del cibo. Gli albori
In apertura, foto di Olio Officina©
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

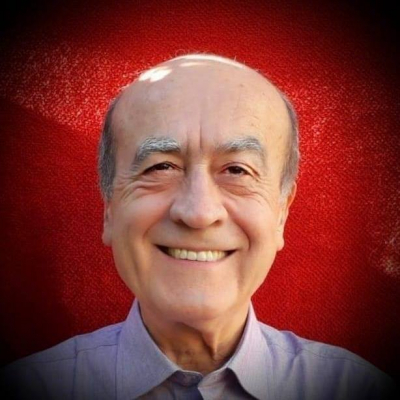
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.