Operai e contadini non vi capiscono di Vladimir Majakovskij è un libretto di una cinquantina di pagine che contiene due articoli del poeta, scrittore, drammaturgo, pittore, cartellonista e giornalista russo nella traduzione di Amedeo Anelli, direttore della rivista “Kamen’” e curatore del volume, con il testo in russo a fronte. Lo ha pubblicato, nell’ottobre 2025, Bibliotheka Edizioni.
Il titolo si riferisce all’accusa che rivolgevano al poeta i pochi che sapevano leggere e che compravano i biglietti delle prime file, le più costose, per ascoltare le poesie recitate nei teatri dall’autore. Ma, in realtà, scrive Majakovskij, i contadini e gli operai affollavano le letture pubbliche. E una volta, nella fabbrica metallurgica Schmidt della Transcaucasia, gli ottocento operai, alla fine della lettura, votarono per attestare la piena comprensione delle opere. Fu il comitato di fabbrica a stendere l’attestato con queste parole: “Hanno votato sì tutti, tranne uno, il quale ha voluto precisare che le opere, recitate dall’autore, gli sembravano più chiare di quando le avesse lette da sé”. Quell’uno era il contabile.
Dopo la sua morte, Majakovskij fu definito da Stalin “il poeta migliore e di maggior talento della nostra epoca sovietica”. Ma l’intellettuale non era stato semplicemente il cantore del regime, come sembrerebbe emergere dal giudizio lusinghiero del dittatore. Aveva interpretato “gli ideali palingenetici dell’avanguardia russa del tempo e del messianesimo proprio di un certo simbolismo”, come ricorda Amedeo Anelli nell’introduzione. Aveva rinnovato non solo il linguaggio artistico e poetico del tempo, ma l’intero sistema delle arti e della comunicazione. Aveva posto in modo drammatico problemi scottanti sul ruolo degli intellettuali nei rapporti con la società e con il potere dominante. Non era, tuttavia, riuscito a sopportare quello che ad un certo punto apparve sempre più chiaro dinanzi ai suoi occhi: il fallimento degli ideali che lo avevano mosso nel sostenere attivamente la rivoluzione bolscevica. Una crisi che lo condusse al suicidio all’età di 37 anni.
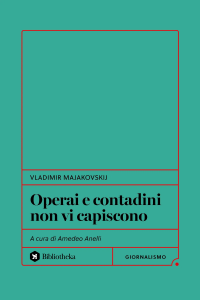
Il problema principale che il poeta si poneva era come comunicare ad una popolazione che, per la maggior parte, era semianalfabeta. Egli non si giovava solo delle tecniche dei futuristi russi. Attingeva a temi di derivazione biblica e propri dello spiritualismo bergsoniano. Il suo linguaggio era iperbolico, ricco di metafore, sorprendentemente ironico e sarcastico. Per lui la parola doveva colpire, persuadere, convincere nel profondo.
“Noi giornalisti siamo spesso colpevoli della svalutazione del nostro lavoro”, scrive sulla rivista “Žurnalist”. Era un invito ai giornalisti a non sopravvalutare eccessivamente gli scrittori incapaci di comunicare. Essi non andavano recensiti e magnificati con reportages e bibliografie. C’era una responsabilità sociale dell’intellettuale da valorizzare qualora si manifestava. Altrimenti, occorreva “riconsiderare gli scrittori, qualunque (fosse) il loro strumento verbale, secondo il criterio del senso sociale”. E si chiedeva: “Dopo questa riconsiderazione non bisognerà discernere il bianco dal nero?”.
Attenzione, però! Majakovskij non proponeva un’arte “di massa”, ma l’esercizio dell’“analisi critica” per capire come avvicinare le “masse” all’arte, come predisporne la comprensione tra gli operai e i contadini. E ragionava sui problemi editoriali, l’organizzazione delle biblioteche e delle librerie, il costo dei libri, l’accesso ai classici.
Per il poeta, le “masse” dovevano essere “accompagnate” nell’accedere ai libri e così avrebbero compreso il loro contenuto, senza la necessità di semplificare e banalizzare la produzione artistica.
Chissà che, al tempo dei social e dell’analfabetismo di ritorno, le riflessioni del poeta russo non siano di una qualche utilità per affrontare i nodi attuali della comunicazione?









