Corso Italia 7
Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi
Novembre
Il sole, affaticato, vuole dichiarare forfait, la natura si lascia andare al riposo stagionale, e per gli umani sopraggiunge il pensiero pauroso del riposo “eterno”. Rendiamo dunque grazie a Novembre e alla poesia, perché insieme con i pensieri e i riti religiosi ci offrono la possibilità di riflettere e meditare sui modi più intensi di vivere la morte

Pare che, con il suo bagaglio di corbezzoli, tristezze e cipressi, Novembre possieda da sempre le physique du rôle e i requisiti simbolici per essere il mese da dedicare ai morti e, quindi, alla morte. Il sole, affaticato, vuole dichiarare forfait, la natura si lascia andare al riposo stagionale, e per gli umani sopraggiunge il pensiero pauroso del riposo “eterno”.
Dalla preistoria ad oggi non è affatto mutata la paura legata a quella realtà biologica fobicamente rappresentata nei panni di una donna in tunica nera, con tanto di falcione nelle scheletriche mani. È mutato, invece, il nostro approccio culturale, come va mostrando il modo di rispondere alla minaccia del Covid. Dietro e dentro il ‘lockdown’, i ciclici DPCM, i grafici epidemiologici, l’affannosa ricerca di rimedi, cosa c’è se non la paura della morte, confidenzialmente detta “fifa” (sì, proprio quella che farebbe, chissà perché, novanta)?
Ciò che aggrava la situazione è l’evidente e tutta moderna difficoltà di accettarla, la morte, contro la quale si continuano a innalzare (inutili) barricate, smarrendo così la capacità di elaborare adeguatamente il lutto individuale e collettivo. Non a caso le bare caricate sui mezzi militari durante la fase pandemica più acuta si muovevano nottetempo, nel buio, perché venissero sottratte all’occhio del giorno capace di sbatterci in faccia i limiti delle «magnifiche sorti e progressive», come avrebbe potuto chiosare Giacomo Leopardi!
Eppure i pensieri più nobili, da Budda a Socrate a Cristo, continuano a spiegarci come fare ad accogliere quella che Francesco d’Assisi volle appellare “sora nostra” in quel capolavoro che apre le porte della poesia italiana. Molti altri poeti, ovviamente, grazie allo speciale radar emotivo messo loro a disposizione dalla poesia, hanno fatto del loro meglio per sondare e scrivere il mistero della morte.
Per evitare di fare concorrenza agli elenchi telefonici, proviamo a scegliere fior da fiore, privilegiando poeti e testi che hanno affrontato il tema in modo originale, aiutandoci a fare i conti con quella che per Pessoa è solo «la curva della strada» avvistata – per dirla con Tagore – allorquando «il giorno chiassoso / tace dinanzi al silenzio delle stelle», quel «giorno / in cui da subito intuii che le teste dei cavalli / andavano verso l’eternità», come ha scritto la Dikinson. Per questa fragile, agorafobica ma illuminata poetessa statunitense «chi ama non conosce morte», così come non la conosce «chi è amato»: viene spiazzata così in pochi versi la coppia eros/thanatosdi classica ascendenza, così cara a Sigmund Freud e ancora molto frequentata soprattutto nel mondo cinematografico (si pensi, per tutti, ad Anonimo veneziano o a Love story). Ma anche il famoso verso di Pavese «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi» sembra un tributo verso il duo amore/morte, simbiotico e oppositivo nello stesso tempo (di qui forse il suo fascino).
Approfittiamo pertanto di Novembre per andare incontro a qualche testo esemplare che proponga una diversa relazione tra amore e morte, riconoscendo alla pulsione amorosa quella speciale carica vitale in grado di addolcire l’angoscia della morte.
«Amor mi mosse» dichiara Beatrice che, proprio per amore, consente a Dante di entrare nel regno dei morti per compiere un viaggio spirituale che lo faccia nascere a nuova vita. E non ce ne voglia il nostro Foscolo, sì, quello dei Sepolcri propinati nelle scuole di ogni ordine e grado, se mettiamo tra parentesi il suo superbo poema scritto in “do di petto” per leggere un più umile Epitaffio dedicato da Lord Byron a tale Boatswain, che «nacque in Terranova / nel maggio del 1803 / e morì a Newstead Abbey / il 18 novembre 1808». Ma chi era costui…? Era il suo cane «che possedette la bellezza / ma non la vanità / la forza ma non l’arroganza / il coraggio ma non la ferocia»: il grande amore per il proprio cane si fa spunto per deplorare i vizi umani posti in costante contrapposizione rispetto alle virtù animali. I romantici, peraltro, avevano una particolare predilezione per morte, cimiteri e dintorni!
Rimaniamo in ambito anglofono e cimiteriale, spostandoci però nello Stato americano del Maine, dove scorre il fiume Spoon, da cui prese il nome un altro viaggio nel regno dei morti, compiuto ai primi del Novecento dalla penna dell’avvocato Edgard Lee Masters. La sua Antologia di Spoon River è un insieme di epitaffi attraverso i quali, sulla “collina” del cimitero, i personaggi di un immaginario paesino prendono a raccontare e a raccontarsi. Sotto l’evidente, ma non moralistica, critica dei comportamenti umani, ci pare agisca quella forma particolare di amore che chiamiamo compassione: verso i deboli, gli emarginati, i perseguitati dalla vita e dalla società. L’opera fu scoperta in Italia allorquando Pavese passò il libro a una giovanissima Fernanda Pivano, che per averlo tradotto… fu tradotta in carcere a causa della censura di regime (era il 1943 quando fu pubblicato da Einaudi). Da allora la raccolta è stata letta molto in Italia, al punto che Fabrizio De André si ispirò a nove di quegli epitaffi per il suo album Non al denaro non all’amore né al cielo (1971). Da allora, anche per noi, quei personaggi «dormono, dormono sulla collina».
Sempre negli Stati Uniti, facciamo tappa presso il testo di un contemporaneo, il nativo americano di etnia Kiowa N. Scott Nomaday (Premio Pulitzer), che così descrive la morte di un anziano: «Per lui non c’è problema / Di altrove. […] La morte lo smuove / Non più di quanto lo smosse la vita; / Lui è sempre stato qui.». Eccoci di fronte a una cultura e a un popolo attraversati da un amore sacro verso la madreterra, un amore creaturale e totale, “panico” si direbbe, che non ha bisogno di scomodare la metafisica, almeno quella cui hanno fatto ricorso quegli europei portatori di un disegno per così dire colonizzatore sfociato nel genocidio.
In ogni caso, quando i poeti più poeti hanno parlato della morte alla luce della loro speciale sensibilità, non hanno potuto non parlare della vita. È proprio per questo che bisogna leggerli, per cercare un confronto con le nostre più importanti domande esistenziali e le nostre più recondite paure, quelle che la ragione di cartesiana memoria non riesce a colmare di ragioni. Potremo scoprire delle intuizioni e delle riflessioni degne di figurare nella galleria delle guide spirituali, e perciò meritevoli di un piccolo spazio sul comodino delle nostre meditazioni. Spingiamoci quindi ad ascoltare altre voci emblematiche della relazione vita/morte, tutte appartenute al Novecento sia pure sotto diversi cieli geografici e culturali.
«Se davvero volete contemplare lo spirito della morte, spalancate il cuore al corpo della vita. / Perché la vita e la morte sono una sola cosa, come il fiume ed il mare.» E poi: «Solo quando berrete al fiume del silenzio canterete davvero. / E quando avrete raggiunto la sommità del monte, comincerete a salire. / E quando la terra esigerà le vostre membra, solo allora danzerete veramente». Ecco che, nei versi di Kahlil Gibran, libanese emigrato in America, la morte diventa la pagina su cui scrivere le domande ultime e lèggere le risposte più vere. Non a caso queste ed altre parole dal tono “profetico”, cariche di suggestioni orientali, le leggiamo nell’ambito della sua opera più famosa, Il Profeta.
Alla stessa area geografica, più o meno, appartiene la voce di Nazim Hikmet, così innamorato dell’utopia comunista da aver scelto di chiudere i suoi giorni in Russia, dopo aver trascorso diversi periodi in un carcere turco, dove scrisse stupende poesie d’amore, giacché si può amare una donna come si può amare un’idea, gli alberi, la vita, perché l’amore, quando è tale, non può conoscere limiti e ambiti di applicazione. Che tenerezza e quale leggerezza caratterizza “Il mio funerale”, testo in cui il poeta immagina le sue esequie pensando, più che a se stesso, agli altri, tanto da chieder loro «Come mi farete scendere giù dal terzo piano? / La bara nell’ascensore non c’entra / e la scala è stretta». E «i bambini accorreranno / i bambini sono sempre curiosi dei morti». Per approdare infine ad una chiusa davvero toccante, oltre che gioiosa: «La nostra cucina mi seguirà con lo sguardo / il nostro balcone mi accompagnerà col bucato steso. / Sono stato felice in questo cortile. / Vicini miei di cortile, vi auguro lunga vita, a tutti».
Come si vede, è sempre l’amore, nelle sue diverse forme, il balsamo che può medicare il dolore della morte, la quale può diventare addirittura un’arte, come spiega il francese Pierre Emmanuel in un breve ma molto suggestivo testo intitolato, appunto, “L’arte di morire”, che per la sua essenziale brevità possiamo riportare interamente: «L’arte di morire / Ce la insegnano gli uccelli / Che cadono / Insieme con le foglie / Le nespole durano / Più a lungo di loro // Nessun rumore o quasi / Appena sono maturi / Subito si perdono / Dentro la fossa // Sono loro i morti / più garbati».
Restiamo in Europa per incontrare lo spagnolo Federico García Lorca, che con la morte ebbe sempre una relazione ravvicinata e confidenziale, quasi a vaticinare il brutale assassinio che dovette subire per mano dei franchisti. In “Memento” il poeta chiede al mondo una sepoltura tutto speciale, una sepoltura diciamo pure “da poeta”: «Quando morirò / sotterratemi con la mia chitarra / sotto la sabbia. / Quando morirò, / fra gli aranci e la menta. // Quando morirò, / sotterratemi se volete / in una banderuola». Purtroppo la sua richiesta non fu esaudita e il corpo trentottenne di un grandissimo poeta non è stato mai trovato: delitto contro l’umanità!
Ma il sangue dei poeti genera altra poesia e quello di Lorca ha prodotto le meravigliose metafore “ispaniche” e surreali di Vittorio Bodini, anch’egli invaso da un senso tragico della vita e della morte. Se leggiamo il suo testo “Morta in Puglia”, sentiamo tutto il legame viscerale intrattenuto dal poeta con l’orizzonte antropologico del suo Salento, che teme venga risucchiato verso il passato e dal cui immaginario non vorrebbe staccarsi: «Morta, non morire di più. / Ricordati delle ulive nere. / Lucida le maniglie e annaffia i garofani. // Dimentica che i vetri delle finestre/ si lavano con acqua e aceto; / che le macchie sui vestiti scuri / si tolgono con la posa del caffè».
Tra il Salento e la Terra di Bari, o meglio tra la Messapia e la Peucetia, ha coltivato la sua musa un altro grande. Si tratta di quel Pietro Gatti autore di una sorta di Spoon river tutto pugliese che, rispetto a quello americano di Edgard Lee Masters, possiede notevoli elementi di originalità. Intanto, come quasi tutta la produzione di Gatti, il suo ‘Nguna vite è scritto in dialetto, che sembrerebbe essere la lingua preferita dai morti. E poi, anche se sono i defunti a raccontarsi, come nell’opera di Masters, qui le voci ultraterrene sono quasi tutte di bambini morti tragicamente. La raccolta, infatti, è dedicata: «Alle criature core bbuene / de tutte le strace de l’annuciende / du munne» (Alle creature cuori buoni / di tutte le stragi degli innocenti / del mondo). Grazie a una lingua fatta di carne e sangue nonostante l’onnipresenza della morte, queste voci ci trasportano in un pianeta contadino dove la natura e la stessa esistenza manifestano una forte, persino violenta, tragicità. Commoventi le vicende, miserevoli le atmosfere, strazianti le parole, come ad esempio quelle di una madre sepolta lontano dalla tomba del figlioletto premorto per tubercolosi, che lei cerca di raggiungere con la mano attraverso un «intrico di radici d’alberi e d’anime».
Rendiamo dunque grazie a Novembre e alla poesia, perché insieme con i pensieri e i riti religiosi ci offrono la possibilità di riflettere e meditare sui modi più intensi di vivere la morte.
[Nota: Rivisti e corretti, sono qui assemblati due testi recentemente pubblicati su «La Gazzetta del Mezzogiorno»]
Nella foto di apertura: l’autore, Lino Angiuli
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

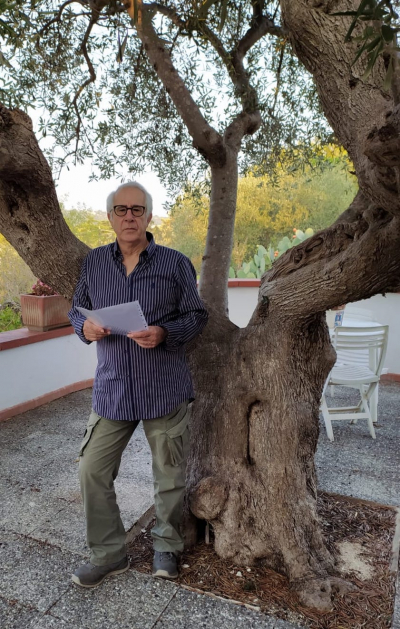
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.