Corso Italia 7
Rivista internazionale di Letteratura – International Journal of LiteratureDiretta da Daniela Marcheschi
«La parola ferisce, la parola convince, la parola placa». Per Ennio Flaiano
È disponibile da Adelphi una riedizione del romanzo Tempo di uccidere, che l’autore pubblicò nel 1947. Tutto nacque una sera del dicembre 1946, nel corso di una passeggiata con Leo Longanesi. «Mi scrive un romanzo per i primi di marzo?», gli avrebbe chiesto l’editore. Raccolse la sfida consegnando in tempo per vincere il Premio Strega alla sua prima edizione. Riletto oggi, il romanzo si presenta come un’opera controcorrente e in qualche modo anacronistica

Alla sottovalutazione di Tempo di uccidere, il romanzo che Ennio Flaiano pubblicò nel 1947 e vede ora una più che meritata riedizione da Adelphi, contribuì non poco l’autore stesso, in forza dello straordinario eclettismo che gli consentì di eccellere nel giornalismo e nella critica teatrale e cinematografica, nell’attività di saggista ed elzevirista, oltre che di sceneggiatore dei capolavori di Fellini e di altri grandi registi, arrivando a firmare ben 60 copioni. Così come ne furono complici la sua maschera di sferzante ironia, la posa di chi non prende niente davvero sul serio, e quindi nemmeno il proprio talento letterario. Con questo spirito si compiaceva di raccontare come una sera del dicembre 1946, durante una passeggiata per le vie di Roma, Leo Longanesi gli avrebbe chiesto «Mi scrive un romanzo per i primi di marzo?», e lui avrebbe raccolto la sfida, consegnando a stretto giro il lavoro che sarebbe andato in stampa in aprile, in tempo per vincere il Premio Strega alla sua prima edizione. Sappiamo però come avrebbe poi smentito l’ostentata nonchalance con una serie di revisioni del testo che avrebbe condotto per il resto della vita.
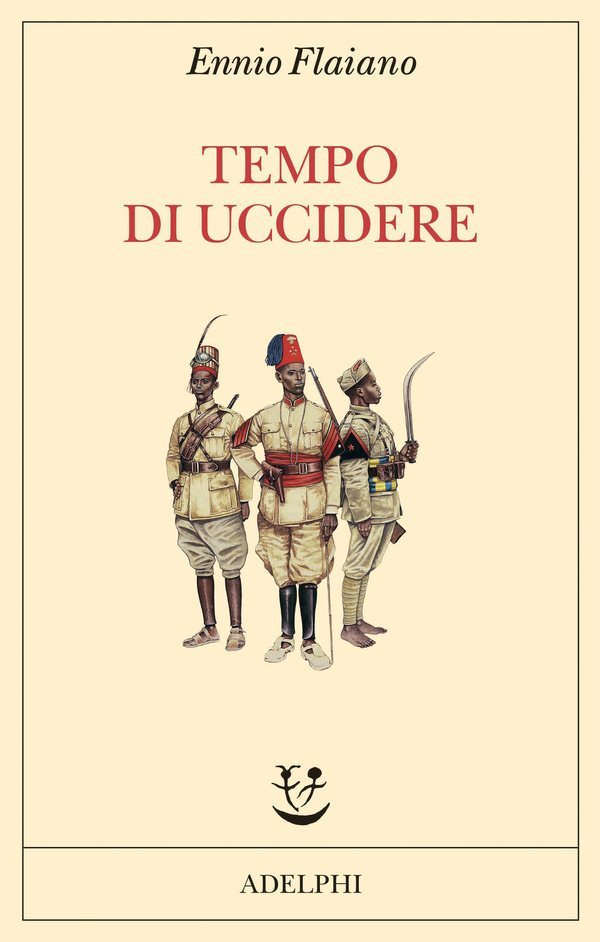
Sempre con un atteggiamento di indolenza, se non di dissipazione, Flaiano scelse poi di non dare forma compiuta ad altri scritti letterari di gran valore e in larga parte pubblicati postumi, come Un bel giorno di libertà o Un giorno a Bombay, mentre a dispetto di chi continua a reputare Tempo di uccidere un unicum bisogna ricordare Melampo, pubblicato a sua volta postumo nel 1974, che del romanzo ha lo spessore e l’articolazione narrativa: favola amara sulla dedizione e sulla delusione amorosa, in cui si incontrano passi memorabili, come: «La vecchiaia è una realtà che dev’esserti comunicata, da solo non si riesce mai a intenderla». Maestro della satira, di giochi di parole e neologismi (“paparazzo” e “vitellone” sono tra i suoi più famosi), Flaiano era capace come pochi di mettere a nudo fragilità, ambizioni e meschinità umane, grazie a una straordinaria sensibilità per certi frammenti di quotidiano da cui scaturivano anche i suoi celebri aforismi, in cui al registro divertito e sardonico si alterna quello più amaro e profondo.
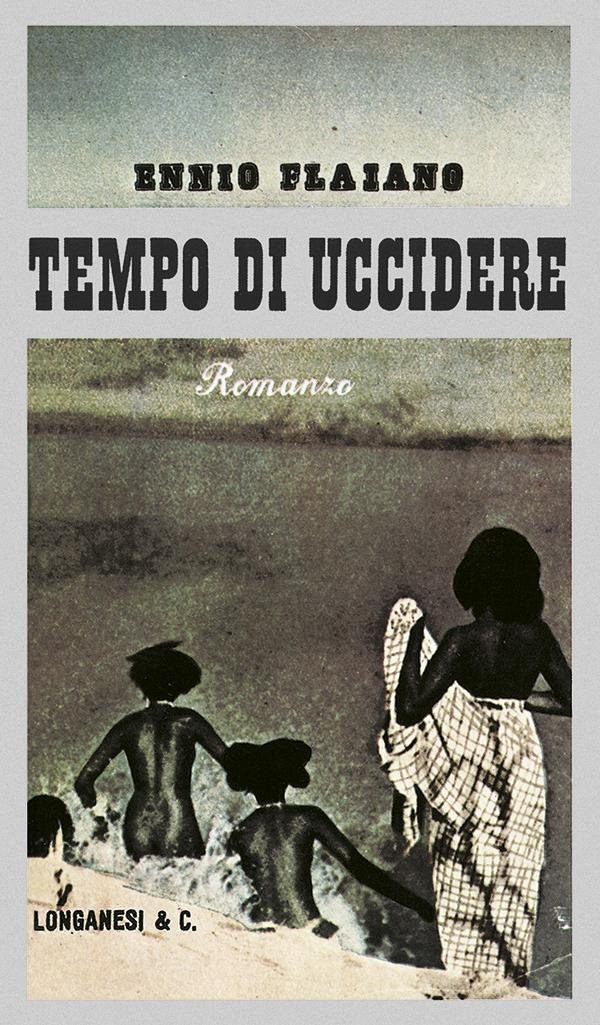
Tempo di uccidere fu accolto con diffidenza dalla critica che si concentrò su alcuni presunti limiti formali a scapito del resto, forse anche perché l’ambientazione rimandava a quella guerra d’Etiopia che nessuno amava ricordare e che è rimasta uno degli eventi più rimossi della nostra storia. La visione antieroica di cui è permeato l’intero romanzo emerge fin dall’incipit, in cui il protagonista, un ufficiale del Regio esercito poco ligio al dovere e afflitto dal mal di denti, esce dai ranghi per trovare un dentista e si perde nella boscaglia. Qui si imbatte in una giovane indigena che con muta condiscendenza gli si concede, ma poi la colpisce incidentalmente con una rivoltellata e finisce per darle il colpo di grazia, mosso da un’ambigua mescolanza di pietà ed egoismo. Sulle prime si crede capace di passare oltre, ma ben presto il peso dell’atto compiuto gli piomba addosso fino a diventare un’ossessione, in cui al rimorso si somma il senso di minaccia, quando si convince che la ragazza fosse affetta da lebbra, e di esserne stato contagiato. Inizia così a girovagare per l’altopiano etiopico, che perde i contorni della pur scabra fascinazione iniziale («Una pace antica, in quel luogo. Ogni cosa lasciata come il primo giorno, il giorno della grande inaugurazione»), per assumere quelli sempre più deformati e surreali conferitigli dallo sguardo allucinato del protagonista, sprofondato in un abisso di rimorso e paura.
Dopo varie peregrinazioni dominate dal parossismo che lo ha avvinto, indotto a commettere altri reati che lo convincono di non avere più alcuna via di uscita, calamitato dal luogo dove ha seppellito la sua vittima, dove vegliato da un vecchio ascari trascorre un lungo periodo di espiazione che però non lo libera dal disgusto di sé e di tutto, l’ufficiale scoprirà alla fine che nessuno lo ha denunciato per il male commesso, non è ricercato come temeva e può tornare in Italia, con l’amara conclusione che «Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri». Dovrà però continuare a scontare la dura condanna inflittagli dal proprio tribunale interiore, con la consapevolezza della debolezza morale che l’esperienza vissuta gli ha rivelato; tarato da un’insanabile colpa accanto a cui permane la simbolica minaccia della lebbra, che lo seguirà a lungo.
Riletto oggi il romanzo si presenta come un’opera controcorrente e in qualche modo anacronistica, lontana dai dettami del neorealismo in quel momento imperante, riconducibile a temi e influenze molteplici. Il protagonista spaesato e irresoluto richiama l’esistenzialismo di Camus e di Sartre, e nel contempo quel modello di “inetto” su cui sono imperniati i grandi romanzi di inizio Novecento, da Musil ai nostri Svevo e Pirandello. Si accosta in particolare a quest’ultimo anche la concezione del Caso come forza occulta che determina gli eventi, in cui riconoscere i segni del proprio destino. Se a momenti la dimensione onirica diventa dominante e sembra rimandare a certe opere di Landolfi o di Savinio, alla rilettura odierna non regge l’idea avallata sempre da taluni critici della prima ora, secondo cui sarebbe casuale e poco rilevante lo scenario reale in cui la vicenda si svolge. Il testo appare al contrario disseminato di efficacissimi scorci sugli scempi della guerra fascista, gli stessi che Flaiano raccolse in Aethiopia, il diario redatto fra il 1935 e il 1936 e pubblicato anch’esso postumo sul settimanale «Il Mondo» nel luglio del 1973. Al suo consueto registro di feroce ironia, qui l’autore alterna quello del tragico sgomento, come quando riporta lo sfogo di un mitragliere della Gran Sasso: «Io vedevo arrivare gli abissini come le mosche. Sparavo con la mitragliatrice. Poi passo l’arma a un compagno che spara per circa un’ora. Alla fine durante una pausa della battaglia il mio compagno scoppia a piangere. “Perché piangi, stupido!” gli dico io. E lui: “Perché devo ammazzarne troppi”».
Molti frammenti di Aethiopia si ripresentano in Tempo di uccidere, dove il dramma individuale del protagonista acquista elementi di universalità e anche una valenza storica oggi più attuale che mai, con la rappresentazione di uno scenario bellico popolato di ufficiali che si arricchiscono grazie a traffici illeciti, o balordi soldati che preferiscono il sesso con le indigene al dovere patriottico. Il tanto decantato mito del “mal d’Africa” viene stigmatizzato con quattro parole: «Fai un breve segno e sei obbedito». Così come non mancano tracce delle stragi perpetrate a danno degli Abissini, nella costante e sottesa denuncia delle aberrazioni e delle gravi responsabilità del colonialismo. «L’Africa è lo sgabuzzino delle porcherie, ci si va a sgranchirsi la coscienza» recita un altro esemplare aforisma, a dimostrazione di come la dote della magica sintesi verbale guidasse Flaiano anche nel testo narrativo. Come ebbe a dichiarare in un’intervista: «La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso della scrittura».
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui


Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.