Boschi in fiamme. Prevenire si può
Ci si chiede spesso il motivo per cui in Italia nel periodo estivo vi siano devastanti incendi. Le risposte sono tante e tutte da prendere in seria considerazione. Le soluzioni ci sono, e sono pure efficaci, ma è bene comprendere le ragioni profonde di un fenomeno che resta perennemente irrisolto. Una circostanziata analisi storica, sociologica e legislativa ci aiuta a comprendere quanto sia importante il valore di una cultura civica dei beni comuni

Perché in Italia ogni anno, e per l’intera stagione estiva, i boschi bruciano in modo così virulento e distruttivo?
C’è in primo luogo da considerare una predisposizione del nostro paese legata alle particolari condizioni meteorologiche e climatiche. Aridità, alte temperature, bassa umidità, forte ventosità, alta frequenza di eventi estremi come le ondate di calore, sono fattori che da noi sono tutti presenti. In queste condizioni un incendio può facilmente acquisire vigore e interessare vaste superfici. Dobbiamo essere consapevoli che la frequenza e l’intensità di questi fenomeni è destinata a crescere in futuro. L’eccezionalità climatica sarà sempre più la norma: il Mediterraneo sarà più esposto rispetto ad altre regioni del mondo a fenomeni di riscaldamento. Si ridurranno le piogge in primavera, mentre aumenteranno le ondate di caldo in estate. E gli incendi quindi potranno essere più rapidi, intensi e di larghe dimensioni. E addirittura potranno verificarsi in anticipo, anche all’inizio della primavera.
I cambiamenti climatici generano inoltre un effetto indiretto sull’esposizione dei boschi agli incendi. Inducono, infatti, attacchi di insetti e funghi agli alberi con conseguenze più gravi che nel passato. Colpiscono piante mediamente più invecchiate e vulnerabili. E così si crea un circolo vizioso: alberi indeboliti dagli attacchi parassitari diventano più esposti ai roghi e piante bruciate, morte o deperenti, sono più vulnerabili ai parassiti.
C’è poi da prendere in esame un secondo fattore strutturale del fenomeno: in molti casi gli incendi dipendono da nostri comportamenti dolosi o irresponsabili. Non si tratta di piromania, una malattia mentale rara. Sono invece gruppi ben definiti di persone che ogni anno si attivano per compiere questi veri e propri crimini: pastori in cerca di pascoli più ricchi e “puliti”, incendiari con motivazioni vendicative verso alcuni proprietari boschivi, operai forestali stagionali in cerca di opportunità di impiego nell’antincendio, cacciatori interessati a controllare e concentrare le aree di rifugio della selvaggina. A prevalere sono i comportamenti colposi legati a noncuranza, negligenza, imperizia e sottovalutazione del rischio come quelli degli agricoltori che bruciano i residui vegetali, dei turisti e campeggiatori distratti, di coloro che gettano mozziconi di sigaretta, dei parcheggiatori fuori strada.
Negli ultimi tempi è emersa l’ipotesi di una regia mafiosa, come nel caso degli incendi dell’area protetta del Vesuvio alcuni anni fa o nel caso di questi giorni che vede l’Aspromonte come arena privilegiata di questa tipologia di delitti ambientali. In effetti, secondo alcuni studi, nelle quattro regioni con tradizionale presenza mafiosa si concentra più del 60% dei roghi. E non sarebbe da scartare l’idea di approfondire un eventuale interesse delle organizzazioni malavitose a mettere le mani sui flussi di spesa della PAC per gli interventi di riforestazione.
Ogni volta che arriva la notizia di un incendio, come quello divampato a Tito in Basilicata che ha distrutto 150 ettari di bosco e ha messo a repentaglio l’incolumità pubblica anche delle fasce periurbane, ci prende lo sconforto. Ma le cause di tali disastri sono note e sono disponibili soluzioni efficaci per evitarli. Sull’onda emotiva, ogni volta siamo portati ad agire esclusivamente sull’inasprimento del regime sanzionatorio e sull’acquisto di nuovi aerei. Queste misure sono certamente necessarie e dobbiamo insistere per ottenerle. Ma dobbiamo, al tempo stesso, essere coscienti che non sono risolutive.
Per una cultura civica dei beni comuni
La tragedia degli incendi boschivi costituisce innanzitutto un problema di carenza di cultura civica dei beni comuni, di gracilità educativa al rispetto dei beni collettivi. Per affrontare tale problema, bisognerebbe agire su più versanti: educazione, prevenzione, sorveglianza. Educazione significa apprendere, fin dalla tenera età, gli elementi essenziali per la conoscenza del fenomeno. E deve riguardare tutti i cittadini. Mentre prevenzione significa scegliere specie appropriate; realizzare diradamenti, spalcature, fasce tagliafuoco, interventi di pulizia di arbusti e sottobosco; fare manutenzione delle fasce laterali delle strade e di quelle sottostanti le linee di comunicazione; ridurre il materiale potenzialmente combustibile attraverso, ad esempio, il fuoco prescritto. Sorveglianza significa responsabilizzare i proprietari attraverso il loro coinvolgimento nelle iniziative di autoprotezione per tutelare i propri immobili e per segnalare ogni evento a ridosso della proprietà; monitorare il territorio con strumenti satellitari e informatici – dispositivi LoRa (= tecnologia wireless a radiofrequenza Long Range) – per localizzare, tra l’altro, anche gli incendi in tempi quasi reali. Ci vuole un’azione formativa degli operatori (pubblici, privati e del Terzo settore) a vasto raggio, anche in termini di maggiore professionalizzazione, che ancora non viene fatta.
Questa cultura civica potrà fiorire se si passerà ad una politica di tutela e gestione attiva delle risorse forestali. Riconoscendo ad esse un valore sociale, culturale ed economico per il quale ha senso difenderle e monitorarle. L’educazione, la prevenzione e la sorveglianza vanno connesse alla rivitalizzazione dell’economia del settore: un bosco che produce valore (legname, biomassa, funghi, tartufi, castagne, ma anche servizi sociali, turistici, ricreativi, culturali) è un bosco che viene difeso e che difficilmente brucia.
Chi vuole farsi un’idea più precisa di questo argomento può sfogliare o scaricare il fascicolo speciale della rivista on line “I Tempi della Terra” (n. 2 del 2021) intitolato “I boschi e le foreste in Italia: aspetti produttivi, ambientali e normativi”, con una introduzione di Tommaso Maggiore. Dai contributi di numerosi esperti apprendiamo che la superficie forestale in Italia negli ultimi 60 anni si è quasi triplicata, raggiungendo il 40 per cento della superficie territoriale. E ciò a scapito di aree arative e pascolive abbandonate. Nello stesso tempo, veniamo a sapere che nello stesso periodo è aumentata sia la domanda di beni e servizi che la vulnerabilità e i rischi cui i boschi sono esposti. In uno dei contributi, Pietro Piussi scrive: “La selvicoltura non è solo la scienza e la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi dell’ecologia forestale, per condizionarne la struttura e la composizione specifica, ma va intesa in senso lato come l’applicazione di queste pratiche in un certo luogo e in un dato momento, fatto che richiede conoscenze relative alle infrastrutture necessarie per svolgere i lavori, all’economia nonché delle esigenze e delle richieste della società”.
In un altro contributo, Severino Romano illustra le opportunità del programma Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed esprime un giudizio critico sulla scelta di non considerare i finanziamenti di questo programma aggiuntivi a quelli della PAC ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse forestali. Un’occasione mancata per una politica della silvicoltura capace di affrontare i nodi strutturali del settore. Nel PNRR c’è un coinvolgimento del settore forestale solo indiretto e, dunque, inefficace al punto da indurre lo studioso a scrivere senza mezzi termini: “Pur con tutte le importanti novità che questo include in merito alla riforma del sistema Paese e alla rivoluzione verde e transizione ecologica annunciata, non possiamo che affermare che il nuovo PNRR rappresenta una importante operazione di ‘green washing’, avendo completamente ignorato un asset importantissimo per tanti territori del nostro Paese, gli stessi su cui si dovrebbe puntare l’attenzione per aumentare la coesione sociale, la resilienza e diminuire la fragilità dei territori, limitare il ‘brain draining’ e l’emigrazione delle fasce più giovani delle popolazioni”.
Ma non siamo dinanzi solo a questo paradosso in tema di silvicoltura. In una recente pubblicazione di Giovanni M. Flick e Maurizio Flick (Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale, Il Mulino, 2020) si dà conto della contrapposizione, tutta ideologica, nella dottrina giuridica tra chi punta esclusivamente a valorizzare la funzione ambientale dei boschi e chi, invece, pone l’accento prevalentemente sulla loro funzione economico-produttiva. Una divaricazione che rischia di tradursi in immobilismo operativo. Ma se si vanno a vedere bene le cose, ci accorgiamo che tale conflitto si può superare con un confronto sereno e laico. Basterebbe approfondire e diffondere una concezione dei beni forestali come beni comuni. È proprio ragionando su questa prospettiva che vorrei tentare di dare un contributo.
Quando foresta e bosco avevano significati diversi
Da decenni giuristi ed economisti utilizzano indifferentemente le parole “bosco”, “selva” e “foresta” come se fossero sinonimi. Forse il termine “foresta” (fortuna delle parole!), con le sue derivazioni, si adatta meglio di “bosco” al bisogno di alcune espressioni linguistiche. Ma solo con il d.lgs. n. 34/2018 – Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) si è pervenuti ad una norma giuridica (art. 3, comma 1) che recita: “I termini foresta, bosco e selva sono equiparati”. Così non ci sono più incertezze definitorie ma anche visioni differenti dei problemi da affrontare.
Dal punto di vista storico, ci sono infatti differenze non di poco conto tra i due vocaboli. E tali divergenze hanno fortemente inciso nel modo di pensare diffuso delle persone. In origine “foresta” (dall’avverbio latino “foris” che significa “fuori”) indicava una proprietà boschiva chiusa al godimento della collettività dei cittadini e riservata all’utilizzo privilegiato del principe o del sovrano. “Inforestare” significava chiudere “a difesa”. Le “forestae” e le “defensae” si trovavano pertanto contrapposte alle “silvae”, ai “nemora”, ai “luci”, cioè ai boschi (dal latino medievale “buscus” che significa “estensione di terreno coperta di alberi”, “zona ristretta e concentrata di vegetazione”, “cosa fitta e inestricabile”).
Secondo questa netta distinzione, solo le foreste e le difese erano oggetto di disposizioni legislative. E le norme erano finalizzate a impedire che su tali aree si costituissero diritti da parte delle popolazioni. Nelle foreste il sovrano o il principe andava a fare le battute di caccia. E le popolazioni sapevano che quei luoghi non erano affar loro e che da quei territori dovevano stare a debita distanza, se non volevano mettersi nei guai.
I boschi e le selve diventarono invece parti costitutive di quell’ambiente con cui le popolazioni umane lottavano per conquistare gli spazi necessari per la propria sopravvivenza. Seneca e Plinio credettero di trovare nei profondi silenzi e nell’oscurità delle selve la causa di quel terrore reverenziale che gli esseri umani sentivano per la divinità. I boschi erano, infatti, popolati, secondo la fantasia degli antichi, di esseri divini ed erano preferiti come luoghi di sacrifici e di riti religiosi.
A difendere per prima i boschi furono, dunque, le religioni mediante la consuetudine. Il culto dei boschi sacri si affermò presso tutti i popoli dell’antichità, sia in Oriente che in Occidente. All’origine del “sacro” ci furono le mitologie che hanno accompagnato la vita del bosco e degli alberi. Peraltro, la consuetudine non riguardava solo gli aspetti religiosi. In Italia era alla base anche delle comunità di villaggio che esercitavano un dominio su proprietà collettive (delle popolazioni residenti) che riguardavano soprattutto le aree boschive. Le regole consuetudinarie di economia rurale permettevano a quelle comunità di sopperire alle proprie necessità più urgenti e immediate. I diritti d’uso consistevano nella facoltà di far pascolare nei boschi gli animali allevati, raccogliere la legna da ardere o da utilizzare come materia prima per l’industria del legno, “far la foglia” per preparare gli alimenti animali.
Con l’affermarsi del cristianesimo, la cura dei boschi sacri incominciò a declinare. La religione cristiana combatteva i culti pagani e prendeva di mira i luoghi dove si esercitavano questi culti. I vescovi ordinavano infatti alle autorità ecclesiastiche e civili di distruggere alberi e boschi sacri, comminando talvolta gravi pene. Nonostante tale azione distruttiva da parte della Chiesa, i culti dei boschi in diversi territori della nostra penisola si conservarono durante il Medioevo e anche dopo. Ma non furono queste le ragioni a provocare l’intervento della legge per difendere i boschi e i suoi prodotti, bensì quelle ecologiche ed economiche.
La legislazione forestale preunitaria
Molti comuni legiferarono sia per conservare il patrimonio boschivo, sia per evitare che la popolazione restasse senza prodotti legnosi, nonché per difendere il terreno e il regime delle acque. Alcuni sottoponevano i tagli ad una speciale autorizzazione per provvedere ai bisogni della marina e della difesa. Numerosi erano i comuni che comminavano la pena di morte contro coloro che provocavano l’incendio dei boschi.
In Lombardia si vietava di estirpare e dissodare i boschi senza permesso, per conservare un naturale riparo alle inondazioni nel piano e alle frane e valanghe nelle montagne.
In Piemonte si vietava il dissodamento ed ogni forma di coltura dei terreni destinati a bosco senza l’autorizzazione governativa.
Nel Granducato di Toscana le restrizioni riguardavano i boschi situati entro un miglio dalla cima degli Appennini; entro questi limiti il taglio era del tutto vietato nei boschi comunali.
Nel Regno delle Due Sicilie il divieto di dissodamento dei boschi e delle terre in pendio (“appese”) fu assoluto.
Particolare attenzione ci fu in Lombardia e nelle Due Sicilie alla conservazione del bosco quando questa serviva a garantire la saldezza del terreno e il buon regime delle acque. In tal caso, il rigore era rivolto soprattutto verso i privati, perché questi coi loro eccessi potevano più degli altri pregiudicare gli interessi della collettività.
La legislazione forestale nel periodo postunitario
Dopo l’Unità, il legislatore italiano si trovò a compiere la sua opera riformatrice ed uniformatrice, avendo a disposizione parecchi elementi tradizionali da valorizzare. Per arrivare al TUFF del 2018, il regime giuridico della foresta ha attraversato tre fasi: quella della tutela, quella della produttività, quella dell’ecosistema.
La fase della tutela si realizzò agli inizi del secolo scorso per reagire alle conseguenze della domanda vieppiù crescente di legno da utilizzare e di terra per il pascolo e l’agricoltura. Conseguenze che si erano tradotte, nei secoli precedenti, in una rilevante degradazione del bosco e in una forte pressione antropica su di esso. In questa fase si guardò soprattutto alla salvaguardia idrogeologica del terreno. Tale salvaguardia venne perseguita con il vincolo per la sopravvivenza delle risorse forestali, introdotto dalla fondamentale e tuttora assai importante legge cosiddetta Serpieri (r.d. n. 3267 del 30 dicembre 1923). In questa prima fase si affermò la prevalenza della funzione pubblica delle foreste sugli interessi privati produttivi. Momenti essenziali della disciplina legislativa furono il vincolo idrogeologico (che non prevedeva indennizzo perché esprimeva la realtà e l’identità del bene-bosco) e poi la sistemazione dei bacini montani, nonché l’intervento per il rimboschimento e il rinsaldamento del terreno.
Purtroppo in quella fase si portò a compimento anche la drastica riduzione delle proprietà collettive delle popolazioni. Contro di esse era invalsa una specie di pregiudizio dottrinale dall’epoca della rivoluzione francese. Quel pregiudizio consisteva nel ritenere che solo la proprietà privata (e pubblica) fosse capace di realizzare il progresso dell’agricoltura. Il Codice Civile del 1865 risentì di questo clima ed evitò accuratamente di contemplare i beni comuni, in alcuna forma o manifestazione. E tuttavia brandelli di legislazione, a cavallo tra anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, espressero la necessità di mantenere le forme e i possessi comuni laddove per l’altitudine e la natura dei fondi, le terre non potevano essere migliorate dal punto di vista agricolo.
La seconda fase, quella della produttività, prese corpo tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso. In tale periodo venne rivitalizzata la funzione produttiva, cercando di contemperarla con quella protettiva delle foreste. Emblema di questa prospettiva fu la cosiddetta legge Quadrifoglio (n. 984 del 27 dicembre 1977). Nonostante le buone intenzioni del ministro dell’Agricoltura dell’epoca, Giovanni Marcora, che la propose, e dei gruppi politici che l’approvarono, quel tentativo di programmazione agricola (che prevedeva anche il programma “forestazione”) si rivelò un sostanziale fallimento. E questo soprattutto a causa di un riassetto squilibrato del regime forestale tra Stato, regioni ed enti locali che non permetteva una governance efficace.
Il bosco come ecosistema comunitario
Con la cosiddetta legge Galasso (n. 431 dell’8 agosto 1985) riprodotta nel d. lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, prese piede la fase multifunzionale del bosco, inteso come ecosistema. I territori coperti da foreste o boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento venivano dichiarati di interesse paesaggistico in quanto tali, come categoria (al pari di altre categorie di beni come le coste, i fiumi, ecc.) e sottoposti a tutela. Un ulteriore vincolo di carattere naturalistico ha interessato oltre un terzo del patrimonio forestale, cioè quello incluso nelle aree protette (ai sensi della legge n. 394 del 1991) e/o nei siti della Rete Natura 2000. Le foreste italiane sono le più “vincolate” in Europa, ma ciò non significa che sono anche le più tutelate. Se accanto ai vincoli non si attivano interventi che mirino alla valorizzazione delle utilità ecosistemiche, il regime di protezione avrà effetti molto parziali. Il rischio è che si alimentano conflitti e si generano abbandoni gestionali. Bisogna invece promuovere nuove convenienze e legami più forti tra tutti i soggetti territoriali che hanno interesse alla tutela e alla valorizzazione del bene-bosco.
Quest’ultima fase si è infine consolidata con il TUFF del 2018 che rappresenta la nuova legge-quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali. Il provvedimento prevede sette decreti attuativi concertati tra Ministeri e regioni. Alcuni sono in fase di pubblicazione. Altri dovranno essere elaborati. Il nodo più complicato resta quello della governance nella tutela delle foreste: in sostanza la difesa della foresta spetta allo Stato, alle regioni, o ad entrambi?
Come sostengono Giovanni M. Flick e Maurizio Flick, “l’ordinamento forestale ha una caratterizzazione particolare, dal momento che assimila al suo interno interessi pubblici e interessi privati. Tale tipicità della foresta ha fatto sì che su di essa si esprimesse un diritto di proprietà il cui esercizio è controllato dalla pubblica amministrazione”. I proprietari dei boschi vanno aiutati a coniugare la gestione sostenibile, la rinaturalizzazione e la conservazione della biodiversità con la possibilità di non deprimere le produzioni forestali e i relativi redditi. Nessuna delle funzioni richieste al bosco può essere svolta senza un coinvolgimento dei proprietari. È dunque indispensabile promuovere accordi territoriali di settore, favorendo l’attivazione di sinergie di filiera e di reti interaziendali (reti d’impresa), caratterizzate da processi produttivi a basse emissioni di carbonio. E nello stesso tempo occorre promuovere consorzi, cooperative e associazioni tra i proprietari privati e forme gestionali comuni tra proprietà privata, proprietà pubblica e proprietà collettiva.
La recente legge 20 novembre 2017, n. 168, ha ora tipizzato la categoria dei “beni collettivi”. Si considerano tali le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione; nonché le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico. Inoltre, rientrano in questa categoria le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati; i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici, ecc. Il loro regime giuridico è caratterizzato: a) dall’inalienabilità; b) dall’indivisibilità; c) dall’inusucapibilità; d) dalla perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; e) dall’affidamento della relativa amministrazione ad enti esponenziali delle collettività titolari. A queste ultime sono riconosciute personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.
Con la rivitalizzazione di queste antiche forme di aggregazione, con cui in passato – come si è visto – le comunità di villaggio si autogestivano, si potranno sperimentare modalità innovative per tenere insieme pubblico, privato e collettivo. Nel Mezzogiorno sarà più difficile ma non impossibile: il patrimonio collettivo nelle regioni meridionali è gestito dai comuni e si è fatto di tutto per dimenticare la sua origine comunitaria. Tuttavia, oggi tale patrimonio costituisce un’opportunità per formare una nuova società civile da responsabilizzare nella gestione sostenibile di fondamentali beni comuni.
In apertura, foto di Francesco Caricato
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

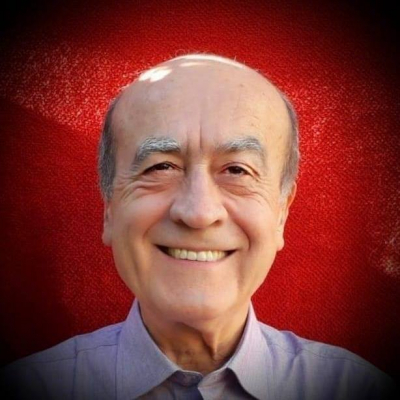
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.