La complessità del verbo educare
Non c’è un rapporto meccanico e automatico tra educazione e sviluppo economico. Chi ha fatto propria questa semplificazione ha preso un abbaglio gigantesco. Impegnarsi, come si è fatto, facendo leva soprattutto sulle discipline tecniche e scientifiche, non è stata una scelta azzeccata. Il progressivo ridimensionamento delle materie umanistiche nei programmi scolastici è stata una svista enorme

L’educazione è un insieme stratificato e complesso; eterogeneo al suo interno (insegnanti, studenti, amministrazioni ripartiti nei diversi ordini e tipi di scuole; programmi per disparate materie e curricoli educativi); connesso da legami diversi con differenti società, culture, saperi, tradizioni nazionali; dipendente da orientamenti dei decisori politici, ma anche da richieste e sollecitazioni, spesso contraddittorie, provenienti dall’ambiente in cui le scuole operano.
Questa complessità spiega perché, nei paesi bene ordinati, le politiche scolastiche non sono un particolare settore di governo ma sono prese in mano direttamente da chi, conservatore o progressista che sia, ha le responsabilità massime e complessive di governo, Thatcher o Chàvez, Sarkozy, Clinton, Bush o Obama. In Italia è stato così solo con Giolitti, ai primi del Novecento. Vorrà Renzi rompere una tradizione di marginalità dei problemi educativi? Vedremo.
Una speciale attenzione alle politiche scolastiche è riservata da quegli statisti che sanno cogliere la complessità delle connessioni che esistono tra istruzione e sviluppo, educazione e democrazia, culture e identità nazionali. Recentemente, su committenza dell’Asian Development Bank, Robert J. Barrow e Jong Wha Lee hanno studiato le relazioni tra scuola e sviluppo economico in riferimento all’evoluzione del Pil in 140 paesi del mondo, a intervalli di cinque anni, tra il 1950 e il 2010.
Dallo studio viene fuori l’immenso progresso della scolarizzazione di massa. Nel 1950 la popolazione mondiale aveva un’istruzione media di 3,2 anni (il dato italiano del tempo); nel 1980 di 5,3 anni; nel 2010 di 7,8 anni. Un progresso enorme. E dappertutto la scolarizzazione ha spinto in alto il reddito. Ma è rimasto forte il divario tra i paesi ad alto reddito, dove l’indice medio è salito da 6,2 a 11 (che è l’indice italiano d’oggi), e i paesi a basso reddito, dove è aumentato da 2,1 a 7,1. Il ritorno sul reddito è alto nei paesi avanzati. L’Italia, ad esempio, con la scolarizzazione di massa ha saputo fare un grande balzo dal sottosviluppo al pieno sviluppo.
Non così si può dire dei paesi poveri e in via di sviluppo: nell’Africa subsahariana e in America Latina il ritorno sul reddito è meno della metà di quello registrato nei paesi ricchi. E questo dato ci indica che non di sola scuola vive lo sviluppo economico, ma di più complicate politiche di investimento, strumenti e regole da adottare non solo nei singoli paesi ma anche a livello globale. Migliorando le condizioni generali, anche le scuole agiscono più positivamente sullo sviluppo.
Non c’è, dunque, un rapporto meccanico e automatico tra educazione e sviluppo economico. Chi ha fatto propria questa semplificazione ha preso un abbaglio gigantesco perché ha ragionato più o meno così: siccome alla competitività economica tra paesi servono innovazioni tecnologiche, è sufficiente per accrescere lo sviluppo chiedere alle scuole di impegnarsi soprattutto nelle discipline tecniche e scientifiche. Da qui il progressivo ridimensionamento delle materie umanistiche nei programmi scolastici. Una svista enorme. Non solo perché non vi è una diretta correlazione tra sistema scolastico e crescita del Pil, ma anche perché, pur volendo ammettere tale collegamento, un sistema educativo all’altezza dei problemi posti dalla globalizzazione deve formare cittadini responsabili e non sudditi, capaci di conoscere e comprendere soprattutto chi è lontano nello spazio e nel tempo. Da qui le ragioni generali di una formazione alla conoscenza e al gusto della geostoria, di taglio antropologico e critico, e di un’educazione che attinge a quei classici greci e latini che sono portatori eccellenti di visioni del mondo che hanno condizionato alle radici la nostra cultura.
In un lavoro di alcuni anni fa (Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, 2011), la filosofa Martha C. Nussbaum ha dedicato pagine molto dense contro la scelta anticlassica che molti paesi hanno adottato. In particolare, la filosofa sostiene che se una nazione intende promuovere una democrazia “umana”, sensibile verso l’altro, intesa a garantire ad ognuno le giuste opportunità di “vita, libertà e ricerca della felicità”, dovrebbe innanzitutto sviluppare nei suoi concittadini la capacità di ragionare sui problemi che riguardano la collettività senza delegare all’autorità e alla tradizione.
E a questo proposito, la studiosa dimostra come il metodo socratico, la tradizione filosofica occidentale di teoria pedagogica da Rousseau a Dewey e la scuola di Tagore hanno ancora molto da dire nel formare alla cittadinanza democratica.
Inoltre, mentre i paesi dove si parlano comunemente lingue derivanti dal greco e dal latino (compreso l’inglese!) hanno pressoché eliminato lo studio di questi antichi idiomi, non così avviene in altre aree più dinamiche del mondo (Giappone, Cina, Israele) dove il ruolo dello studio delle rispettive lingue antiche, che sono le loro radici classiche, il loro latino e greco, continua ad essere fondante nell’organizzazione scolastica e culturale. E ciò dimostra la correlazione stretta tra evoluzione delle società e valorizzazione delle tradizioni culturali. Ben venga, dunque, anche in Italia – così come pare voglia fare il governo – una ripresa delle discipline umanistiche nelle nostre scuole.
La foto di apertura è di Luigi Caricato
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

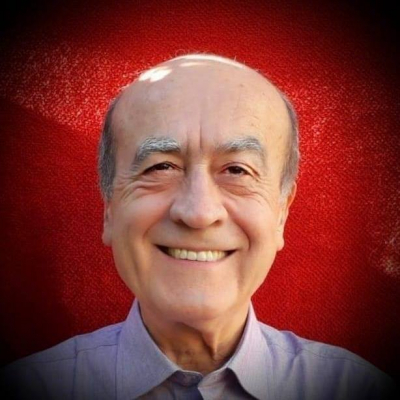
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.