La lentezza. Da stereotipo negativo a cattiva utopia
La lentezza non ha nulla a che vedere con il mondo rurale. La vera misura della vita contadina è stata la fretta. Non esisteva né l’idea di perdere tempo, né quella di non avere tempo. Oggi invece talune élite culturali esibiscono la lentezza quale elemento di superiorità. Lo slow food, per esempio, si autopercepisce come modello eticamente superiore

La lentezza non ha mai rappresentato un tratto distintivo del mondo rurale e delle popolazioni meridionali. Il legame tra l’idea di lentezza e lo stile di vita del mondo contadino e, in particolare, del mondo rurale mediterraneo è uno stereotipo inventato di sana pianta per stigmatizzare la presunta pigrizia e apatia delle popolazioni del Sud o per stimolarne paternalisticamente l’anelito al cambiamento. Oggi questo luogo comune è ripreso e ribaltato rispetto al suo significato originario nel tentativo di rispondere a forme di neorazzismo culturale antimeridionale o a preoccupazioni igienico-sanitarie e ambientali riguardanti la produzione di cibo. Ma si tratta di uno stereotipo costruito agli albori della modernità che stravolge un tempo e un concetto propri della civiltà urbana che risalivano all’antichità e non avevano le accezioni esclusivamente negative assunte nel XVIII secolo.
Il tempo e il concetto di “lentezza” e di “ozio” andrebbero, pertanto, ripresi dalla tradizione antica occidentale che li vedeva in constante contraddizione con quello di “affari”. Come più volte è avvenuto in passato, occorrerebbe dare anche nell’attuale società nuova forma a tale contraddittorietà senza la pretesa di volerla superare.
Otium e negotium nella civiltà urbana
La civiltà urbana appare, infatti, da quando è sorta (le prime testimonianze archeologiche di questa forma di vita nell’ambiente mediterraneo risalgono agli anni 3500-4000 a. C.), come un continuo alternarsi di crisi e fioriture contrassegnate dall’atteggiamento duplice e contraddittorio degli individui che condividono la vita cittadina. Da una parte ci rivolgiamo alla città come a un luogo nel quale ritrovarci, sostare bene ed essere in pace: un luogo di otium, di scambio umano, sicuramente fattivo, intelligente, un luogo dove dedicarsi agli studi. E da un altro, chiediamo alla città di essere funzionale, un luogo dove muoversi con facilità e poter sviluppare nel modo più efficace e col minimo d’impedimento i nec otia, i negotia, i nostri affari. Alla città continuiamo cioè a chiedere due cose opposte. Quando essa delude troppo e diventa solo negozio, allora incominciano le fughe dalla città, così ben testimoniate dalla nostra letteratura: le arcadie, le nostalgie per una più o meno mitica età non-urbana. D’altra parte, quando la città assume davvero i connotati dell’agorá, ci affrettiamo a distruggere questo tipo di luogo perché contrasta con la funzionalità della città.
Fin dall’antichità, la lentezza e l’ozio si sono dunque dovuti conciliare con la funzionalità e il tempo degli scambi mercantili. Ma non avevano mai assunto un valore completamente negativo. Per Cicerone l’otium è strettamente legato al negotium: il tempo dedicato alla cultura è importante quanto quello dedicato alle attività pratiche e alla politica.
L’urbanistica contemporanea si è dimenata lungamente tra soluzioni culturaliste attente al contatto con la natura e al vicinato, fino alla “Città-giardino” di Howard, e soluzioni razionalizzatrici sempre più audaci, fino alla “Ville Radieuse” e “Chandigarh” di Le Corbusier.
La lentezza come stereotipo negativo
La critica alla lentezza e all’ozio viene elaborata nei paesi protestanti, calvinisti e giansenisti dell’Europa continentale contro i meridionali, cioè gli abitanti di tutte le regioni italiane. E viene basata soprattutto su fattori climatici. Sarebbe il caldo a favorire il temperamento ozioso e indolente degli italiani e, dunque, l’arretratezza economica, civile e morale consolidatasi in molte aree della penisola.
Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo si afferma l’idea che l’Italia può recuperare l’antico splendore se i ceti dominanti e quelli subalterni abbandonano comportamenti disdicevoli. E siffatti comportamenti sono attribuiti non solo alla geografia ma anche a condizionamenti etnici e religiosi, che avrebbero reso gli italiani una popolazione di poltroni, viziosi, superstiziosi, apatici. E una tale idea viene fatta propria dagli illuministi prima e dai patrioti risorgimentali poi per sollecitare nel Mezzogiorno d’Italia la consapevolezza di un cambiamento necessario.
Insomma, da uno stereotipo che arrivava da fuori si passa addirittura a uno stereotipo autoimposto.
La vera misura della vita contadina è stata la fretta
In realtà, come ricorda l’antropologo Vito Teti, nelle antiche comunità rurali nessuno faceva la bella vita, né si poteva permettere di fare le cose con lentezza. La fatica, la dipendenza dalla natura, la precarietà, la soggezione ai padroni erano gli elementi che caratterizzavano le campagne di tutta Italia. Il grande storico Fernand Braudel ricorda i campagnoli scheletrici ridotti alla fame nelle cattive annate, le carestie ricorrenti, le malattie, la malaria e la peste. “E ogni volta bisogna affrettarsi, approfittare delle ultime piogge di primavera o delle prime autunnali, dei primi o degli ultimi giorni buoni…”
Fame, fumo, cimici, vento, acque piovane, animali popolavano i miseri tuguri di famiglie con non meno di dieci figli. I medici e gli operatori sociali che andavano a verificare le condizioni di salute dei contadini riconducevano debilitazione fisica e depressione degli individui a una fatica estenuante e ad una fretta inenarrabile, a impossibilità di riposo e di sosta, ad un’alimentazione carente.
Nelle comunità contadine non esisteva né l’idea di perdere tempo né quella di non avere tempo. Anche l’organizzazione dei riti e delle feste era meticolosa e carica di tensione. Le processioni, coi santi che corrono, si svolgevano sotto il segno della fretta. Svaghi, giochi, scherzi erano legati alla mietitura, alla raccolta delle olive, alla vendemmia, alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti, allo svolgersi delle fiere. Vivere assecondando i ritmi e i colori delle stagioni non significava mai essere in ozio o inattivi, ma anzi sempre in tensione e mai distratti.
Associare, dunque, l’idea della lentezza e dell’ozio alle campagne e al Mezzogiorno è stato uno stereotipo negativo inventato per denigrare le popolazioni rurali e meridionali oppure, quando l’intento non era malevolo, per sospingerle a migliorare se stesse.
E oggi coloro che rimpiangono, nostalgicamente, la lentezza della vita contadina, in realtà non fanno altro che fingere di ricordare con rammarico un passato inesistente. E colpevolmente rimuovono, invece, una storia di fatica, di etica del lavoro, di mutuo aiuto e di reciprocità che costituisce il patrimonio umano e morale più prezioso e autentico lasciatoci in eredità dalla società civile delle campagne. E’ davvero sorprendente la quantità di piccoli e grandi progetti, finanziati con risorse pubbliche, che si fondano sulla base di una storia immaginaria e sulla cancellazione di quanto di nobile ci ha consegnato il passato.
La lentezza come cattiva utopia
L’elogio della lentezza come valore in sé, sganciata dal rapporto dialettico che deve necessariamente e perennemente intercorrere tra ozio e affari, nasce tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento con la critica alla modernità occidentale e alla società capitalistica. Anche Bertrand Russell si fa attrarre dall’idea di una presunta lentezza mediterranea proibita alle popolazioni del Nord.
Oggi la lentezza come pratica di vita attribuita alle persone del Sud e delle campagne di ieri e di oggi viene esibita da talune élite culturali come elemento di superiorità. E costituisce il fondo di una visione utopica per imporre un modo diverso di vivere che dovrebbe liberare l’uomo dalla fretta, dall’efficientismo e dalle attività frenetiche. Si inventa così una storia del Mezzogiorno e delle campagne come “mondi a parte”, che non avrebbero avuto alcuna interazione con la scienza, con l’economia di mercato e con lo sviluppo capitalistico, mitizzando stili di vita e modelli produttivi che in realtà non trovano alcun riscontro nelle fonti storiografiche.
Come osserva acutamente il sociologo Domenico De Masi, la domanda di lentezza proviene da persone che vivono nella fretta e manifestano nostalgia per una vita che non possono e non desiderano praticare totalmente. Spesso non si tiene conto che tale domanda è associata ad un’altra altrettanto forte di funzionalità, di efficienza, di miglioramento delle condizioni materiali e spirituali di vita. In passato, la presunta lentezza delle persone in cucina e a tavola – ma non vale soltanto per quelle del Mediterraneo – era un tutt’uno con un mondo di privazioni, di penuria e di fretta. Altroché “mangiare lenti”, i contadini spesso mangiavano soltanto “pane e coltello”, pane asciutto, un cibo insufficiente e consumato spesso velocemente o in grande solitudine sul posto di lavoro. Oggi la lentezza come bisogno nuovo di essere a tavola, nella vita, nel mondo non si può disgiungere dalla crescita economica, dalla creazione di posti di lavoro, dall’innovazione. Non può non confrontarsi e interagire con l’insieme della società, superando lo stereotipo – e spesso l’autostereotipo – dell’agricoltura e del Mezzogiorno come “mondi a parte”.
Lo slow food che si autopercepisce come modello eticamente superiore e combatte con spirito crociato gli altri modelli culturali è un privilegio di persone cresciute nell’abbondanza, insoddisfatte, che possono accedere ad un’ampia varietà di cibi. Ma si tratta di un movimento poco spendibile per affrontare il complesso delle sfide della modernità perché si basa su fondamenti culturali molto labili e su tradizioni inventate senza alcun riscontro con la realtà.
Il bisogno di lentezza che la nostra società post-industriale e post-metropolitana manifesta – almeno dagli anni Settanta quando incomincia a farsi strada la consapevolezza dell’insostenibilità dei meccanismi moltiplicativi tipici della modernità – va affrontato nella sua storicità. E dunque tornando a fare i conti con la ciclicità della dialettica otium e negotium che ha caratterizzato fin dalle origini la vita delle nostre città.
Oggi però non ci sono più le vecchie città e non c’è più il vecchio mondo rurale ma ci sono i territori. E con la fine della società industriale e del paradigma dello sviluppo quantitativo e illimitato si conclude anche il ciclo delle metropoli che ne costituivano il fulcro. I territori contemporanei sono ora fatti di spazi indefiniti, in cui gli eventi accadono sulla base di logiche che non corrispondono più ad un disegno unitario d’insieme. Quando si parla di nuova ruralità, di rurbanizzazione, di società delle reti, si fa riferimento a questo scenario che mette in discussione ogni autoreferenzialità di ceti, corporazioni e saperi specialistici e unidisciplinari. Non ci sono più “mondi a parte”, separatezze e muraglie da imporre o da autocostruire, modelli superiori da ergere come fortini gli uni contro gli altri.
In siffatta situazione, è cattiva utopia ritenere che la domanda di lentezza e di spazi per l’ozio possa prevalere su quella che riguarda la funzionalità, l’efficienza, nonché la velocità e la simultaneità dei tempi che contraddistinguono la nostra vita. Né sarebbe una risposta soddisfacente relegare i momenti della lentezza e dell’ozio in spazi chiusi, in recinti, in fortini, dove rifugiarsi al week-end per poi rituffarsi, ancor più alienati di prima, nella frenesia della vita quotidiana. Non potremmo mai sentirci abitanti in luoghi segregati dal complesso dei territori in cui viviamo.
La gestione comunitaria dei territori
Come afferma Massimo Cacciari, nel tempo del “general Intellect” e della Mobilitazione universale, dovremmo dare una nuova configurazione ai corpi che compongono i territori contemporanei, non più né urbani né rurali; corpi che dovrebbero potersi “deformare” o trasformare durante il loro movimento; corpi elastici, spugnosi, molluscolari che dovrebbero potersi accogliere l’un l’altro, penetrare gli uni negli altri; corpi polivalenti non solo in quanto capaci di inglobare in sé diverse funzioni, ma in quanto intimamente in relazione gli uni con gli altri, in grado di riflettersi vicendevolmente. Lo spazio complessivo di cui avvertiamo il bisogno per il nostro buon vivere potrebbe così risultare dall’interazione dei suoi diversi corpi. Questi funzionerebbero come monadi capaci di tenere in sé la logica dell’intero. Si tratta di applicare all’abitare nostro, di questo tempo le nuove General Purpose Technologies (Gpt) già oggi molto promettenti per gli sviluppi futuri (Ict, microelettronica e nanotecnologie, biotecnologie, neuroscienze, robotica, materiali avanzati, fotonica).E così si potrebbe realizzare una individualità universale.
Partendo da tale ottica, è interessante vedere come l’agricoltura del terzo millennio si va spontaneamente riorganizzando. Lo sta facendo lungo tre traiettorie di sviluppo che appaiono contraddittorie tra di loro ma in realtà andrebbero considerate complementari. Un primo percorso è quello perseguito dall’agricoltura industrializzata, che adegua continuamente la dimensione di scala e adotta volontariamente strategie di sostenibilità ambientale e sociale per poter sopravvivere. Il secondo è quello dell’agricoltura multifunzionale che realizza economie di scopo e crea nuovi mercati. Infine esiste l’agricoltura che disattiva la funzione produttiva per privilegiare altre attività come la creazione di energia, la fornitura di servizi sociali, culturali, ambientali e ricreativi oppure la realizzazione di nuovi modi di abitare.
Purtroppo questi tre percorsi sono visti da alcune élite culturali, politiche ed economiche in contrapposizione tra loro e si vorrebbe superare tale contraddittorietà scegliendone uno per annullare gli altri. Si tratta di una visione suicida che porterebbe all’irrilevanza l’insieme dell’agricoltura.
La decisione di adottare una delle tre strategie dovrebbe, invece, rimanere nella sfera delle scelte individuali e non assunta deterministicamente dalle politiche pubbliche. Queste dovrebbero garantire pari opportunità agli operatori per far convivere i tre modelli in modo armonioso. In tal modo si potrebbero ridurre gli aspetti negativi, esaltare quelli positivi e alimentare le interconnessioni e le contaminazioni al fine di accrescere la coesione sociale e la qualità dei territori. E così l’agricoltura potrebbe continuare a costruire – così come ha fatto fin dal suo apparire 10 mila anni fa – luoghi comunitari adeguati all’uso, regolati da norme comuni e corrispondenti alle esigenze e ai problemi di questo tempo.
La stessa impostazione andrebbe perseguita in altri ambiti dell’economia al fine di pervenire ad uno sviluppo equilibrato e fortemente interconnesso.
Ma tale esito non è scontato. Si può ottenere a patto che si creino forme comunitarie di gestione dei territori e si improntino i comportamenti individuali alla fraternità civile, al mutuo aiuto e alla reciprocità. Si tratta di costruire una nuova società civile, capace di alimentare di nuova linfa le istituzioni e il mercato, rigenerando lo spirito di quei legami sociali che hanno caratterizzato – questi sì e non già la lentezza e l’ozio – le comunità rurali del passato e di cui la modernità ha ritenuto di disfarsi, considerandoli ingombranti e pericolosi fardelli.
Foto di Luigi Caricato, Marche, Recanati, Agriturismo Il Crepuscolo
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

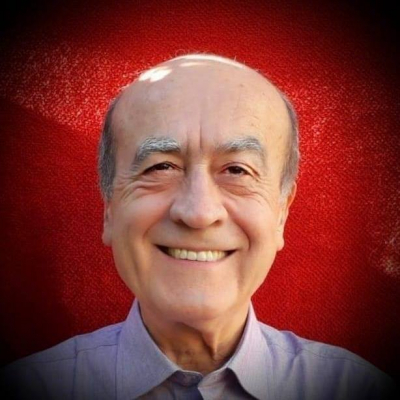
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.