La pandemia “covidica”. Salviamoci dalla retorica catartica
Elementi per un progetto di adattamento della società al Covid.
Ripartire dalle idee, non trascurando di considerare il dramma degli esclusi e di avere il coraggio di riconoscerci tutti vulnerabili. Molti paesi si trovano oggi di fronte a quello che potremmo chiamare il “trilemma del coronavirus” e possono scegliere solo due delle seguenti tre opzioni: limitare le morti, allentare le restrizioni o difendere le libertà civili

La pandemia “covidica” ha dato la stura a complottisti, catastrofisti, palingenetici, millenaristi e ogni sorta di ideologisti per confermarsi nelle proprie verità incrollabili e individuare nel coronavirus il provvidenziale alleato che porterebbe a termine l’agognata azione distruttiva e purificatrice, nell’incuranza dei destini concreti dell’umanità. Gli esempi li ha ben enucleati Mario Campli in Pandemia e Palingenesi. Ne cito solo due tra i più significativi. «La Terra contrattacca l’umanità con il coronavirus» ha tuonato Leonardo Boff, passato dalla teologia della liberazione all’ecoteologia. E ha continuato: «L’ipotesi che propongo è che, a questo punto, i ruoli sono stati invertiti. Essendo un super-organismo vivente, la Terra reagisce, contrattacca e si vendica dell’umanità, perché come dice il Papa nella sua enciclica ecologica “mai abbiamo maltrattato e ferito la nostra Casa comune come negli ultimi due secoli” (n. 53). Ora, arrabbiata, Gaia grida: “Basta! Sono una madre generosa, ma ho dei limiti insormontabili alla mia vita. Devo dare lezioni serie a questi miei figli e figlie ribelli e violenti. Se non hanno imparato a interpretare i segni che ho mandato loro e non mi rispettano e non si prendono cura di me come loro Madre, forse non li voglio più sul mio suolo”. Penso che il Covid-19 sia uno di quei segni, non l’ultimo ancora, ma abbastanza letale da scuotere le basi del nostro tipo di civiltà. I biologi temono che potremmo essere vittime del cosiddetto Next Big One (NBO), un ultimo così letale e inespugnabile che è in grado di porre fine alla specie umana». Un’ambientalista indiana, Vandana Shiva, è arrivata a dire che lo spillover dei nuovi supervirus è causato dagli Ogm, deducendone la conferma della sua visione esoterica e complottista: «Un piccolo virus può aiutarci a fare un grande passo avanti nella fondazione di una nuova civiltà ecologica planetaria basata sull’armonia con la natura. Oppure possiamo continuare a vivere la fantasia del dominio sul pianeta fino alla prossima pandemia. E infine, all’estinzione. La Terra andrà avanti, con o senza di noi».
Fortunatamente abbiamo potuto giovarci in questi giorni di riflessioni serie come quelle di Franco Ferrarotti che ha negato alle conseguenze della pandemia la patente di “crisi di civiltà” e ha affermato: «Le crisi sono sanguinose, ma l’emergenza attuale fa letteralmente “emergere” i veri problemi. Siamo come il viaggiatore di Marco Aurelio che ha dimenticato lo scopo del viaggio». Conviene, dunque, interrogarci se non sia giunto il momento di rispondere alle domande di senso e di responsabilizzarci convintamente. Anche Biagio de Giovanni ritiene che una pandemia capace di unificare il mondo «potrebbe lasciare qualche traccia: un momentaneo ridimensionamento della volontà di potenza, un attimo solo, in cui il mondo si mette a pensare sul male, sulla sua capacità di unificazione, e afferra, in un baleno, che nel fondo siamo sempre al punto di partenza di tutto, e che bisogna ridurre l’albagia che ci fa considerare padroni di noi stessi. Un pensiero più modesto sul finito si può forse produrre. Ma potrebbe darsi il contrario. Che, approfittando delle debolezze di alcuni, la volontà di potenza più forte colga l’occasione per manifestarsi più aspra che mai. Le conseguenze della malattia-mondo possono essere tra loro opposte, tutto fuorché capaci di redimere l’umanità». E infine Jürgen Habermas afferma che l’emergenza «impone a tutti una spinta riflessiva che, fino ad ora, era l’attività degli esperti: dobbiamo agire nella conoscenza esplicita della nostra non conoscenza». «Oggi – continua il filosofo tedesco – tutti i cittadini stanno imparando come i loro governi devono prendere decisioni con una chiara consapevolezza dei limiti di conoscenza dei virologi che li consigliano. La scena che vede l’azione politica immersa nell’incertezza è stata raramente illuminata in modo così brillante. Forse questa esperienza almeno insolita lascerà il segno sulla coscienza pubblica». Forse si incomincerà finalmente a comprendere l’urgenza di costruire un rapporto corretto tra politica e scienza. Dice la senatrice e scienziata Elena Cattaneo: «La scienza mira a studiare l’ignoto per restringere gli spazi dell’incertezza. E anche in questo caso, sul nuovo coronavirus, sta lavorando per fornire le risposte migliori. Al momento non le ha tutte, stiamo parlando di un’epidemia che in questi termini si verifica dopo 100 anni, nella straordinarietà di un mondo popolato da 7 miliardi di persone sempre più interconnesse. […] Gli scienziati devono essere al fianco delle istituzioni quando si prende una decisione, fornire le informazioni derivate dal metodo scientifico e dal contesto dei principi etici a cui lo scienziato deve obbedire, assicurarsi che siano ben comprese e non vengano distorte o manipolate. Poi il politico decide. Ma non finisce lì. Si osservano le conseguenze della decisione, ad esempio gli effetti della chiusura delle scuole, e si raccolgono le critiche». Dopo decenni di pseudoscienza e di rapporti strumentali della politica con ogni sorta di ciarlatani e sciamani per avvalorare scelte capaci di attrarre facile consenso (dalla vicenda Stamina alle campagne anti-vax), alla modalità tratteggiata dalla senatrice Cattaneo bisognerà arrivare con un percorso di apprendimento collettivo.
Il dramma degli esclusi
C’è una questione cruciale che è esplosa in questi giorni: la vicenda dell’atteggiamento discriminatorio nei confronti degli “esclusi”, dei soggetti “vulnerabili” e degli anziani. I medici si sono trovati dinanzi a scelte tragiche sulle priorità da seguire nell’utilizzo dei respiratori, che si sono rivelati insufficienti per tutti i pazienti. Quando il vaccino verrà prodotto – non basterà per tutti, almeno nelle prime fasi – chi sarà vaccinato per primo? Le linee guida, che in molti stanno già adottando, specificano i criteri di scelta: nello stato del Tennessee, per esempio, chi soffre di atrofia muscolare spinale non può avere accesso alla terapia intensiva. In Minnesota, invece, sono coloro che soffrono di malattie polmonari e cardiache ad essere esclusi per primi. Nello Stato di Washington così come in Alabama, Tennessee, Utah, Minnesota, Colorado e Oregon, spetta ai medici decidere sulla base del livello di abilità fisica e intellettiva dei pazienti. Non è una novità. Durante l’epidemia mondiale di influenza aviaria, negli Stati Uniti, gli anziani e i disabili sarebbero stati gli ultimi a ricevere il vaccino.
E c’è un altro dato, fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, che lascia esterrefatti. In circa mille Rsa italiane dal primo febbraio ad oggi ci sono stati 2.724 decessi. Quelli dovuti al Covid sono stati 364 e quelli a seguito di sintomi simil-infuenzali sono stati 2.360, ma che fanno pensare comunque al coronavirus, anche se alla persona morta non è stato fatto il tampone. In tutto, le morti degli ospiti di queste strutture (anziani non autosufficienti) sono state 6.773, quindi quelle che sono o potrebbero essere legate alla pandemia rappresentano il 40 per cento.
Ma una vera e propria bomba è arrivata da Bruxelles. In un’intervista, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto di “tenere gli anziani al sicuro”, chiusi in casa, fino a Natale. La motivazione è preservarli dal contagio. Un finto buonismo che nasconde un’idea del vecchio come individuo molesto. Dice Ferrarotti: «La vecchiaia è considerata nei suoi aspetti legati alla decadenza fisica e non come tesoro di esperienze esistenziali. Questo ha interrotto la continuità tra le generazioni. […] In una società bene ordinata, i vecchi dovrebbero essere visti come testimoni del valore di ciò che sembra superfluo e invece è essenziale. […] È una “devianza” pericolosa che ha per bussola le strategie operative che danno cittadinanza attiva al vigore, al tornaconto, alla rendita e ad altre qualità nei vecchi sbiadite; così da farli diventare, in termini economicistici, un valore marginale». Emergono così quei “veri problemi” a cui allude il sociologo e che non abbiamo ancora voluto affrontare. Come liberarci dei residui di utilitarismo e dei limiti del contrattualismo? Forse è giunto il momento di farlo.
La teoria rawlsiana della giustizia
Le teorie politiche della società maggiormente accettate oggi si fondano su un’idea di contratto sociale attraverso il quale i cittadini si accordano sulle regole di base della loro convivenza, su come spartirsi in maniera efficace i benefici della vita associata e su come assegnare opportunità e risorse secondo giustizia. La versione più avanzata di questa impostazione è probabilmente la teoria della giustizia di John Rawls, il filosofo politico più influente del XX secolo. Nell’approccio al tema della giustizia elaborato da Rawls, si suggerisce che tutti i cittadini debbano essere ritenuti uguali e, in virtù del cosiddetto “principio di differenza”, se qualche disuguaglianza può essere tollerata nella creazione di un sistema di protezione dei diritti, essa debba andare a vantaggio del gruppo dei soggetti più svantaggiati. Le azioni politiche quindi devono essere orientate alla massimizzazione del benessere di coloro che hanno meno, che si trovano in una condizione di maggior sofferenza.
Eppure anche nell’impostazione contrattualistica, proprio per il suo fondarsi sull’idea di contratto, troviamo crepe e contraddizioni profonde. Il contratto, infatti, si fonda sulla possibilità di un mutuo vantaggio. È un contratto che per definizione origina dall’incontro di soggetti razionali, autonomi e indipendenti, i cui interessi individuali, opportunamente coordinati dal vincolo nascente, determinano la possibilità di reciproci vantaggi e benefici. Ma non sempre e non tutte le relazioni possono fondarsi sul mutuo vantaggio. Per questo, per esempio, la logica contrattuale non riesce a cogliere, a spiegare e quindi a legittimare quelle relazioni che coinvolgono soggetti non pienamente autonomi e indipendenti, che assumono, per questo la posizione di “esclusi”. Come possiamo, infatti, giustificare in termini contrattuali, cioè fondandola sul potenziale vantaggio reciproco, una relazione che coinvolge un soggetto che non ha niente da dare ma tutto da ricevere? L’unica possibilità è quella di escludere tali soggetti dalla fase di elaborazione e stipula del contratto sociale originario. La società si occuperà di loro in seguito, come afferma Rawls, solo nella successiva fase legislativa, una volta, cioè, che gli autonomi e gli indipendenti avranno trovato un accordo sulle regole da usare per distribuire i frutti della cooperazione.
Ma allora, nei confronti degli esclusi la giustizia non è più giustizia vera, perché non c’è partecipazione attiva alla scelta delle regole, ma diventa esclusivamente paternalismo e pietà istituzionale. Come ha rilevato Vittorio Pelligra, «non è difficile rinvenire in questa impostazione di fondo, molto più che nei vincoli del bilancio pubblico, la causa remota alla base della già richiamata rottura dei patti intergenerazionali, delle resistenze verso le società multietniche e più in generale della crisi profonda delle politiche pubbliche negli ambiti dell’istruzione, della sanità e del welfare più in generale». Una crisi che va oltre gli aspetti istituzionali riferiti alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e investe alcuni principi di fondo delle democrazie contemporanee.
Come possiamo definire una società che si dà regole che penalizzano proprio coloro che sono più deboli e vulnerabili? Probabilmente non “giusta”. Una società giusta, infatti, non esclude “gli esclusi”. Ma se, allo stesso tempo, non possiamo fondare la nostra convivenza né sull’autonomia, né sull’indipendenza dei partecipanti, né tanto meno sui reciproci benefici derivanti da un accordo contrattuale, dove possiamo rinvenire un fondamento più basilare ed originario del contratto? Cosa ci rende veramente tutti simili? Come ci unisce nel profondo rendendoci uguali e ugualmente degni di riconoscimento? Probabilmente solo la constatazione della nostra vulnerabilità e della reciproca dipendenza che essa genera. Tale vulnerabilità, da una parte, riguarda gli esclusi in maniera più evidente, ma essa non risparmia nessuno degli altri, noi inclusi, che in un momento o nell’altro della nostra vita, per un periodo più o meno lungo, abbiamo fatto, facciamo e faremo l’esperienza di tale vulnerabilità e dipendenza.
Riconoscerci tutti vulnerabili
Sono proprio questi i giorni della vulnerabilità. Cosa sono questa pandemia e questa quarantena se non un’esperienza concreta e tangibile della nostra fragile condizione di vulnerabilità? Come singoli e come comunità. In che modo, allora, vulnerabilità e dipendenza possono essere poste a fondamento del legame sociale? Attraverso un percorso che porta dalla vulnerabilità alla dipendenza, dalla dipendenza alla fiducia e dalla fiducia alla responsabilità. La fiducia di chi si affida, nei confronti di chi si prende cura della vulnerabilità altrui, che a sua volta si sostiene sulla “simmetria dei bisogni”, fa sorgere il bisogno di dare cura, l’urgenza di prendersi cura. Allora è proprio questa vulnerabilità e l’interdipendenza che ne scaturisce, a renderci originariamente soggetti sociali. Se, come ha più volte suggerito Martha Nussbaum, consideriamo l’intrinseco valore di colui che è dipendente, il quale, soddisfacendo il bisogno di “dare” cura, con la sua in-abilità ̀ e vulnerabilità, contribuisce attivamente a conferire senso alla vita di chi di esso si prende cura, possiamo capire come ogni relazione, anche quelle caratterizzate dalle forme di dipendenza più estreme, possono sostanziare una logica di scambio, non contrattuale questa volta, ma fondato sulla reciprocità.
Porre l’accento sulla simmetria dei bisogni, sulla vulnerabilità e sulla reciprocità ci aiuta a definire, allora, la direzione verso la quale dovrebbe andare una teoria sociale ed economica del civile che veda nella vulnerabilità e nella dipendenza potenziale, rafforzata dalla norma della reciprocità, l’origine della responsabilità individuale e sociale per gli altri. In una società civile tale richiesta di reciprocità non può rimanere inevasa. Se possiamo, infatti, delegare la responsabilità della cura, non possiamo certo esimerci dal dovere morale che essa venga fornita. La vulnerabilità quindi ci lega gli uni agli altri, e mai, forse, è stato più evidente come in questi giorni, in una relazione biunivoca: sia quando siamo noi stessi dipendenti, sia quando siamo noi a prenderci cura di qualcuno che dipende da noi. Questa non è̀ un’eventualità rara ed eccezionale, quanto piuttosto un’implicazione della nostra stessa natura biologica. Non è̀ difficile comprendere come nessuna società potrebbe vivere più di una generazione se a tale dipendenza i suoi membri non rispondessero in modo adeguato.
È dalla somiglianza nel dolore e nell’umiliazione, dal riconoscimento e valorizzazione delle fragilità e delle ferite di ciascuno, che tutti noi oggi, concretamente come non mai, sperimentiamo che possiamo partire per riprogettare il nostro vivere comune, il fondamento della vita sociale, i criteri di cura, l’idea stessa di sviluppo. Il “dopo” dovrà necessariamente fondarsi su un ripensamento radicale del nostro sistema educativo, della sanità, del welfare, dell’organizzazione del lavoro e, più in generale, del nostro rapporto con l’ambiente che ci ospita. Porre a fondamento di questo progetto la nostra intrinseca vulnerabilità e la reciproca dipendenza può forse aiutarci a pensare e realizzare una convivenza più resiliente e, in fondo, anche più giusta.
Una pandemia darwiniana
Un altro grave problema che la pandemia “covidica” ha fatto “emergere” è che non siamo per nulla attrezzati a ragionare seconda la logica darwiniana dell’evoluzione. Gilberto Corbellini ha spiegato con estrema chiarezza in La pandemia non è hegeliana, ma darwiniana che «il rapporto tra la nostra specie e il virus ha una dinamica evolutiva, i cui esiti non sono predicibili e fluttueranno, come già sta accadendo con i ritorni di fiamma in Asia, per motivi che poco hanno a che vedere con le modalità di intervenire sulla trasmissione, che variano da paese a paese». Il distanziamento fisico non porterà all’estinzione della trasmissione: in realtà si sta solo aspettando che meno persone muoiano o finiscano all’ospedale, per attenuare le misure di restrizione.
Non ci sarà mai un giorno in cui potremo dire di esserci liberati dal virus. E ciò per il semplice motivo che un giorno senza contagi non preclude al fatto che il giorno dopo ve ne saranno altri. Come ha scritto Enrico Bucci, «il contagio zero come traguardo definitivo è una chimera irraggiungibile (il che non significa che non sia possibile avere giorni senza contagi, a livello locale o nazionale). Ogni soluzione deve quindi prevedere la circostanza che dovremo abituarci a convivere con questo e con tantissimi altri nuovi parassiti emergenti. Il fatto di essere noi uomini e donne così numerosi, fortemente interconnessi e capaci di spostarci rapidissimamente in ogni angolo del pianeta, facilita ai virus e ai batteri la possibilità di replicarsi in rapida evoluzione. Ma indietro non possiamo più tornare. Dobbiamo quindi adattarci a questa nuova situazione.
La letteratura sull’epidemiologia evoluzionistica spiega che ogni parassita funziona come insieme di popolazioni distribuite geograficamente, dove prevalgono localmente i fenotipi che si replicano più efficacemente stante la condizione fisiologica degli ospiti. La replicazione del parassita dipende dalle variazioni genetiche in competizione, dalle reazioni biologiche (immunitarie in primis) e dai comportamenti dell’ospite (anche indotti dal virus), nonché dalle misure sanitarie (anche queste in parte condizionate dal virus): le popolazioni virali evolveranno sulla base di caratteristiche come virulenza, infettività, patogenicità, etc. che risultino le più vantaggiose sul piano riproduttivo. La selezione naturale non premia chi è più forte, più debole, più veloce, etc.: è il mero risultato della riproduzione/replicazione differenziale. A fronte dell’ampia circolazione del virus che avviene sotto la guida del caso e della selezione naturale, all’interno dell’ospite avviene un altro processo darwiniano che è strategico evolutivamente, cioè la selezione clonale dei linfociti che rispondono al parassita. Se così stanno le cose, non sarebbe il caso di interrogarci sui rapporti tra parassiti e ospiti in un quadro scientifico-culturale un po’ più utile, più verosimile e più ampio della caterva di numeri utilizzata quotidianamente nella comunicazione e divulgazione? Siamo abituati a ragionare con una logica che Hegel riassumeva efficacemente in questa formula: ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Coi virus e i batteri del nuovo millennio questa logica ci fa prendere molte cantonate. E siccome dovremo adattarci a convivere in futuro con questi parassiti che mutano continuamente, dovremo rimodellare il tutto assumendo il pensiero di Darwin. Non sarà facile questo cambio di mentalità. Eppure, la democrazia potrà sopravvivere ad un replicatore darwiniano, qual è il virus, solo se sarà capace di continuare a garantire la salute e la vita dei cittadini nella nuova condizione. Questa sarà la grande sfida!
Il “trilemma del coronavirus”
Molti paesi si trovano di fronte a quello che potremmo chiamare il “trilemma del coronavirus” e possono scegliere solo due delle seguenti tre opzioni: limitare le morti, allentare le restrizioni o difendere le libertà civili. I paesi asiatici hanno scelto le prime due, a spese della terza. Ma anche il resto del mondo dovrà compiere una scelta, che trasformerà il ruolo e la portata dello stato. Una scelta che diventerà ancor più stringente con la fase due del contenimento della pandemia. Si accresceranno le difficoltà tecniche, matematiche e giuridiche. Non basterà aver scelto l’applicazione per fare il contact tracing. Occorreranno i test sierologici e i tamponi. Occorrerà un’organizzazione sanitaria ultra-efficiente ma anche una strategia pubblica di ampie vedute: nella fase due, quando la visione monodimensionale verrà superata per far posto a una strategia aperta alla complessità dei fenomeni – sanitari, economici, sociali, generazionali, ecologici – non potrà essere più l’organizzazione sanitaria a gestire la leadership. Le imprese, i corpi intermedi, la politica, si dovranno far carico delle scelte e dei rischi connessi. Nella fase due a guidare le decisioni ci vorrà una molteplicità di strumenti e di soluzioni innovative a cui far ricorso per non trovarsi dinanzi a dilemmi intollerabili: salute o economia, privacy o tracciamento, protezione degli anziani o educazione dei bambini. Ma non si potrà eludere la “biosorveglianza”: essa è un’opportunità, ma costituisce anche un rischio per le democrazie liberali. In Ungheria e Polonia l’emergenza sanitaria è diventata un pretesto per restringere le libertà civili attraverso la “biosorveglianza”. La distribuzione della “biosorveglianza” dovrebbe essere la prima preoccupazione per i paladini della democrazia e delle libertà civili. I parlamenti dovrebbero imporre delle scadenze ai poteri di emergenza conferiti ai governi e le istituzioni indipendenti dovrebbero monitorare la concentrazione dei dati. Di norma i cittadini dovrebbero possedere i propri dati e decidere chi può utilizzarli. Applicare questi principi in questa fase turbolenta non sarà facile perché la democrazia liberale è oggi messa in discussione e non c’è una sensibilità adeguata e diffusa per poterla difendere. Ciascuno Stato si troverà dinanzi a queste due opzioni: 1) tra il nazionalismo isolazionista (ogni paese per conto suo) e la solidarietà globale (un piano d’azione globale); 2) fra il controllo totalitario (dall’alto e indiscriminatamente) e l’emancipazione dei cittadini (fare leva sul loro senso civico). Come ha scritto Yuval Noah Harari, «è augurabile che prevalga la seconda opzione in entrambi i casi, altrimenti avremo un mondo chiuso su se stesso, meno sicuro e meno democratico».
La partita politica che si sta giocando nel mondo
La gestione dell’emergenza dovuta alla pandemia “covidica” sta ridisegnando lo scacchiere politico mondiale. L’America decide come al solito qualcosa del destino del mondo. E la sua presidenza che scaturirà alle prossime elezioni sarà importante per capire cosa sarà la globalizzazione. Donald Trump rappresenta un isolazionismo a sfondo populista attraverso il quale ha prodotto una caduta verticale del rapporto dell’America con il mondo come era prima, e soprattutto ha sancito la divisione di quella civiltà che nel suo insieme si chiama “Occidente”. Potremmo avere un globalismo dominato da un’Asia cinese-russa. E con la pandemia questo sbocco potrebbe avere un’accelerazione. Risulta facile apprezzare l’efficacia dell’autoritarismo come soluzione. «E se le nostre democrazie fossero scarsamente pronte? Troppo lente? Bloccate dalle libertà individuali?». Questo ritornello risuonava già prima della pandemia. Se consideriamo la Cina, la situazione sta sicuramente migliorando, ma l’epidemia non è stata ancora sconfitta, neppure a Wuhan. D’altra parte, è vero che a Pechino sono stati costruiti due ospedali in pochi giorni e che il governo cinese non è in mano alla lobby finanziaria, ma, per trarre i benefici di questi due punti a favore, dovremmo forse rinunciare alla democrazia? Sarebbe cambiare totalmente la struttura del mondo, con l’effetto di rendere dominanti gli Stati usciti dalla tragica esperienza del comunismo reale e che oggi rappresentano, in forme anche diverse, una nuova forma internazionale di dispotismo.
Biagio de Giovanni non ha remore nel dire che Cina e Russia costituiscono «la vera destra del mondo globale, nata dalla sinistra quando diventa estrema». E un Occidente diviso e perfino contrapposto al proprio interno, non avrà una vera capacità di resistere di fronte alla nuova egemonia che si disegna. Di qui la straordinaria importanza delle elezioni americane. Quale cultura può resistere a questo stato di cose? In un mondo dove dominano economicismo e finanze più un dispotismo di tipo nuovo, posato su una immane capacità produttiva e volontà di dominio, quale cultura può fronteggiare questo nuovo ordine? Una nuova cultura della sinistra che si oppone al dispotismo, sorretto da una potenziale egemonia globale, può dunque diventare utile. Non si tratta di opporre ostracismi alla Cina e alla Russia, ma misura e cultura nel rapporto necessario. Tra società aperta e società chiusa, la sinistra dovrebbe fare una netta scelta di campo per la prima. E per restare fedele alla sua vocazione all’eguaglianza, in un mondo che vede nascere nuove disparità e ingiustizie, la sinistra dovrebbe farsi carico di ridare forza politica e sociale a quei processi di costituzionalizzazione sovranazionale, rimasti i soli capaci di nuova eguaglianza, ma oggi presi nella morsa del populismo. Ha scritto Jürgen Habermas: «Mentre lo stato di diritto e lo stato sociale si possono garantire, in linea di principio, anche senza democrazia, i diritti di partecipazione politica, i quali fondano la cittadinanza politica attiva, ossia l’esercizio pubblico dell’autonomia, per estendersi oltre gli Stati hanno necessariamente bisogno di un ordinamento democratico sovranazionale». Il cittadino potrà esercitare la propria sovranità nel proprio Stato e in una dimensione sovranazionale solo se la cittadinanza politica attiva è in grado di esprimersi in una democrazia oltre lo Stato. Non si tratta di porsi l’obiettivo utopico di realizzare la “repubblica mondiale” o una qualche forma di stato sovranazionale. Sono sufficienti architetture procedurali che permettano al cittadino di partecipare alla scelta degli obiettivi e all’individuazione e realizzazione degli interventi con essi coerenti. Al momento tali architetture sono molto deficitarie dal punto di vista democratico. L’entità sovranazionale più consolidata, l’Unione Europea, dovrà porre mano alla definizione democratica della propria governance. In base all’art. 48 del Trattato sull’UE, il Parlamento Europeo dovrà aprire il Semestre Europeo Costituente e predisporre un progetto di revisione del Trattato da negoziare con gli Stati membri. Il progressivo rafforzamento delle architetture istituzionali sovranazionali è la sfida che i cittadini consapevoli dovranno affrontare se vorranno superare la propria condizione di “sudditi” o “clienti” di poteri che sfuggono al controllo democratico.
Sarà dunque necessario giocare una difficile partita su molti fronti. Ma forse proprio la tragica situazione che ci attende potrà stimolare nuove classi dirigenti dell’Occidente, da riunire e rivisitare, e permetterci di elaborare inediti strumenti di governo della vita comune, ridando significato a democrazie che si vanno inaridendo.
Un grande progetto di adattamento all’era “covidica”
D’ora in poi, la parola d’ordine dovrà essere “adattamento”. Ma per progettare l’adattamento all’era “covidica”, bisognerà connettere strettamente la fase dell’emergenza con quella della ripartenza. Ma nessuna riflessione pubblica è davvero iniziata su come ripartire. La fase 2 annunciata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è una finzione. Continua la sfilza di decreti che contengono prescrizioni e restrizioni. Con l’aggiunta di elementi grotteschi che riguardano perfino i comportamenti da tenere all’interno delle mura domestiche. La fase 2 deve significare una ripresa graduale delle attività in condizioni di sicurezza. Coloro che vengono «liberati» dal lockdown devono essere sottoposti a screening sistematico e indossare le mascherine per diverse settimane. Altrimenti, l’uscita dal confinamento avrà un esito peggiore di quello dell’inizio della pandemia.
L’elemento connettivo tra la fase dell’emergenza e quella della ripartenza in sicurezza dovrà essere un nuovo modo di concepire il lavoro e la produttività. La prestazione lavorativa va concepita come un progetto di lavoro-benessere della persona che non si realizza solo in presenza e nelle forme tradizionali. Si tratta di adeguare strutturalmente e tecnologicamente i diversi spazi in cui si svolge la nostra vita come se stessimo sempre a casa. È necessario ripensare le attività lavorative (in agricoltura, nelle fabbriche, nei laboratori, negli uffici) affinché lavoro, benessere della persona e tutela ambientale si integrino e non siano mai in conflitto. Tutto quello che può essere “remotizzabile” va “remotizzato”. Tutto quello che può essere automatizzabile e meccanizzabile va automatizzato e meccanizzato. Al centro del nostro impegno vanno posti con forza gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e il modello di economia circolare. Occorre un cambio di paradigma nelle analisi, nelle politiche e nelle azioni innovative dei cittadini, della società civile, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Un modo nuovo di concepire lo sviluppo dovrà guidarci nel trasformare i rischi in opportunità e nel definire scenari di resilienza in un orizzonte di lungo periodo. Il cittadino potrà esercitare la sua sovranità se la comunità in cui opera si attiva per creare sviluppo. Scriveva Giorgio Ceriani Sebregondi (in Lettera a padre Lebret, 1956): «Lo sviluppo non è semplicemente crescita economica ma costituisce un salto di civiltà. È, infatti, l’esito della combinazione dei cambiamenti mentali e sociali di una popolazione, che la rendono atta a far crescere in modo cumulativo e permanente il suo prodotto reale globale». Il cittadino potrà esercitare la sua sovranità se l’economia pone al centro la persona. La massimizzazione del profitto è necessaria come indice sicuro di gestione razionale di un’impresa, ma non deve mai rompere l’equilibrio della comunità. Vincere la sfida dello sviluppo sostenibile richiede un cambiamento di mentalità e un approccio integrato ai singoli problemi. Si tratta di identificare soluzioni possibili per realizzare la transizione necessaria alla sostenibilità dello sviluppo. Occorre minimizzare i costi ad essa connessi e massimizzare i ritorni per i diversi stakeholder. Come scrive Leonardo Becchetti, se si sviluppasse nei consumi il mercato delle informazioni sul rating sociale e ambientale (applicando a questo fine la tecnologia blockchain) e i cittadini-clienti fossero consapevoli e decidessero tutti insieme di “votare col portafoglio” per le imprese migliori, vincerebbero le imprese tecnologicamente più avanzate: quelle che hanno meno bisogno di puntare al ribasso sul costo del lavoro. Al centro dell’attenzione vanno poste: l’equa redistribuzione delle risorse, la buona governance a livello globale, la difesa dei diritti fondamentali della persona, la lotta alla violenza nei confronti delle donne, l’istruzione, la salute, la parità di genere, la riduzione concreta del divario generazionale.
Bisognerà ridisegnare completamente la sanità intesa come “bene comune globale”. Come afferma Gaël Giraud, «abbiamo toccato con mano in questi giorni che la salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno e che siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza». «Anche per i più privilegiati – continua l’economista francese – la privatizzazione dei sistemi sanitari è un’opzione irrazionale: essi non possono restare totalmente separati dagli altri; la malattia li raggiungerà sempre. La salute è un bene comune globale e deve essere gestita come tale». Scrive Giraud in modo condivisibile: «la salute deve essere trattata come una questione di interesse collettivo, con modalità di intervento articolate e stratificate. A livello locale, per esempio, le comunità possono organizzarsi per reagire rapidamente, circoscrivendo i cluster dei contagiati da Covid-19. A livello statale, è necessario un potente servizio ospedaliero pubblico. A livello internazionale, le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per contrastare una situazione di epidemia devono diventare vincolanti. Pochi Paesi hanno seguito le raccomandazioni dell’Oms prima e durante la crisi. Siamo più disposti ad ascoltare i “consigli” del Fondo monetario internazionale (Fmi) che quelli dell’Oms. Lo scenario attuale dimostra che abbiamo torto». Ma la salute è solo un esempio: anche l’ambiente, l’istruzione, la cultura, la biodiversità sono “beni comuni globali”. Dobbiamo immaginare istituzioni che ci permettano di valorizzarli, di riconoscere le nostre interdipendenze e rendere resilienti le nostre società.
Si tratta, in sostanza, di promuovere una particolare forma di organizzazione dei cittadini che solleciti, guidi ed esprima il formarsi di un’autonoma capacità tecnica, politica e giuridica dei cittadini stessi a concorrere alla determinazione delle politiche di sviluppo sostenibile. Preliminarmente occorre reinventare forme e modi nuovi di apprendimento della cittadinanza per rispondere alle seguenti sfide: a) adattamento alle pandemie; b) sostenibilità; c) educarci al metodo scientifico; d) formarci permanentemente a connettere conoscenza tecnico-scientifica e saperi esperienziali; e) educarci alla democrazia all’interno dello Stato e oltre lo Stato. Per reinventare la cittadinanza e le comunità va progettato e promosso un «sistema – per dirlo con le parole di Giorgio Ruffolo – nuovo, organizzativo e di regolazione, un’economia associativa, che abbia la stessa dignità dello stato e del mercato e che si ponga, con un suo equilibrio economico ed una sua impronta imprenditoriale, come risposta strutturale dalla parte della domanda alle nuove esigenze che si creano nell’ambito dell’odierna società». I “beni comuni”, come li ha definiti in particolare l’economista americana Elinor Ostrom, aprono un terzo spazio tra stato e mercato. Possono guidarci in un mondo più resiliente, in grado di resistere a shock come quello causato da questa pandemia.
Il Corpo Europeo di Solidarietà
Ernesto Rossi, autore con Altiero Spinelli e Eugenio Colorni del Manifesto di Ventotene, scrisse in carcere nel 1942 e pubblicò nel 1946 il libro Abolire la miseria. Nella prima metà del saggio egli quasi schernisce tutti gli interventi di “beneficenza” o di “soccorso incondizionato” con i quali ci si illude di debellare povertà e disoccupazione. Nella seconda parte propone la fondazione, a livello europeo, di un “esercito del lavoro”, reclutato in alternativa al servizio militare, che provveda ad assicurare, a spese della collettività, i mezzi essenziali di sussistenza a chi ne ha bisogno.
Nel dicembre 2016, a 70 anni dalla pubblicazione di Abolire la miseria, la Commissione Europea ha ripreso, forse inconsapevolmente, l’idea di Ernesto Rossi, istituendo il Corpo Europeo di Solidarietà per permettere ai giovani tra i 18 e i 30 anni di poter partecipare ad attività lavorative (tirocinio, apprendistato o lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi) o a progetti di volontariato all’interno di organizzazioni che si occupano di solidarietà. I partecipanti potranno essere impiegati in un’ampia gamma di attività, in settori quali: l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’assistenza nella distribuzione di prodotti alimentari, la costruzione di strutture di ricovero, l’accoglienza, l’assistenza e l’integrazione di migranti e rifugiati, la protezione dell’ambiente e la prevenzione di catastrofi naturali.
Nel 2017 è entrato in vigore in Italia il nuovo Servizio Civile Universale. Un’occasione per favorire e sostenere l’impegno volontario e civico dei giovani nel mondo associativo e nelle istituzioni locali. Un’opportunità per conseguire nuove competenze in vista di una successiva attività lavorativa.
Trasmettere da una generazione all’altra la cultura del “saper fare”
Tra gli esiti indesiderati della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica in atto va annoverato il distacco (fino al conflitto identitario) tra le generazioni. Solo la creazione di istanze dinamiche di confronto potrà condurre ad una radicale riconversione della logica del conflitto identitario. Tra i principali scopi dell’economia associativa dovrà essere annoverata la creazione del “lavoro di cittadinanza”. Esso non si configura come vero e proprio accompagnamento di un giovane ad un impiego, ma come spazio simbolico entro cui le differenze tra generazioni diverse si riconoscono e interagiscono per generare impegno lavorativo e vivificare lo “spirito dello sviluppo”, di cui parlava Albert Hirschman.
Il lavoro di cittadinanza è il contesto dove assimilare i principi costituzionali: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1) e “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4). Tali principi contengono l’impegno delle istituzioni a soddisfare l’esigenza degli individui a lavorare e, nel contempo, il dovere di ogni cittadino di essere quello che può in proporzione dei propri talenti. Si attuano iniettando cultura d’impresa da intendere come aspirazione dell’uomo a incivilirsi, a elevarsi, mediante un percorso tortuoso che non ha mai fine per evitare di correre il pericolo di tornare indietro verso la barbarie.
Ernesto Rossi afferma (in Abolire la miseria) senza mezzi termini che la nozione “diritto al lavoro” è un’assurdità che discende dalla «falsa idea che basti produrre delle cose che soddisfino i bisogni umani perché il lavoro risulti economicamente produttivo». Il lavoro non è un diritto che può essere soddisfatto solo dalle leggi sul lavoro. È questa idea molto immiserita di lavoro ad averlo reso un oggetto misterioso. Il lavoro si può creare con il lavoro di cittadinanza, cioè con il dialogo intergenerazionale, la diffusione della conoscenza, il cambiamento della mentalità, l’educazione all’innovazione continua, alla relazionalità e alla speranza del futuro.
In apertura: Cristina Mangini, “Assembramenti n°4”, Pastello su carta, 2020
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

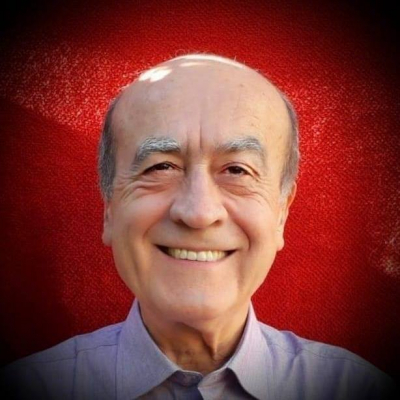
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.