Orti urbani e sociali
Per molti sono un modo di organizzare la propria vita in cui il rapporto con la terra e le sue risorse costituiscono un aspetto importante che completa il proprio modo di essere, fonte di equilibrio e benessere psico-fisico. Le istituzioni li considerano ininfluenti ai fini della sommatoria del Pil, ignorando volutamente l’apporto di tali attività. Tuttavia quando curiamo un campo senza l'assillo di dover venderne i frutti a prezzi convenienti, ma solo per il piacere di fare un regalo unico agli amici, rivitalizziamo la civiltà del lavoro delle tradizioni rurali

Questi visibili nella foto di apertura sono gli orti di Tito, in Basilicata. Si possono considerare orti urbani o sociali come denominiamo quelli che sorgono all’interno delle grandi e medie città? Per certi versi anche questi sono orti che svolgono essenzialmente una funzione di servizio. Da tempo i loro conduttori non vivono più prevalentemente di agricoltura. I componenti delle famiglie che possiedono questi piccoli appezzamenti di terra anche in passato hanno svolto una molteplicità di attività.
Per molti l’orto è un modo di organizzare la propria vita in cui il rapporto con la terra e le sue risorse è un aspetto importante che completa il proprio modo di essere. Fonte di equilibrio e di benessere psico-fisico. I prodotti dell’orto sono prevalentemente o esclusivamente destinati all’autoconsumo familiare.
Il 41 per cento della popolazione italiana è coinvolta in questa modalità di fare agricoltura. La superficie interessata è una parte consistente del paesaggio rurale del nostro Paese.
Non svolgendo alcuna attività imprenditoriale agricola, questi cittadini non ricevono la scheda dell’Istat per il censimento agricolo. La cultura economica e di conseguenza le istituzioni li considerano ininfluenti ai fini della sommatoria del PIL e, dunque, ignorano volutamente l’apporto di tali attività alla composizione dei consumi familiari, al consumo di mezzi tecnici e di servizi professionali necessari per svolgerle, alla salvaguardia del territorio e al benessere psico-fisico delle persone.
Negli ultimi 30 anni la superficie agricola si è contratta di oltre tre milioni di ettari. Ma non per questo tali aree sono state automaticamente cementificate come alcuni commentatori continuano a sostenere. “Assumere la differenza tra le superfici agricole tra l’uno e l’altro censimento come misura dell’urbanizzazione è indice di analfabetismo statistico” dice giustamente Corrado Barberis, presidente emerito dell’Insor.
Su questi tre milioni di ettari sono, infatti, impegnati tanti individui che la contabilità nazionale non prende in considerazione nonostante gli indubbi benefici economici, salutistici e ambientali da essi prodotti. Sono proprio queste forme di agricoltura le attività che meglio ci fanno rivivere la concezione del lavoro che esisteva nel mondo contadino. Secondo la cultura rurale il lavoro non era considerato una merce in quanto non aveva valore economico.
Lavorare voleva, infatti, dire riuscire a mangiare ogni giorno ma anche vivere in salute, dormire di notte e svegliarsi di buon’ora con energia ed entusiasmo.
Lavorare significava curare le risorse naturali per riprodurle e rigenerarle a vantaggio delle generazioni successive.
Lavorare, inoltre, voleva dire non avere troppi “grilli per la testa”, cioè vivere con sobrietà e serietà morale.
Lavorare, infine, non doveva mai trasformarsi in forme prolungate di sfruttamento bestiale, a cui i contadini sapevano opporre una resistenza passiva e sottrarsi ricorrendo a volte anche all’astuzia, finché non arrivò il tempo delle lotte organizzate.
Lavorare e vivere con la terra era tutt’uno. E questa concezione del lavoro fu alla base non solo del salto imprenditoriale compiuto da tanti contadini italiani negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, quando al sopraggiungere di talune condizioni indotte dalle politiche economiche dell’epoca dettero vita all’agricoltura moderna, ma anche delle centinaia di distretti industriali per iniziativa di tanti mezzadri che si fecero imprenditori e operai specializzati nei settori manifatturieri.
E siffatta cultura è rimasta nel codice genetico di quei tre milioni di contadini meridionali che tra la metà degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Settanta trasferirono la propria residenza in un comune del Nord.
Dedicando una parte significativa del nostro tempo libero alla cura dell’orto, del vigneto, del frutteto, dell’alveare o dell’allevamento di animali da cortile, scegliamo non solo di mangiare cibo fatto con le nostre mani e di stare meglio in salute, ma di continuare a coltivare l’idea atavica che vuole il lavoro agricolo come unica risorsa capace di arrestare ogni forma di degrado umano, impedire alle popolazioni di regredire nella miseria più nera e guardare alla vita con fiducia.
E’ per questo che quando vediamo le immagini o sentiamo i racconti
di sfruttamento schiavistico, a danno degli immigrati, nelle nostre campagne, siamo presi da un forte senso di ripulsa. Consideriamo ripugnante ogni forma di sfruttamento ma soprattutto quello che viene praticato in agricoltura.
Se noi oggi continuiamo ad apprezzare ogni lavoro e, nello stesso tempo, ricerchiamo anche tutto ciò che possa migliorare la qualità e la consapevolezza della nostra vita, lo dobbiamo alla concezione del lavoro che avevano i nostri antenati contadini.
Quando curiamo un ciliegio senza l’assillo di dover venderne i frutti a prezzi convenienti, ma solo per il piacere di fare un regalo unico agli amici, rivitalizziamo la civiltà del lavoro delle tradizioni rurali.
La foto è di Alfonso Pascale
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

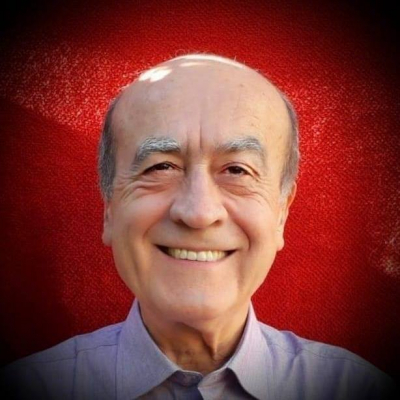
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.