La grande storia umana e letteraria di Giuseppe Pontiggia
A vent’anni dalla scomparsa, riportiamo l’intervista al grande narratore e saggista su un tema alquanto scomodo ma che riguarda tutti, in modo diretto o indiretto: la disabilità. Lo facciamo a partire dal romanzo Nati due volte, con cui l’autore indaga anche se stesso, a partire dalla propria vicenda familiare: “Prendere coscienza del limite significa anche prendere coscienza di se stessi, della propria natura”

Il 27 giugno 2003 lo scrittore Giuseppe Pontiggia morì prematuramente a Milano all’età di 69 anni. È stata una perdita enorme. Ero molto legato a lui, per la bella e profonda persona ch’era e per essere l’autore di libri indimenticabili, la cui opera completa è stata raccolta in un “Meridiano” Mondadori pubblicato nel 2004 a cura di Daniela Marcheschi.
Pontiggia è stato un solido punto di riferimento per molti e in tanti tuttora lo ricordano per la grande eredità morale e intellettuale che ci ha lasciato. Non c’è soltanto la sua imponente e importante opera letteraria, molto apprezzata da critica e lettori, a ricordarci di lui, è anche la sua grande umanità di maestro saggio che lo ha da sempre contraddistinto.
Ai lettori di Olio Officina voglio far dono di una intervista che lo scrittore mi concesse nel 2000, in occasione dell’uscita del romanzo Nati due volte, edito da Mondadori. Un libro di rara sensibilità, scritto con uno stile impeccabile, che da un lato costituisce una grande prova narrativa, di alta letteratura, ma che nel contempo si scopre essere il resoconto della sua personale esperienza di padre la cui vita di un figlio disabile. La condizione di disabilità crea non pochi imbarazzi, soprattutto in una società abituata a esaltare la perfezione della forma e a preferire alla sostanza l’apparenza. La diversità resta ancora un tema scivoloso, arduo e alquanto scomodo da affrontare. Nati due volte, romanzo con il quale Giuseppe Pontiggia si è misurato senza mai risparmiarsi, a lettura ultimata offre esiti straordinari e preziosi proprio per quanti vogliano affrontare la realtà senza eluderla.
È per questo che ho scelto questa intervista, tra le tante che lo scrittore mi ha rilasciato. Ed è il motivo per cui Nati due volte ritengo si possa considerare emblematicamente il punto di partenza per quanti vogliano accostarsi per la prima volta all’opera e alla figura di Giuseppe Pontiggia, traendone, oltre al piacere della lettura, anche l’occasione per crescere come persone.
INTERVISTA A GIUSEPPE PONTIGGIA
L’aver sostenuto un tema così diretto, vissuto giorno dopo giorno sulla propria pelle non è stata un’operazione da poco…
È stato assai difficile. Ho impiegato alcuni mesi per superare una serie di resistenze, e anche di angosce, per i problemi legati alla mia storia personale. Ma ho rinunciato ad essere autobiografico in senso stretto per affidarmi in via privilegiata all’invenzione. Ho cercato così di avvicinare e di scrutare il tema dell’handicap da molte angolazioni, non soltanto presentandolo nella sua veste drammatica, che ci è più abituale, ma anche in quella ironica – attraverso una lettura satirica e perfino grottesca – evitando molto opportunamente di risultare monocolore e di presentare un quadro piuttosto uniforme e chiuso in se stesso. Ho cercato una visione “a scopi” del problema, sia dal punto di vista tematico, sia di quello espressivo, con ciò dimostrando che la materia stessa richiede un approccio molteplice, non più univoco com’è avvenuto finora. Un approccio aperto a molti punti di vista, alcuni dei quali peraltro molto felici e di straordinaria intensità.
La prima difficoltà nell’approccio con il mondo dell’handicap credo che la si incontri sin da subito a partire dal linguaggio, con le sue molte insidie. Il termine “spastico”, ad esempio, dà spesso luogo a malcelati imbarazzi e le difficoltà nel cercare altre espressioni, più “morbide”, sono notevoli. In altri casi, alcune formule espressive, assai poco cortesi, sono addirittura discriminatorie.
Con la stesura del romanzo ho avuto la conferma che effettivamente il linguaggio è il banco di prova delle esperienze. Gli uomini si servono del linguaggio per eludere, per aggredire, per nascondersi, raramente invece per illuminare la realtà nella sua chiarezza. Quindi, anche di fronte al problema dell’handicap troviamo degli atteggiamenti dispregiativi, di chi se ne serve in modo liquidatorio. Troviamo gli atteggiamenti reticenti dei genitori, per esempio, che si difendono attraverso il linguaggio dalla paura di constatare la gravità del problema.
Nella vicenda di cui narro, colui che in fondo dimostra di essere il più equilibrato nella famiglia è proprio il figlio disabile. Questi ha una semplicità straordinaria nel dire le cose come stanno, proprio perché convive con l’handicap dalla nascita e non si difende, attraverso il linguaggio, da una paura che ha già superato. Il padre, facendo peraltro l’insegnante, avrebbe dovuto educare il figlio a muoversi nel mondo, invece nel corso degli anni impara proprio dal figlio ad accettare e a comprendere l’handicap.
Il linguaggio in generale, e in particolare nella situazione della disabilità, richiede una estrema sorveglianza, una grande delicatezza, un particolare riguardo. Attraverso il linguaggio noi difendiamo le nostre esperienze, cerchiamo di attenuarne gli aspetti terribili o di esaltare gli aspetti positivi.
Nel romanzo la famiglia diventa luogo d’elezione, terreno d’incontro e di confronto. Rappresenta come un baluardo a difesa dal mondo esterno, un luogo protettivo sicuro e inattaccabile. Eppure, si scopre che all’interno non tutto è facile e immediato e che le conquiste di ogni giorno sono dure e faticose.
Credo che la forma narrativa possa avere una sua efficacia unica, anche se non esclusiva, nell’affrontare il tema della disabilità, perché mostra dal vivo una serie di elementi, di fatti che concorrono a non farci capire l’uomo, a non farcelo accettare nella sua realtà. Il racconto di una famiglia in cui il padre insegnante impara dal figlio una sorta di arte del vivere, in coabitazione con l’handicap, è un aspetto significativo.
Alla fine si scopre ch’è proprio il figlio a insegnare al padre come va affrontata, con lucidità e serenità, una minorazione. La madre, al contrario, è piena di slancio e dedizione, ma a sua volta proietta nel figlio forme di nevrosi e angosce che le appartengono ma che non riguardano il figlio.
La nonna paterna impiega invece tutta una vita per capire che non è quello che mangia il nipote ad aver senso e valore, ma quello che il nipote ha da dare agli altri, ed è tanto. Il suocero dell’insegnante, un uomo piuttosto autoritario, un igienista, un salutista, non capirà mai e cercherà sempre di illudersi che il nipote possa diventare normale. Come se questo fosse un traguardo importante. Finirà invece con il morire disabile nella mente. Questo aspetto io l’ho raccontato anche in modo grottesco, e perfino comico. Ho inteso mettere in luce come l’handicap della mente, o del fisico, ch’è un limite, nella disabilità fa acquisire aspetti vistosi che in forme comportamentali diverse, ciascuno di noi comunque vive. Tutti noi abbiamo forme di disabilità – emotiva, psicologica, intellettuale – e dobbiamo abituarci a considerare il limite come caratteristica fondamentale della nostra esperienza del vivere. Accanto a questa ragione, c’è anche l’importanza di superare il limite tutte le volte ch’è possibile, ed è necessario e bello. E soprattutto, quando non è possibile superare i nostri limiti, si rende necessario non solo accettarli, ma addirittura amarli. L’uomo, d’altra parte, era comunemente definito dagli antichi con il termine di mortale. Prendere coscienza del limite significa anche prendere coscienza di se stessi, della propria natura.
Leggendo Nati due volte si scorgono tante figure istituzionali messe a nudo senza reticenze e si nota pure, con grande amarezza, il fallimento dei luoghi deputati alla educazione e alla riabilitazione dei ragazzi disabili.
Uno degli aspetti paradossali del romanzo è che la disabilità rivela e mette a nudo la disabilità di coloro che dovrebbero curarla, in particolare i medici e la scuola. Nati due volte mostra l’inadeguatezza, lo sconcerto, l’impreparazione della società nell’affrontare nel modo più adeguato il problema dell’handicap.
Ora, se io faccio un bilancio retrospettivo, vedo che in trent’anni (nota bene, l’intervista, pubblicata da Luigi Caricato sul settimanale Voce del Sud, risale al 2000) la società ha fatto molti passi in avanti. Trent’anni fa il disabile veniva vissuto spesso come una vergogna, quasi una colpa da tenere nascosta. Nella scuola venivano emarginati e destinati nelle sezioni speciali. La medicina era spesso impreparata a prevenire e a curare in modo tempestivo. Molti passi in avanti sono stati compiuti, ma la visione delle persone, la mentalità, deve secondo me colmare ancora una distanza importante. In modi diversi si ripropongono ancora nuove forme di discriminazione, magari fondate su una ideologia che nelle intenzioni vuole essere di aiuto e sostegno, ma che nei fatti poi si rivela inadeguata.
In fondo, il padre-io narrante del romanzo vuole che il figlio venga accettato non come identico agli altri, ma come diverso dagli altri, con una diversità che ha i medesimi diritti, ma che richiede un’attenzione un po’ particolare.
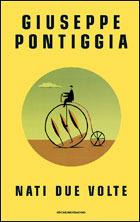
In apertura, ritratto di Giuseppe Pontiggia, illustrazione di Stefania Morgante per Olio Officina
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui


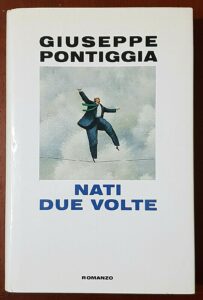


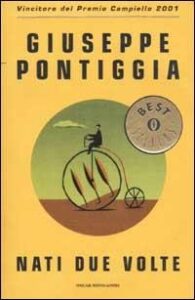


Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.