Ragionando intorno al concetto di disabilità
"Se la maggior parte della gente usasse sedie a rotelle, continueremmo ugualmente a costruire scale invece che rampe d'accesso?". In diversi lavori, la filosofa Martha C. Nussbaum ha analizzato in termini normativi la situazione delle persone affette da disabilità, e da numerose premesse trae la conseguenza che, se un individuo non è in grado di esercitare delle attività nei modi più comuni a causa di una menomazione, la società ha un insieme di ragioni per (ri)organizzare il proprio funzionamento

In diversi lavori, Martha C. Nussbaum, una tra le voci più innovative nel panorama filosofico contemporaneo, ha analizzato la situazione delle persone con disabilità dal punto di vista delle normative.
La conclusione che ne ha tratto è che esse sovente sono nell’impossibilità di esercitare diritti fondamentali di cui pure sono nominalmente titolari.
Il motivo di fondo di tale situazione è che le leggi sono costruite su modelli di pensiero che di fatto non considerano le persone con disabilità soggetti che hanno pari dignità con tutti gli altri individui.
Destinatario dei diritti individuali continua, infatti, ad essere l’individuo razionale, consapevole e indipendente.
Ma la realtà ci mette ogni giorno sotto gli occhi molte situazioni in cui gli individui non possono contare sulle stesse abilità nell’utilizzare le proprie risorse e quindi non possono godere pienamente di una pluralità di diritti.
Da qui l’impegno della filosofa nel contribuire a delineare un progetto etico-politico che tenga conto di tali disparità. Vedi: “Giustizia sociale e dignità umana”, Il Mulino, 2002, pagg. 27-50; “Le nuove frontiere della giustizia”, Il Mulino 2007, pagg. 113-292.
La studiosa parte dalla premessa che gli esseri umani, sotto certi aspetti, sono tutti disabili: sono mortali, hanno la vista debole, soffrono terribili mal di schiena e dolori cervicali, hanno la memoria corta e via dicendo. Ma quando queste menomazioni colpiscono la maggioranza (o il gruppo più potente), la società si adatta per venire loro incontro.
Perciò, non troviamo scale con gradini talmente alti che soltanto Gargantua e Pantagruel potrebbero salirle, né le nostre orchestre impiegano strumenti musicali che emettono suoni a una frequenza inafferrabile all’udito umano e percepibile soltanto alle orecchie dei cani.
Anche nel caso in cui ad alcune persone sia possibile raggiungere con grandi difficoltà e intenso allenamento un certo risultato, noi non domandiamo di fare altrettanto a tutti i cittadini “normali”.
Quindi, non organizziamo il mondo in modo tale che soltanto chi è capace di correre un miglio in quattro minuti può riuscire ad arrivare al lavoro in tempo. Sviluppiamo, invece, determinate “protesi” – ossia automobili, treni, autobus – che ci aiutano a percorrere un miglio in meno di quattro minuti.
Il problema di molte persone nella nostra società è che non si viene incontro al loro handicap, perché le menomazioni di cui soffrono sono atipiche e vengono percepite come “anormali”.
Non esiste una differenza intrinseca “di natura” tra una persona che usa una sedia a rotelle, per muoversi alla stessa velocità di una persona che cammina o che corre, e una persona che usa un’automobile per ottenere un risultato di cui le proprie sole gambe non sarebbero capaci.
In entrambi i casi, l’ingegno umano fornisce uno strumento in grado di supplire alle reali capacità del corpo. La differenza è che le automobili sono molto comuni, mentre le sedie a rotelle sono inconsuete, atipiche. La società viene incontro agli uni, e, almeno fino a un tempo molto recente, ha completamente trascurato gli altri. Noi costruiamo strade, ma non rampe d’accesso per sedie a rotelle (almeno fino a poco tempo fa).
Dovremmo chiederci: “Se la maggior parte della gente usasse sedie a rotelle, continueremmo ugualmente a costruire scale invece che rampe d’accesso?” Ma questa domanda non ce la poniamo e pensiamo che le persone affette da handicap inconsueti siano le uniche ad avere pecche: sono le mele marce del canestro, quelle da buttare via per evitare che possano contaminare le altre.
Da queste premesse Nussbaum trae la conseguenza che, se un individuo non è in grado di esercitare delle attività nei modi più comuni a causa di una menomazione, la società ha un insieme di ragioni particolarmente urgenti per (ri)organizzare il funzionamento della società in modo tale da rendere quelle capacità disponibili a questa persona.
Si tratta di garantire alle persone disabili il diritto di vivere nel mondo, cioè di essere trattati come cittadini per i quali lo spazio pubblico è organizzato e nei cui interessi è mantenuto in efficienza.
Tra i diritti più importanti in gioco che rientrano in questo diritto generale vi sono il diritto al lavoro e il diritto ai mezzi necessari a partecipare efficacemente alla vita politica e sociale. Il fine più appropriato dell’azione politica per venire incontro alle persone deboli è dunque l’opportunità di scegliere e non la “funzionalità”.
Una volta che si fornisce un sostegno ai bisogni umani e alle capacità di queste persone, e il loro campo d’azione è predisposto in modo completo – cioè in aree che vanno dalla vita e dalla salute alla loro piena partecipazione alle attività sociali – la scelta di “funzionare” o meno dovrebbe essere lasciata all’individuo.
Tuttavia, questo percorso è possibile se abbandoniamo l’idea della “normalità” intesa come riferimento di perfezione a cui conformarsi e affrontiamo il problema della debolezza umana come una condizione in cui tutti siamo coinvolti coi nostri differenziati bisogni esistenziali e relazionali.
In “Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge” (Carocci 2007, pagg. 207-263), Nussbaum fa derivare la categoria di “normalità”, con cui stigmatizziamo determinati gruppi di persone, dalla vergogna primitiva che ci riguarda tutti.
Infatti, siccome tutti noi non riusciamo a concretizzare quel senso di felicità che deriva dall’unità primordiale con il ventre materno e di cui dalla nostra primissima infanzia conserviamo un’intensa nostalgia, abbiamo bisogno di una sorta di sostituto di quel senso di sicurezza e completezza. E coloro che si definiscono “normali” trovano questa sicurezza nell’idea di un gruppo molto esteso a cui non manca nulla.
L’idea di “normalità” è perciò simile ad un surrogato del ventre materno.
Naturalmente questo stratagemma richiede una “stigmatizzazione” nei confronti di altri gruppi di persone.
I normali sanno che i loro corpi sono fragili e vulnerabili, ma quando possono bollare con uno stigma le persone fisicamente disabili si sentono molto meglio nei confronti della loro umana debolezza, quasi immortali.
I normali sanno che i loro intelletti sono manchevoli per molti aspetti: tutti gli esseri umani hanno molte deficienze quanto a conoscenza, memoria, capacità di giudizio e comprensione.
Tuttavia, contornati da soggetti mentalmente disabili, bollati come “ritardati”, “idioti”, “mongoloidi”, “pazzi”, i normali si sentono notevolmente saggi e intelligenti.
In breve, proiettando all’esterno la vergogna che essi sono inclini a provare per i propri limiti, marchiando i volti e i corpi degli altri, i normali realizzano una sorta di pienezza surrogata, soddisfano il loro desiderio infantile di dominio e di invulnerabilità.
La filosofa a questo punto sostiene che la nozione di debolezza andrebbe rifondata.
Dovremmo sforzarci di ridurre sempre più fino ad annullare il suo carattere di album fotografico delle varie “menomazioni” – di tipo anatomico, genetico, sensoriale, estetico, neurologico, sessuale, anagrafico, etc. – che valgono a costituire gruppi sociali come intimamente sottodotati, anormali, devianti e così via.
Mentre occorrerebbe concepire la debolezza, guardando al reticolo socio-economico e amministrativo del territorio, come una classificazione dei “luoghi” dove noi viviamo e cerchiamo di inserirci.
La classificazione dovrebbe, dunque, riguardare l’accessibilità o meno ai “luoghi” ostacolata – per coloro che vorrebbero o potrebbero fruirne – da ritardi normativi, da barriere, da insufficienze applicative, da vuoti progettuali e programmatici, dal cattivo uso delle leggi.
Insomma, si tratta di spostare l’attenzione dalle diversità morfologiche delle persone alle “rampe d’accesso” la cui attivazione o il cui miglior funzionamento varrebbero a ridurre di fatto le distanze tra le persone.
Dovremmo mettere al centro il vissuto dei singoli individui, chiarendo quando e in che misura occorra parlare effettivamente di debolezza.
Una volta accertati i termini della specifica “combinazione esistenziale” di ciascun essere, non resterà che misurare poi la distanza fra ciò che fa o può fare una persona in difficoltà, la quale risulti in tutto o in parte abbandonata a se stessa, e un soggetto toccato da identiche occasioni di disagio e portatore di analoghe ragioni interattive, che si veda invece adeguatamente sostenuto nei suoi progetti.
In conclusione, ha poco senso il raffronto, condotto in astratto, tra la squadra dei “forti” da un lato e quella dei “deboli” dall’altro.
Andrebbe, invece, messo a paragone ciò che un individuo fragile si vede costretto a fare o a non fare e ciò che avverrebbe invece nell’organizzazione delle sue giornate qualora fossero vivi intorno a lui i supporti – assistenziali, normativi, comunitari, tecnico-scientifici, formativi, etc. – capaci di neutralizzare, in tutto o in parte, i risvolti reclusivi di quelle manchevolezze.
Ma questo modo di ragionare presuppone il convincimento che esistono non tanto soggetti deboli (dal di dentro) quanto soggetti sempre e solamente “indeboliti” (dal di fuori).
A questi principi si va conformando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che nel 2001 ha pubblicato la “Classificazione internazionale del funzionamento della salute e della disabilità” (ICF).
Questa nuova norma è stata riconosciuta da 191 paesi, inclusa l’Italia. In base alla classificazione ICF la disabilità è definita “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”, nella certezza che non ci può essere definizione di disabilità senza valutazione dell’interazione tra una persona e il contesto ambientale in cui la stessa vive.
È un capovolgimento di logica: mentre gli indicatori tradizionali si basavano sui “tassi di mortalità”, l’ICF pone come centrale la “qualità della vita” delle persone affette da una patologia, permette quindi di evidenziare come i contesti ambientali convivono con la loro condizione e come sia possibile migliorarla affinché possano contare su un’esistenza dignitosa.
In questo modo, la disabilità non è considerata più solo un attributo della persona, ma un insieme di condizioni potenzialmente restrittive derivanti da un fallimento della società nel soddisfare i bisogni delle persone e nel consentire loro di mettere a frutto le proprie capacità.
Olio Officina da sempre pone attenzione alla tematica dell’inclusività, dedicando ampio spazio a considerazioni ed esperienze. All’undicesima edizione di Olio Officina Festival, Anna Gioria, Serena Mela del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia e Alfonso Pascale, storico dell’agricoltura e studioso di agricoltura sociale, hanno raccontato questo mondo soffermandosi su come il settore oleario si pone in questo contesto e cliccando QUI potete leggere le loro considerazioni a riguardo.
Un’altra ricca testimonianza che trovate sul Magazine è a firma di Anna Gioria, Alla ricerca dell’olio e dei frantoi accessibili.
In apertura, illustrazione di Giulia Serafin per Olio Officina
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Se sei un utente registrato puoi accedere al tuo account cliccando qui
oppure puoi creare un nuovo account cliccando qui

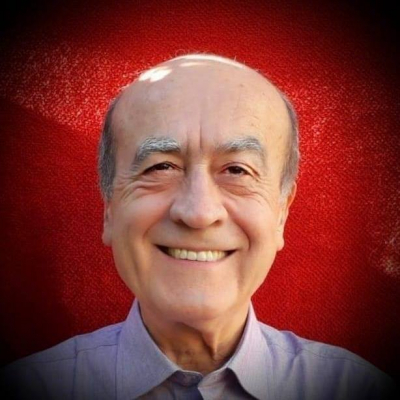
Commenta la notizia
Devi essere connesso per inviare un commento.