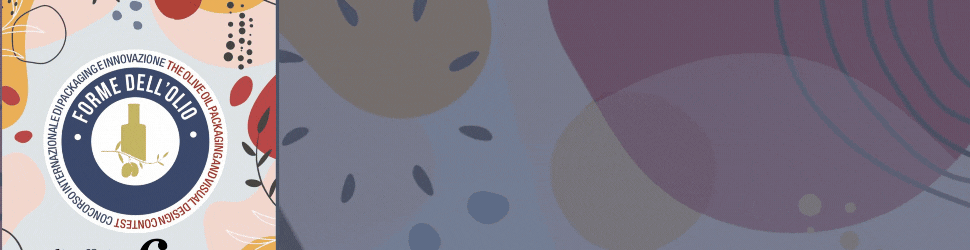Olio Officina Festival
Sensoriale
Olio Officina Festival 2026, 15a edizione
Rho - Milano - Centro Congressi Mantovani Furioli
22 - 24 Gennaio 2026
EDIZIONE 2026 PROGRAMMA MASTERCLASS Diventa partnerTanti gli spunti di riflessione a Olio Officina Festival 2026, il cui tema centrale ruota intorno alla parola “sesnsoriale”. Tante le argomentazioni che si svilupperanno, a [...]
Comunicazione, neuromarketing e cultura digitale per gli oli extra vergini di oliva. Ovvero, come percepire, raccontare, trasmettere e creare valore. Uscirà per le edizioni Olio [...]
A Olio Officina Festival 2026 il cortometraggio di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali, un racconto di memoria e rinascita, dove la fatica del lavoro si trasforma in gioia di [...]
“Con tatto della terra: tra pietre, legno e acqua”. Si intitola così il laboratorio condotto Flavio Lenardon e Samuele Cama. Si tratta di un momento olistico con cui saranno [...]
Dilemmi irrisolti | Perché la sansa non è tanto amata da olivicoltori e frantoiani
La questione è di per sé molto complessa, ma si prova qui a spiegarla in modo facile. Sono state tante le polemiche che si sono lette e ascoltate al riguardo nel corso degli anni. Ciascuno ha espresso la propria opinione, ma in pochi si sono assunti l’impegno di analizzare concretamente tutti gli aspetti problematici per affrontarli in modo sostanziale, con la necessaria lucidità
Esperienze Cose da sapere
Nel mondo dell’olio extra vergine di oliva il tatto è il senso meno raccontato, quando invece è forse il più potente. Toccare non serve solo a riconoscere una forma, ma a valutare [...]
Esperienze Sotto la lente
Tra i personaggi che contribuiscono a dare visibilità e impulso alla “valle dalle molte cantine”, territorio a tutti noto come Valpolicella, c’è senza dubbio Celestino Gaspari. La [...]
Esperienze Economia
Secondo i dati forniti dall'Icqrf, sulla base di quanto riportato nei registri telematici dell'olio, gli operatori del settore risultano pari a circa 20.500, mentre sono 202.920 [...]
Culture Saperi
Il nuovo libro del biotecnologo Andrea Sonnino entra con pervicace lucidità nella grande disputa tra i sostenitori della conservazione della purezza genetica e i promotori della [...]
Esperienze Ambiente
Una indagine che ha analizzato oltre 74mila tesi di dottorato realizzate tra 2008 e 2021 ci offre la prima mappatura completa della produzione dottorale sul clima in Italia. È un [...]
Esperienze Cose da sapere
Il verde brillante, il giallo dorato, le tante sfumature. Ogni olio extra vergine di oliva porta con sé una propria identità cromatica. Il consumatore non vede solo un colore, ma [...]
Esperienze Economia
Per alcuni territori è stata una campagna olearia splendida, premiante per quantità e qualità. Per altre aree non è stata una olivagione semplice da gestire, ma la professionalità [...]
Esperienze Sotto la lente
In Basilicata si trova una delle denominazioni più giovani del panorama enologico nazionale, e per questo motivo ancora poco conosciuta dal grande pubblico, pur racchiudendo un [...]
Esperienze Sotto la lente
È l’uomo che ha cambiato il volto e il destino della Barbera. L’illuminazione a Napa Valley, a seguito dell’incontro con il celebre enologo di origine russa André Tchelistcheff. [...]
Esperienze Ars Olearia
Ora che le Olive Taggiasche liguri hanno conseguito l’attestazione di origine attraverso il riconoscimento ufficiale del marchio Igp, diventa fondamentale valutarne la qualità e [...]
Esperienze Economia
Per farlo occorre dare vita a un network efficace, in grado di rilanciare in modo concreto l’intero comparto. Intervista a Dora Desantis, presidente Fooi, Filiera olivicola [...]
Esperienze Cose da sapere
Perché cedere alle abitudini standardizzate, con cesti natalizi generici? L’olio extra vergine di oliva ha una forza in più che sorprende e cattura: è qualcosa di quotidiano, di [...]